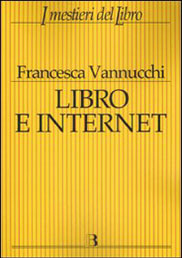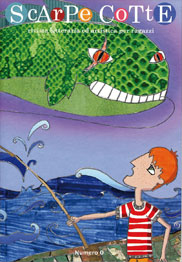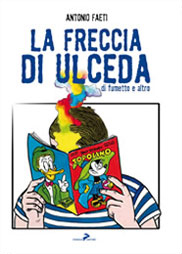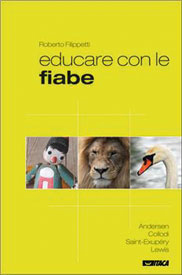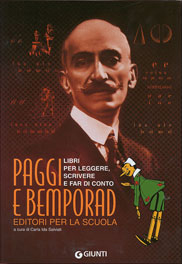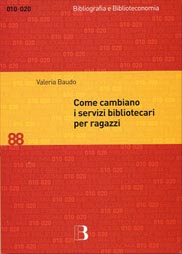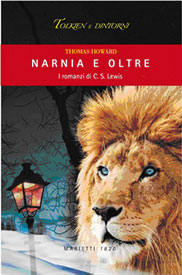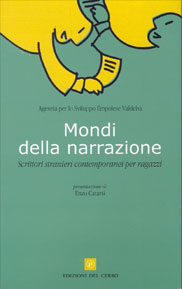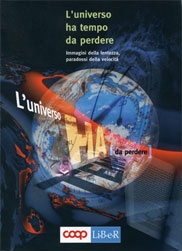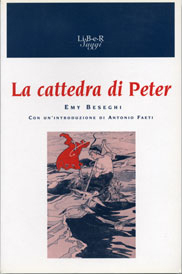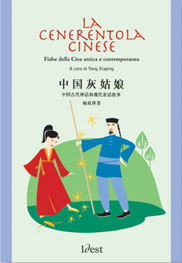Immagini della lentezza, paradossi della velocità
A cura di Vinicio Ongini, Domenico Bartolini, Riccardo Pontegobbi
Campi Bisenzio, Comune di Campi Bisenzio, 1995, 112 p.
Euro 10,33
La collaborazione tra Amministrazione Comunale di Campi Bisenzio, LiBeR e Unicoop Firenze ha dato vita a questa pubblicazione, che raccoglie gli interventi di un convegno tenutosi a Firenze nel marzo 1995 presso il salone Brunelleschi dell'Istituto degli Innocenti, dal titolo "L'universo ha tempo da perdere". Il legame tra lentezza e velocità, e le sue implicazioni su molteplici aspetti della natura e della società (dal rapporto con le scuole, le città e i ragazzi a quello con la dimensione religiosa, o ancora ai tempi di Internet e della TV) è il tema attorno al quale si sviluppano le riflessioni dei relatori, tra i quali figurano Margherita Hack, Giorgio Celli, Antonio Faeti, Roberto Denti.
Chiude il volume la riproduzione di una serie di vignette realizzate "in diretta" durante il convegno da Sergio Staino, che, come avverte la didascalia, "risentono della cronaca e del clima politico di quei giorni". "Stranamente" simili ai giorni nostri.
Dalla fiaba alla TV
Campi Bisenzio, Comune di Campi Bisenzio, 1992, 71 p.
(Quaderni di LiBeR, 2)
Euro 5,16
Il secondo Quaderno di LiBeR raccoglie materiali del Convegno "Bambini e paure: quando dove e perché", organizzato dalla Biblioteca civica Bernardino Partenio di Spilimbergo nel novembre 1990.
L'approccio all'argomento è interdisciplinare: i testi delle relazioni presentate al Convegno sono state, quando necessario, aggiornate dagli autori e offrono un'articolata riflessione critica sul tema delle paure dei bambini a cura di psicologi, esperti del libro per bambini e ragazzi, pedagogisti, massmediologi. La bibliografia che segue gli interventi è aggiornata con le pubblicazioni edite fino al dicembre 1991, e mostra il vero e proprio boom editoriale avuto in quegli anni dal tema delle paure nella letteratura per l'infanzia, ancora oggi fortemente presente nell'immaginario dei bambini
Indice
Marcello Bernardi. I bambini e la paura
Roberto Denti. La paura nelle fiabe di magia
Francesca Lazzarato. "E' per mangiarti meglio, bambina mia"
Donatella Ziliotto. Storie d'ombra
Marina D'Amato. La telepaura
Roberto Farnè. Giochi di paura
Bibliografia:
- Paura, paure
- Mostri
- Streghe
- Fantasmi e vampiri
- Horror
Per acquistare il libro
Emy Beseghi
Saggio introduttivo di Antonio Faeti
Campi Bisenzio, Comune di Campi Bisenzio, 1996
96 p. ; 24 cm (LiBeR/Saggi)
L'autrice oggi insegna Letteratura per l'infanzia all'Università di Bologna, cattedra che nel 1996, anno in cui il libro è uscito, apparteneva ad Antonio Faeti, autore del primo attento intervento, dal titolo "Il giardino e il labirinto".
La domanda centrale attorno alla quale ruotano i saggi contenuti nel libro è "Che cosa è, veramente, una tesi di laurea?": da qui parte un'indagine minuziosa sull'itinerario che vede come protagonista la tesi in letteratura per l'infanzia, disciplina particolare, in un certo senso "anomala", perché il libro per ragazzi è "come Peter Pan, un'opera aperta, un proliferare di sensi nascosti, un testo infinitamente dilatabile".
In appendice al volume è pubblicato l'elenco completo delle tesi in storia della letteratura per l'infanzia presso l'Università di Bologna dal 1982 (anno di istituzione della cattedra) al 1995.
Fiabe della Cina antica e contemporanea
A cura di Yang Xiaping
Illustrazioni di Chiara Donelli-Cornaro
Idest, 2003, 80 p
Testo bilingue italiano-cinese
ISBN 88-87078-29-7 - € 12,00
In un libro bilingue, italiano e cinese, la più antica tra le “cenerentole”: una proposta esclusiva per gli scaffali multiculturali delle biblioteche per ragazzi e scolastiche.
Sono presenti, nelle diverse tradizioni dei popoli del mondo, “cenerentole” protagoniste di fiabe dai tratti comuni: la bella ragazza laboriosa soggiogata da una spietata matrigna e dalla sorellastra, l’incontro con il principe, o il re e, soprattutto, il piccolo paio di scarpe a cui si lega il riconoscimento e il mutare della sorte della giovane eroina. La fiaba qui presentata, in cui agisce un’intelligente e tenera orfana chiamata Ye Xian e che in omaggio alla tradizione è stata intitolata La Cenerentola cinese, è forse la più antica tra quelle conosciute, addirittura di circa 700 anni anteriore alla celebre versione occidentale.
Accompagnano questa suggestiva Cenerentola cinque fiabe della Cina antica e contemporanea che hanno il potere di trascinare il lettore in un’atmosfera magica e di aprirgli le porte di un mondo lontano abitato oltre che da esseri umani buoni e cattivi, da divinità e da mostri, da fieri animali fantastici e da sapienti animali domestici… Mondi così diversi e così uguali si offrono, grazie anche ai testi bilingui in italiano e cinese, a una lettura senza confini.
Enti promotori
Provincia di Prato, Comune di Campi Bisenzio, Quartiere5 di Firenze
La curatrice
Yang Xiaping è nata ad Hangzhou (Cina). Si è laureata in Lettere presso l'Università di Lingue Straniere di Luoyang e diplomata in Lingua rumena presso l'Università di Lingue Straniere di Pechino. Dal 1988 vive in Italia e collabora con enti e istituzioni locali in qualità di mediatrice culturale. Ha collaborato con vari editori ed enti alla redazione di opuscoli e libri a carattere multiculturale. In particolare, nel 2001, è stata autrice del libro Poesie e filastrocche cinesi promosso dal Comune di Campi Bisenzio e edito da Idest