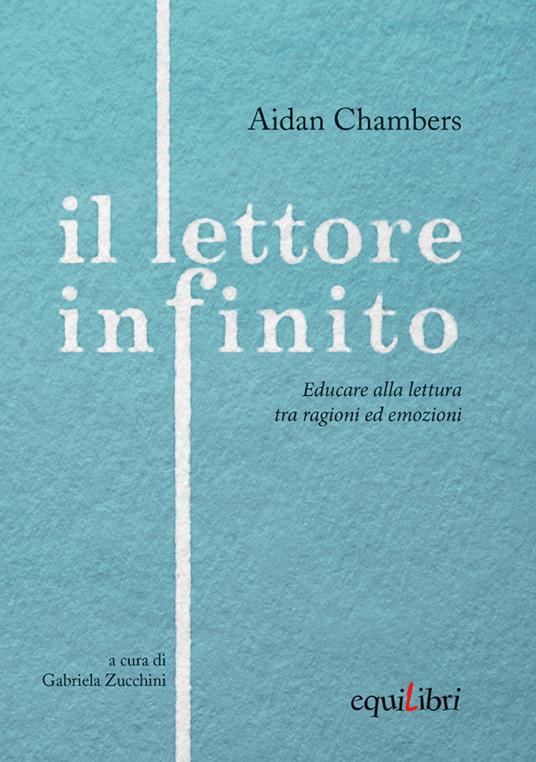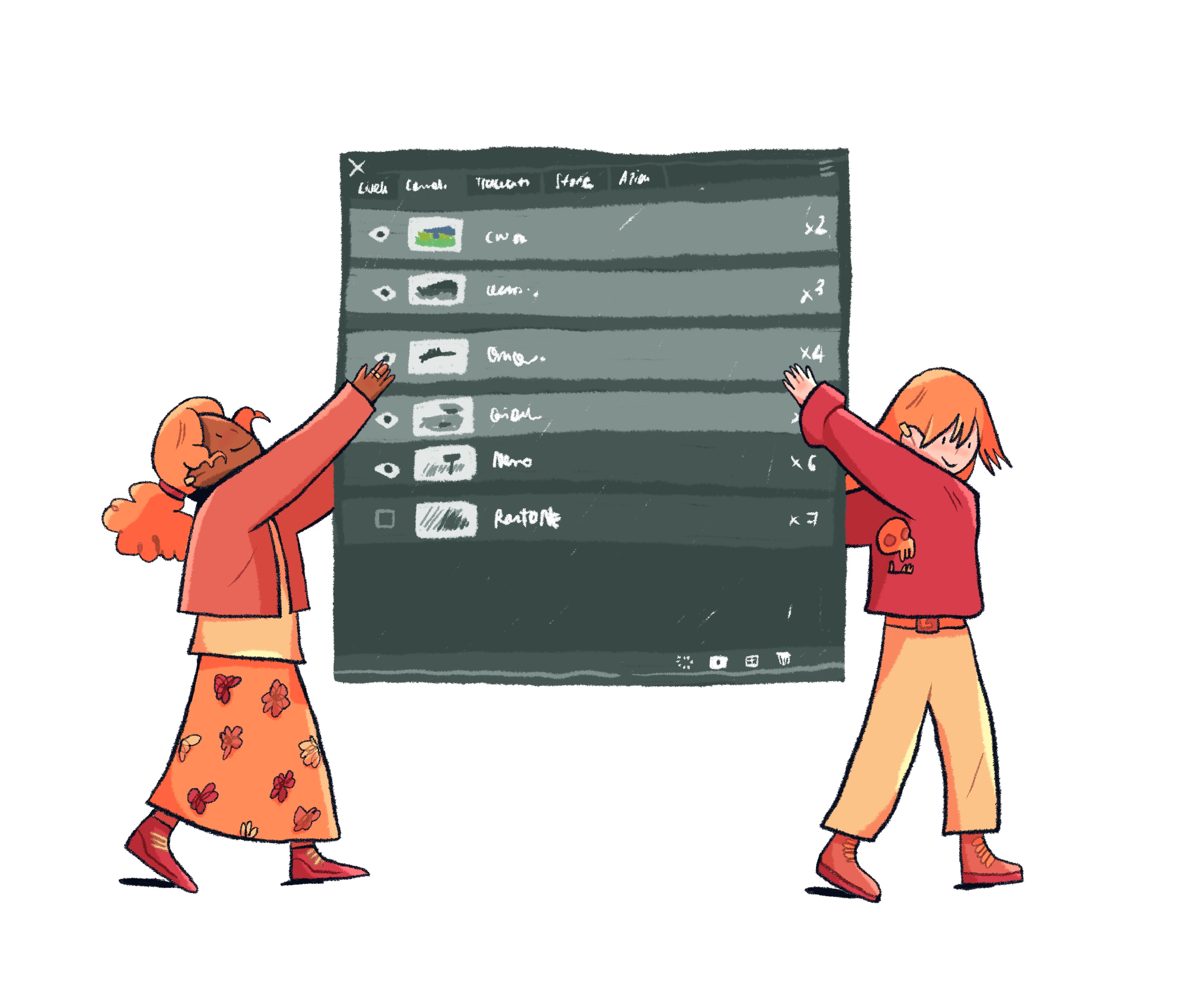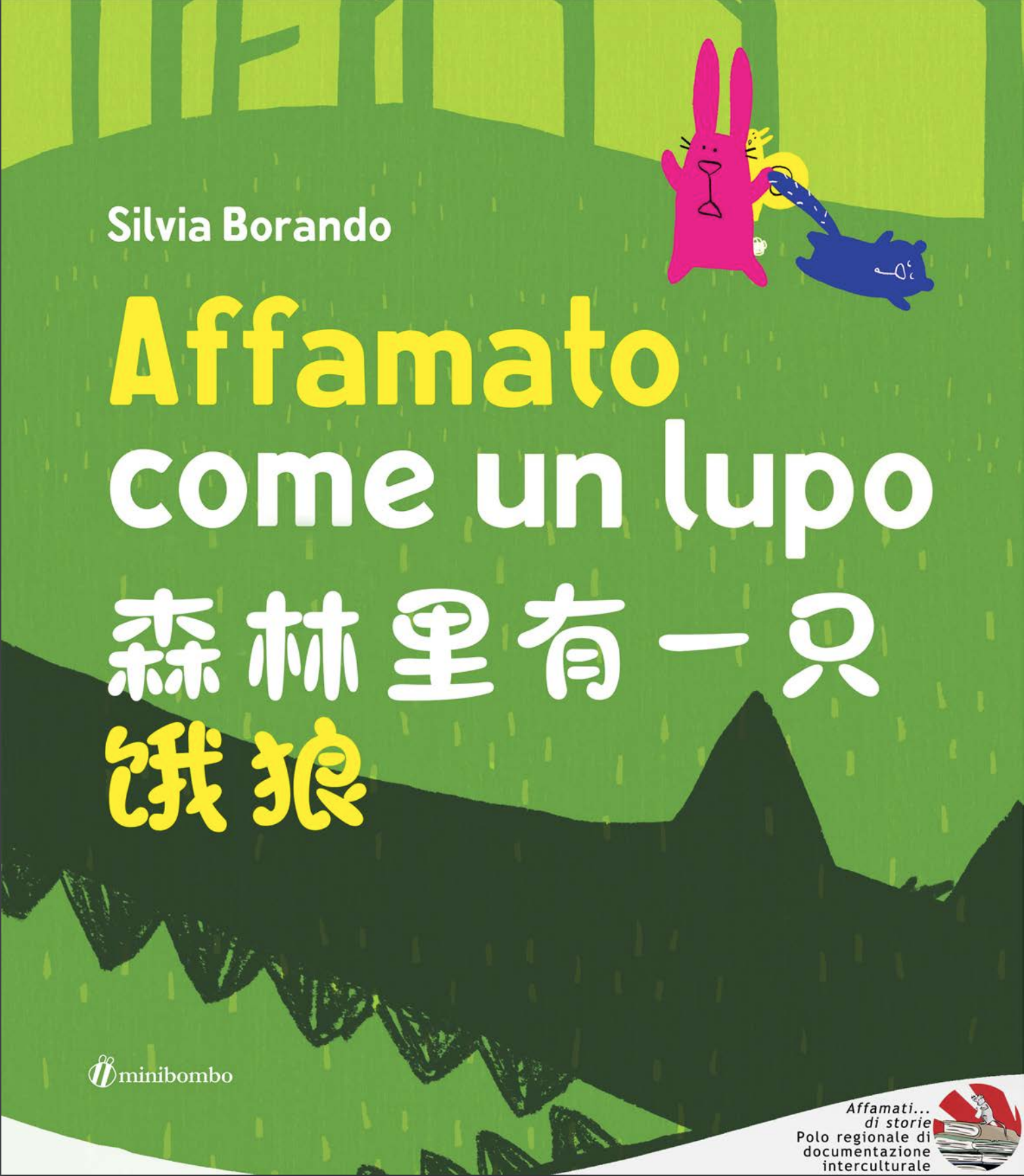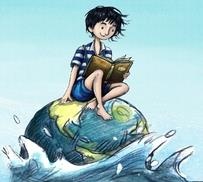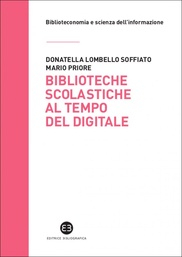Educare lettori e lettrici per la vita
di Manuela Muscetta, Liceo scientifico “Pasquale Stanislao Mancini”, Avellino
"Fabio Geda ci ha svelato che scrive libri per creare ordine dentro di sé, io ho capito che i libri li leggo per fare ordine dentro di me": le riflessioni di Alessia, classe seconda del Liceo scientifico Mancini di Avellino, dopo il Dialogo con l’autore nell’ambito del progetto Vivavoce, dimostrano che la lettura può divenire un aspetto irrinunciabile dell’esistenza, come auspicato da Giusi Marchetta nel suo intervento al convegno di Sondrio del 27 maggio, anche per adolescenti erroneamente ritenuti distratti, indolenti e irrimediabilmente fagocitati dai social media.
Dunque, è davvero possibile conquistare l’interesse dei giovani alla lettura? Anche nei licei, erroneamente ritenuti contesto privilegiato per l’educazione alla lettura, ci troviamo, infatti, di fronte a una vera e propria emergenza: gli studenti leggono sempre meno, mostrano scarsa abitudine alla lettura individuale, scelgono autori e titoli al di fuori del contesto scolastico su spinta di fattori esterni (ad esempio i Book toker), recepiscono poco le proposte di lettura dei docenti, spesso imposte per “obbligo” e inadatte a sollecitare i loro interessi e le loro emozioni. L’esperienza del progetto Vivavoce nei licei di Avellino ha offerto ai docenti, già in cerca di equilibrio tra didattica tradizionale e spinta all’innovazione, una preziosa opportunità di sperimentare strategie efficaci per appassionare i giovani alla lettura. Il percorso di formazione e sperimentazione, centrato su solide premesse pedagogiche e metodologiche e strutturato in forma rigorosamente progressiva, oltre che sui reali interessi dei nostri studenti, è stato accolto come una sfida da parte dei docenti liceali avellinesi, consapevoli dell’urgenza di dedicare spazio e tempo a questa sfida, considerando quest’obiettivo una priorità e rimettendo in discussione il “canone” tradizionale. L’unicità del progetto è costituita dall’aver mostrato agli insegnanti la necessità di lavorare su di sé come lettori per poter divenire catalizzatori di lettura: partendo da una riflessione metacognitiva, l’itinerario ci ha formato sulla letteratura YA, genere letterario ancora poco conosciuto nella scuola secondaria di secondo grado, e ci ha coinvolto nella sperimentazione individuale e come comunità di docenti-lettori della metodologia Tell me di Chambers. Il passaggio successivo della lettura ad alta voce e del laboratorio Tell me con le classi, seguito dai Dialoghi con le autrici e gli autori, ha indotto molti di noi a riflettere sulla centralità della lettura, che non va intesa né gestita come una sovrapposizione alla letteratura del canone consolidato (da intendersi comunque in modo aperto e flessibile, non rigido), poiché abbiamo constatato in modo inequivocabile che la letteratura YA ha una sua evidente valenza letteraria e ha il prezioso merito di illuminare lo sguardo dei nostri adolescenti, che in queste storie riescono a immedesimarsi e a interrogarsi su di sé e sulla vita. La mia sperimentazione dei laboratori Tell me si è svolta in una classe seconda del Liceo scientifico: ascoltando i racconti di Benedetta Bonfiglioli, il romanzo breve di Fabio Geda, fino ai romanzi di Melvin Burgess, le ragazze e i ragazzi hanno percepito il momento della conversazione sui libri come uno spazio di libertà, non vincolato a schede di lettura, verifiche o valutazioni. Le domande aperte su cui è basato il Tell me hanno generato una spontanea propensione a condividere impressioni, connessioni col vissuto personale, emozioni, dimostrando che parlare di libri è parlare di sé. L’incontro con l’autore al termine del laboratorio è stato particolarmente apprezzato dagli studenti di tutte le classi coinvolte, perché l’immersione profonda nelle loro storie ha creato una fortissima attesa e curiosità, convogliate in un forte coinvolgimento emotivo e culturale nel dialogo finale con gli stessi autori. Nodo centrale della piena adesione del progetto ai bisogni del nostro contesto formativo è stata la splendida intesa con le formatrici di Equilibri, Gabriela Zucchini e Alice Torreggiani, e la collaborazione attiva, professionale e motivante con Consiglia Aquino, che con la sua libreria L’angolo delle storie rappresenta un presidio di cultura nella città di Avellino. Avendo apprezzato l’efficacia e la novità del progetto per il rigore, la replicabilità anche su altri autori e altri docenti, la scoperta del mondo letterario, vario e ricchissimo, della letteratura YA per la co-costruzione di significati e la condivisione di esperienze, auspichiamo che l’entusiasmo, lo studio, l’organizzazione e la riflessione metacognitiva, unita alla consapevolezza di far parte di una comunità di pratiche, possano rendere realistico il sogno, ora un po’ più concreto, di educare lettrici e lettori per la vita.
La lettura prende corpo: in classe, a scuola
di Lisa Marra e Sergio D’Onofrio, IPSEOA “Manlio Rossi Doria”, Avellino
In classe
“Allora ragazzi spostiamo i banchi e mettiamo le sedie in cerchio”: la classe accoglie l’invito favorevolmente, perché la disposizione a cerchio vuole dire solo una cosa “Niente lezione!”
L’avvio della lettura è un po’ traballante. Qualche occhiata, qualche risatina. Qualcuno troppo distratto. Poi succede qualcosa. Succede che la storia prende corpo. Succede che ci si accorge che a parlare è un ragazzo. Un ragazzo come loro. Un ragazzo che vive relazioni familiari e amicali non sempre facili, proprio come capita a loro. E poi arriva anche il silenzio. Un silenzio che è concentrazione, voglia di non perdere la traccia delle parole. Dove sta andando il protagonista? Dove stiamo andando noi? Come finirà la storia? Le domande restano sospese nell’aria. E quando finisco la lettura, succede ancora. Silenzio. La storia è dentro di loro, sta fermentando. Apro il cerchio e faccio girare i ragazzi. “Ora ditemi, in una parola, cosa vi è piaciuto e cosa non vi è piaciuto della storia?” Ecco una domanda non ostile, che apre e distende. Inizia la discussione. La classe si anima, prende respiro, prende corpo. Si discute, si riflette sul ruolo dei personaggi, su come hanno agito, sulla giustezza o meno delle loro azioni. È un’analisi in piena regola. Anzi, è più di un’analisi. I ragazzi stanno facendo altro, stanno portando i loro vissuti nell’analisi. Si stanno lasciando andare a piccole confidenze su di sé e su come si sentono, su come loro vivono i rapporti a casa con i genitori, a scuola o con gli amici. Ogni intervento è spontaneo, non c’è una risposta giusta o sbagliata. Non c’è giudizio. Si è finalmente liberi di dire o non dire. Si è finalmente liberi di essere non un voto, ma una persona.
A scuola
Vorrei tanto bandire l’espressione “Corso di aggiornamento”, soprattutto nella scuola. Vorrei sostituirla con “Incontri per condividere, pensare, fare insieme”. Così è stato Vivavoce, un momento molto importante per me per costruire relazioni, per conoscere, spingermi a. Ricordo di essermi iscritto in ritardo, oltre i termini, mosso dalla mia curiosità, io docente di sostegno. L’incontro con Gabriela Zucchini, la conoscenza di Consiglia Aquino, la sorpresa Aidan Chambers durante la prima videoconferenza. E poi letture, tante, personali, condivise con altri insegnanti che hanno partecipato all’esperienza Vivavoce.
Ebbene la lettura ha preso corpo, il mio, scatenando una serie di reazioni a catena.
Settimana dell’accoglienza con le classi prime del mio Istituto Professionale Alberghiero “Manlio Rossi Doria” di Avellino: letture ad alta voce con attività sul testo e riflessioni con i ragazzi. Ed ancora i Tell me con gli studenti della prima D. Il pianto di S., gli abbracci di C., gli occhi desiderosi di ascoltarmi di G., la rabbia di M., il desiderio di tutti gli altri ragazzi di ripetere l’esperienza dopo uno dei racconti di Zucchero e sale di Benedetta Bonfiglioli.
Che dire della settimana dell’inclusione da me organizzata e coordinata: altra reazione a catena. Con il consenso della D.S. Maria Teresa Cipriano, ho incontrato dieci classi della mia scuola. Ho letto ad alta voce per loro, tra sguardi strani e orecchie tese. E durante la stessa settimana, condivisione della “buona pratica” della lettura ad alta voce con insegnanti del mio istituto e di altre scuole della rete d’ambito. Sono qui anche a raccontare della curiosità di alcuni colleghi che mi hanno invitato a leggere, a sperimentare la metodologia Tell me, la potenza dei Silent Book, nelle loro classi. E infine, meravigliosi gli incontri di fine anno per condividere con gli insegnanti della mia scuola quanto appreso durante l’esperienza Vivavoce.
La lettura ha preso corpo, tanti corpi. Bello.