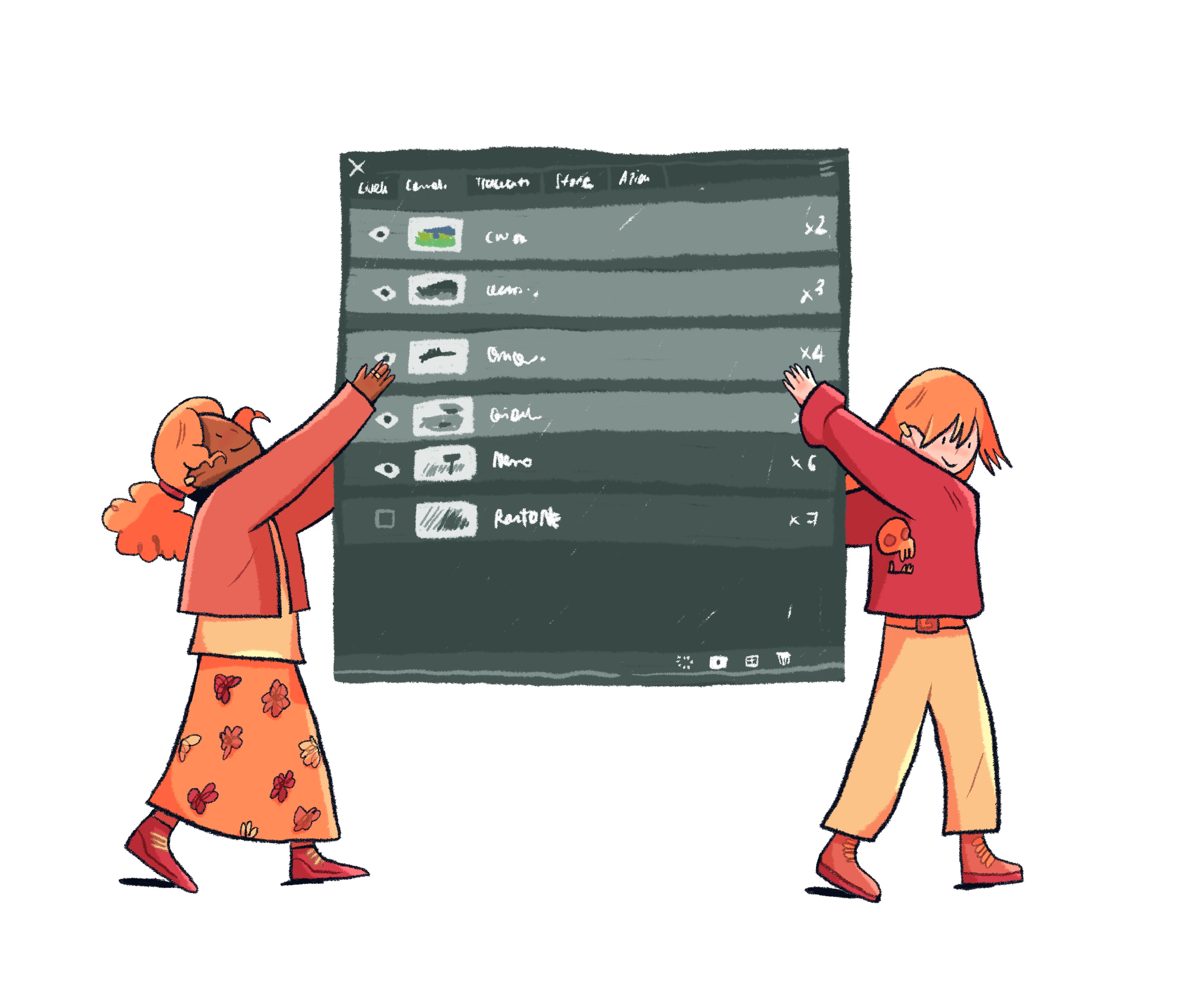Simone Galvanini è un fotolitista: il professionista che, partendo da illustrazioni originali, crea e gestisce i file che vengono usati per la stampa, offset o digitale, e determina così la qualità della stampa e del libro nel suo complesso.
Negli ultimi vent’anni questa professione ha subito una rivoluzione: dalle tecnologie analogiche, basate sulla pellicola fotografica, si è passati a un processo interamente digitalizzato. La sua esperienza in entrambi i campi può aiutarci a capire meglio cosa fanno le macchine, perché lo fanno e come sfruttare le loro potenzialità. Ripercorrendo le fasi di lavorazione di una delle illustrazioni di Irene Penazzi per Poesie della casetta (Topipittori, 2023), abbiamo definito sei punti, utili per chi ha a che fare con le immagini, ma non ha piena consapevolezza dei passaggi che portano alla realizzazione di un libro.
- Valutazione dell’originale
Quando si progetta un libro illustrato, la prima cosa da osservare sono le caratteristiche degli originali.
Si valuta il formato delle illustrazioni in rapporto al formato che avrà il libro, per assegnare la giusta risoluzione all’immagine. Se è lo stesso, la risoluzione ottimale sarà 304,8 dpi, che corrisponde a 120 linee/cm. Se invece si parte da un originale di piccole dimensioni per ingrandirlo, dovremo aumentare la risoluzione. Non sempre a maggiore risoluzione corrisponde migliore qualità. Se l’originale ha delle imperfezioni, sbavature o difetti che vorremmo eliminare, a 300 dpi potrebbero sparire, ma a 1200 dpi le vedremmo benissimo. Oltre al formato, vanno esaminati tecnica e colori. L’illustrazione di Irene è stata fatta su una carta piuttosto spessa, non perfettamente bianca, con matite colorate e pastelli a cera; non tutti i colori dell’illustrazione si possono ottenere in quadricromia. Uno dei verdi, infatti, è molto luminoso e in stampa non renderebbe. Abbiamo quindi deciso di introdurre un colore fuori scala, cioè un Pantone. Vedremo in seguito come gestirlo.
- Acquisizione dell’immagine
Prima di acquisire l’immagine, è necessario che il monitor sia stato tarato, cioè calibrato con lo spettrofotometro, uno strumento che misura e quantifica i colori, valuta i dati cromatici e, soprattutto, è in grado di mantenerne l’uniformità in ogni fase, permettendo di simulare la stampa in modo esatto. Va considerato un dato, in apparenza banale: il monitor ha una luminosità che, per natura, manca al foglio di stampa. Tutto quello che a monitor ci appare chiaro e luminoso, una volta stampato sarà più spento e piatto.
Nel nostro caso, il formato del libro sarebbe stato poco più piccolo dell’originale, quindi la scansione è stata acquisita al 100% del formato a una risoluzione di 304 dpi in RGB. Lo spazio colore RGB sta per Rosso, Giallo, Blu, ovvero i colori primari della sintesi additiva. Un file RGB contiene la sovrapposizione dei tre strati di colore, ognuno codificato su 256 livelli (da 0 a 255: per ottenere il bianco i valori saranno tutti 255, per il nero tutti 0). Si acquisisce l’immagine in RGB perché più versatile, dal momento che i valori verranno compensati a ogni modifica (se, per esempio, aggiungiamo un po’ di blu, toglierà piccole percentuali anche al verde e al magenta). Tenendo i valori standard dello scanner, siamo certi che i minimi non verranno ‘bruciati’ e i massimi non risulteranno ‘chiusi’. Otterremo, in sostanza, una scansione che si potrà lavorare facilmente.
- Perfezionamento della scansione
Acquisita la scansione, si ritaglia, si raddrizza e si confronta minuziosamente con l’originale.
Grazie allo strumento ‘curve’ di Photoshop, possiamo controllare i contrasti dell’immagine. In RGB le curve lavorano in modo opposto alla quadricromia. Nell’angolo in basso a sinistra avremo le zone scure e nell’angolo in alto a destra le alte luci.
- Conversione e correzione colore
Da questo momento in poi, è bene lavorare sul livello duplicato.
Il supporto scelto da Irene è una carta con una bassa percentuale di giallo. Poiché la carta condizionerà la resa dell’illustrazione, schiariamo il fondo del foglio per evitare che tutta l’illustrazione, in stampa, viri verso il giallo. Della scansione in RGB, si lavorano ancora le curve in input e si aggiustano i contrasti.
Una volta applicate le curve e la maschera di contrasto (da Filtro>Maschera di contrasto) – un eccessivo contrasto dei colori rischierebbe di rovinare l’immagine – si passa alla conversione in quadricromia, lo spazio colore CMYK, che sta per Ciano, Magenta, Giallo e Nero. Le prime tre lettere corrispondono ai colori primari della sintesi sottrattiva. Ciano, Magenta e Giallo potrebbero potenzialmente riprodurre tutte le sfumature dal bianco al nero, ma gli inchiostri di stampa non sono abbastanza puri per riuscire a rendere il ‘nero teorico’. Per questo motivo, si aggiunge il nero (K).
Con questi passaggi, si recuperano le sfumature che probabilmente avremo perso pulendo lo sfondo: alzando di pochissimo la percentuale del valore di output, riusciamo a far emergere le zone del disegno che si erano schiarite troppo.
Riguardo ai colori, c’è almeno un tono di verde che è possibile restituire in stampa solo introducendo un Pantone. Data la complessità dell’immagine, si può procedere selezionando con una maschera l’area del verde da assegnare al Pantone. Creato il quinto colore, nel nostro caso Pantone 802 U, selezioniamo il canale del Ciano (nel verde lavorano, infatti, ciano e giallo) e lo incolliamo nel canale Pantone. Infine, torniamo ai canali CMYK per abbassare i rispettivi valori di ciano e giallo, lasciandoli lavorare con percentuali minime (10-15%): faranno da base al livello del Pantone, rinforzandolo.
- Profilo colore
Per procedere, è fondamentale avere deciso su quale supporto stampare l’illustrazione. In base a questa scelta, all’immagine andrà ‘agganciato’ il profilo colore adeguato perché possa rendere bene in stampa. Se si sceglie una carta patinata, l’illustrazione sarà salvata con il profilo PSO Coated v3, che fa apparire i colori luminosi sulla carta lucida; se si stampa su carta usomano, il profilo più aggiornato è PSO Uncoated v3 (FOGRA 52); si avrà meno luminosità e meno colore perché la carta assorbe di più gli inchiostri. Tutti i profili colore vengono forniti dalle case madri, anche se, per lavori particolari o stampe di pregio, è possibile crearne uno ad hoc. La conversione non deve mai essere fatta da Immagine>Metodo>CMYK perché è un passaggio che non ‘aggancerebbe’ il profilo all’immagine. L’azione corretta è, invece, Modifica>Converti in profilo>Profilo per usomano>PSO Uncoated v3. Prima di procedere, la scansione lavorata andrà salvata in tiff, un formato che consente di mantenere tutti i dati. La prova di stampa rivelerà se avremo fatto un buon lavoro di prestampa.
- Prova di stampa certificata
È tutto pronto per la prova di stampa certificata. Significa che i valori che la stampante professionale rileva, per mezzo dello spettrofotometro presente, non dovranno mai superare gli standard forniti da FOGRA su scala mondiale.
Quando si controlla una scansione, è fondamentale che la luce dell’ambiente sia a 5000° kelvin, una luce neutra che permette all’occhio umano di percepire l’immagine reale, senza variazioni cromatiche.
La prova certificata e, prima ancora, il buon lavoro di prestampa e del fotolitista, ci faranno arrivare preparati alla stampa, perché i colori sono stati calibrati e la simulazione vicinissima alla stampa in offset. Ecco il risultato del lavoro fatto (sopra, la prova certificata, sotto, il libro stampato):
In conclusione, tutto questo tecnicismo per porre l’attenzione su due aspetti: attraverso un esempio legato a una sola fase di un processo produttivo ben più articolato, mi interessava dare l’idea della complessità e della quantità di lavoro necessarie per ottenere un libro di qualità; e, proprio per la complessità del processo, sottolineare i benefici che si traggono in termini qualitativi se ci si affida a figure di alta professionalità. Uno sguardo attento anche a questi punti potrà, infatti, permetterci di valutare con più completezza la qualità di un libro.
Anna Martinucci (da LiBeR 142)
Ill. iniziale di Gaia Sartorato di Mimaster Illustrazione per LiBeR 142.