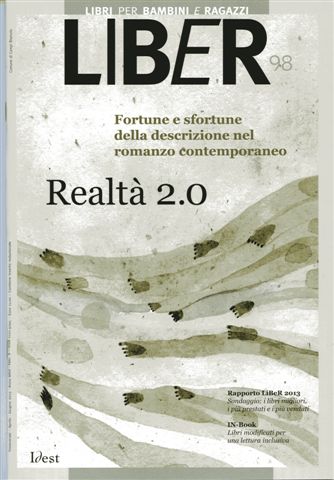[Aprile – Giugno 2013]
Sommario
Sketch
Tutto è fiaba, Federico Maggioni (p. 5)
La descrizione narrativa
Realismo letterario: un necrologio, Stefano Calabrese (p. 18-21)
Un passato glorioso, Federica Fioroni (p. 22-24)
Il motore della narrazione, Eleonora Brandigi (p. 24)
Finzionale vs reale, Sara Uboldi (p. 25-27)
Descrizione e albi illustrati, Eleonora Brandigi (p. 26-27)
Illustrazioni di Milena Cavallo
Rapporto LiBeR 2013 – Prima parte: i sondaggi di LiBeR
La seconda volta di Kujier, Benedetta Masi (p. 28-31)
Guus Kujier, poeta dell’infanzia, Gabriela Zucchini (p. 30)
I commenti degli esperti, Ermanno Detti, Carla Poesio, Beniamino Sidoti, Rosella Picech, Fernando Rotondo, Anna Parola, Teresa Buongiorno, Pino Boero, Walter Fochesato (p. 31-33)
E lo chiamano Schiappa!, Alessandra Pecchioli e Elena Tonini (p. 34-35)
Premio Nati per Leggere
A proposito di famiglia, Giovanni Alterini (p. 38-39)
Bebè, bimbi e lettura
Piccoli ma complessi, Giovanna Malgaroli (p. 40-41)
IN-Book
Tutti in biblioteca con gli IN-Book, Francesca Pongetti (p. 42-45)
Libri in simboli (p. 43)
Comunicare con gli IN-Book, Antonella Costantino (p. 46-47)
Una voce tra le famiglie, Sauro Filippeschi (p. 47)
Leggere, scoprire e condividere, Roberta Annibali e Anna Ficcadenti (p. 48-49)
Servizi per utenze speciali, Laura Beretta (p. 49)
Al passo con la lettura agevolata, Silvia D’Ambrosio (p. 50-52)
Libri senza barriere, a cura di Biblioteca di Verdello e Azienda ospedaliera di Treviglio (p. 53-54)
La biblioteca diventa speciale, Francesca Pongetti (p. 55-57)
Così lo leggo anch’io!, Fausto Galbiati e Alessia Destefani (p. 56-57)
Media Kids
Volano parole tra libro e display, Maurizio Caminito (p. 58-59)
Un museo scientifico in tasca (p. 59)
Lectures
Scrittura e pregiudizio, Guido Sgardoli (p. 60-64)
Ceppo Ragazzi, Paolo Fabrizio Iacuzzi (p. 61)
Autori: Elsa Morante
Santi, Sultani e Gran Capitani, Stefania Fabri (p. 65-67)
Dossier Segnali di lettura
Una storia vera e altre verosimili, Selene Ballerini (p. 68-69)
C’era una volta una sedia blu…, Laura Anfuso (p. 70-71)
Materia Grigia (p. 72-73)
Rubriche
Rubabandiera
In equilibrio tra Paidia e Ludus, Roberto Farnè (p. 74-75)
La cattedra di Peter
Seguendo le briciole… fin dentro la tv, Emma Beseghi (p. 76-77)
La cassetta degli attrezzi
I migliori saggi sui comics, Giulio C. Cuccolini (p. 78-79)
Copertina
L’illustrazione di copertina è di Milena Cavallo, primo premio Tapirulan 2013
Inserto redazionale – Schede Novità
La bibliografia del libro per bambini e ragazzi, con le segnalazioni di 569 novità.
Per acquistare LiBeR
Estratti
La descrizione narrativa
Stefano Calabrese (Realismo letterario: un necrologio: “La descrizione dettagliata di uno scenario (detta descrizione bottom-up in quanto il lettore deve ricostruire un insieme da una pluralità di dettagli), che lascia poco spazio all'immaginazione del destinatario, in quanto si occupa di realtà non ancora del tutto a lui familiari e predominante in tutta la modernità, quando il senso di "realtà" va costruito e continuamente rinegoziato. La descrizione frammentaria e metonimica di uno scenario (detta descrizione top-down in quanto il lettore utilizza i pochi indizi fornitigli per selezionare un intero quadro di riferimento), che offre ampi margini di libertà cognitiva al destinatario in quanto non importa se sia reale o finzionale, come accade nella letteratura postmoderna e nei processi estetici che contraddistinguono l'epoca del digitale, dove l'idea stessa di realtà è divenuta obsoleta. Nel primo caso la descrizione è nelle mani dell'emittente e ha l'aspetto di un quadro fiammingo; nel secondo caso la descrizione è nelle mani del destinatario e ha l'aspetto di un quadro di Pollock, astratto e sintetizzante, che privilegia non tanto gli aspetti analogico-figurativi delle immagini (il fatto a esempio che la fotografia di una sedia assomigli a una sedia reale) ma le componenti plastiche delle immagini (il colore, la posizione nello spazio, l'identità visiva dei contorni, lineari o curvilinei). È proprio questa forma di descrizione top-down che oggi sta trionfando in letteratura”).
Federica Fioroni (Un passato glorioso: “Dal punto di vista della teoria della narrazione risulta altrettanto proficua la distinzione tra descrizione autoriale e descrizione figurale: la prima è fornita da un narratore estraneo alla storia e si registra tipicamente nel romanzo ottocentesco di stampo realista, mentre la seconda viene presentata da un personaggio focalizzatore, secondo una prassi più frequente a partire dal modernismo, anche se ne faceva già largo uso Flaubert. Ma qual è stata la tendenza della letteratura per l'infanzia in relazione al dispositivo mimetico della descrizione? Nei testi children-oriented un narratore adulto solitamente si focalizzava su un personaggio giovane, creando l'illusione che gli eventi fossero osservati attraverso occhi infantili. È altrettanto vero che tra narratore e personaggio si interponeva una distanza cognitiva e morale, per cui la prospettiva era in qualche modo divisa in due, e un secondo osservatore (il narratore) rendeva visibile – talora in modo ironico – ciò che il primo osservatore (il protagonista) non era in grado di scorgere; colui che raccontava si disponeva insomma a regredire al livello mentale del suo eroe, in quanto ne aveva avuto esperienza diretta, ma l'operazione letteraria gli permetteva di utilizzare il patrimonio di conoscenze accumulate, traendo occasione di insegnamento dalle vicende dei personaggi. Per una struttura narrativa di questo tipo, la soluzione migliore appare l'adozione di una focalizzazione zero con un narratore in terza persona di tipo onnisciente, il quale osserva dall'esterno e dall'alto i fatti ed è in grado di muoversi liberamente nel tempo e nello spazio, oltre a conoscere i pensieri e i sentimenti dei personaggi”).
Sara Uboldi (Finzionale vs reale: “Il punto di partenza per analizzare il problema del transfert di informazioni dal mondo finzionale al mondo reale è senz’altro il paradigma del problem-solving, poiché comporta il riconoscimento di una struttura relazionale simile nelle due diverse dimensioni: al contrario di quanto sosteneva Jean Piaget – per il quale fino ai nove-dieci anni i bambini non riuscirebbero a risolvere problemi analogici – un importante test ha invece mostrato come sotto lo stimolo di una narrazione, già a quattro anni il 58% dei bambini coinvolti nell’esperimento sia stato in grado di trasferire la soluzione analogica desunta dalla narrazione di finzione a un contesto reale. In particolare, uno studio recente ha distinto tale narrazione in un racconto fantasy e in un Bildungsroman per ragazzi attraverso tre test che hanno impegnato i bambini dai tre anni e mezzo ai sei, mettendo in luce una loro minore propensione a trasferire le soluzioni dal racconto fantasy alla realtà rispetto al Bildungsroman”).
Eleonora Brandigi (Descrizione e albi illustrati: “La diffusione del picturebook, del graphic novel e di altre forme di narrazione per immagini e word-less – talvolta rubricate sotto la voce "fumetti", come L’approdo di Shaun Tan – è la causa principale del declino della descrizione o ne è una conseguenza? Se intendiamo la descrizione come quella tipologia di testo che, pur integrandosi con il contesto narrativo, definisce gli spazi, i personaggi e gli eventi di una storia, il linguaggio analogico delle immagini può rendere del tutto inutili le descrizioni, soprattutto là dove – come nell'albo illustrato e nel "fumetto" – non si attua una semplice giustapposizione di parole e immagini, ma prende vita un linguaggio “polifonico” cui partecipano le informazioni narrative, tematiche, emotive e referenziali. Per la complessità e il risultato ottenuto in termini di effetto di realtà si può forse affermare che, da questo punto di vista, la diffusione del picturebook toglie fisicamente spazio alla descrizione come produttore di realtà”).
Nello stesso numero: Rapporto LiBeR 2013 – Prima parte
Domenico Bartolini e Riccardo Pontegobbi (“Nel Rapporto sull’editoria per ragazzi, i sondaggi di LiBeR sulle preferenze di lettura del 2012: i migliori libri scelti dagli esperti, i più prestati in biblioteca e i più venduti in libreria. Collaborazione di Benedetta Masi, Alessandra Pecchioli, Elena Tonini).
E ancora:
Premio Nati per Leggere
Giovanni Alterini (A proposito di famiglia: Le famiglie raccontate dai libri per piccoli lettori, proposti nella sezione “Crescere con i libri” alla terza edizione del Premio NPL).
Bebè, bimbi e lettori
Giovanna Malgaroli (Piccoli ma complessi: “L’articolo intende considerare i meccanismi della distribuzione libraria con riferimento ai libri per bambini in età prescolare, dal punto di vista dei potenziali lettori (i bambini e gli adulti che li accompagnano nella scoperta dei libri e nell'esperienza di lettura), con particolare riguardo per i piccoli editori i quali investono in una produzione che mette al centro innovazione, qualità e durata”).
Inoltre:
IN-Book
Francesca Pongetti (Tutti in biblioteca con gli IN-Book!: “Lo scorso 26 ottobre 2012 si è svolto presso la Biblioteca del comune di Senigallia (AN) il primo Forum regionale dal titolo “L’esperienza dei libri in simboli, gli IN-Book”. Il convegno si poneva come obiettivo di fornire una panoramica delle azioni sul tema dei libri su misura, in simboli e degli IN-Book, per l’intervento precoce ed inclusivo, indirizzato ai bimbi “speciali” e non, sin dalla scuola dell’infanzia, dove si attiva tra pari l’integrazione di gruppo di chi presenta problemi di comunicazione, relazione, difficoltà di linguaggio o è semplicemente di etnia diversa. Un IN-Book è fondamentalmente un libro “tradotto” in immagini; esso, infatti, nasce come libro creato su misura del bambino, personale; può essere anche modificato,; egli ne è il destinatario ma subito diventa, oltre che un facilitatore comunicativo per soggetti con disabilità di comunicazione, anche uno strumento catalizzante per la socializzazione e l’inclusione sociale”).
Antonella Costantino (Comunicare con gli IN-Book: “La Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA) è ogni comunicazione che sostituisce o aumenta il linguaggio verbale, ed è un area della pratica clinica che cerca di compensare la disabilità temporanea o permanente di individui con bisogni comunicativi complessi (ASHA, 2005). Si tratta quindi di una modalità di intervento e non semplicemente di una tecnica riabilitativa, e deve poter essere presente in tutti i contesti di vita perché abbiamo bisogno di comunicare in ogni momento e luogo della nostra giornata. Potremmo dire che un sistema di CAA è una specie di “traduttore immediato continuo” tra il sistema di comunicazione dell’altro ed il nostro. I simboli sono uno degli elementi fondamentali, rappresentano una vera e propria seconda lingua visiva che affianca quella uditiva. Sono sempre composti da un’immagine grafica, dalla parola alfabetica scritta in alto, da un sottile bordo che tiene insieme le due. La persona che usa la CAA riconosce l’immagine, il partner comunicativo la parola. Possono anche essere usati strumenti digitali programmati per “prestare” la voce quando necessario, o tecnologie informatiche e strumenti computerizzati appositamente adattati fino ad arrivare all’uso del controllo di sguardo, o modalità che consentano di leggere o scrivere anche a coloro che non sono in grado di usare l’alfabeto o la penna”).
Sauro Filippeschi (Una voce tra le famiglie: “Il livello di applicazione del percorso di CA per i bambini inseriti nel progetto dell’Associazione nazionale di volontariato Sindrome Cornelia De Lange Onlus, è ovviamente diverso, così come diversi sono gli approcci delle famiglie, i contesti ambientali, gli ausili degli operatori sanitari e i contributi del sistema scuola. Pur rappresentando le famiglie di bambini della CDL è ipotizzabile che, in questo consesso, possiamo rappresentare tutte le famiglie di bambini disabili in generale. I problemi incontrati dalle famiglie con bambini con ritardo mentale, con spettro autistico, con disturbi caratteriali o semplicemente con disturbi specifici dell’apprendimento, non sono così diversi dalle problematiche che hanno incontrato le famiglie di Giorgia, di Maria, di Laerte, di Vitttorio o di Marco. Per ognuna di loro c’è il problema di scrivere, comporre, redigere, stampare e leggere gli In-Books per tentare di ottenere i progressi auspicati”).
Roberta Annibali e Anna Ficcadenti (Leggere, scoprire e condividere: “Oltre che all’interno del contesto familiare, la lettura deve essere promossa anche nell’ambiente ospedaliero. Costretto ad affrontare situazioni complesse e delicate, dal dolore fisico al trauma psicologico del distacco familiare, dalle paure personali alle difficoltà oggettive, il bambino malato viene spesso a trovarsi in un ambiente a misura d’adulto, attento ai bisogni pratici ma non sempre preparato a gestire quelli psicologici ed emotivi. L’obiettivo della lettura in questo caso può diventare quello di intrattenere i bambini con un’attività che ne stimoli la fantasia facendoli distrarre dal contesto in cui vivono, sensibilizzare le famiglie e gli operatori sulle potenzialità della lettura ad alta voce in età prescolare in termini di sviluppo psichico, affettivo e relazionale e contribuire così all’umanizzazione delle strutture ospedaliere”).
Laura Beretta (Servizi per utenze speciali: La voce delle biblioteche: il lavoro del gruppo di studio del’AIB per tutti coloro che hanno difficoltà di accesso al testo scritto e al libro cartaceo).
Silvia D’Ambrosio (Al passo con la lettura agevolata: “L’epoca delle prime esperienze pionieristiche di pochissime isolate e un po’ solitarie biblioteche è giunta quindi al termine. Dalla biblioteca singola si sta arrivando alla creazione di più poli in ogni territorio laddove i sistemi siano molto grandi, oppure si punta a sperimentare un’economia di scala, mettendo insieme le forze organizzative, economiche, l’esperienza, le risorse, la competenza di ogni biblioteca e sistema. Parliamo quindi di sezioni con marchio di qualità non solo per la presenza di libri in simboli con immagini adeguate, ma anche di altre tipologie di libri utili a diversi tipi di utenza. Siamo consapevoli che servirebbe ci fossero più biblioteche a produrli e che ci fosse una diffusione in tutte le zone di Italia: riteniamo però che la base di tale progetto sia la capacità dei bibliotecari di ascoltare il loro territorio e segnalare la reperibilità di questi libri, supportando gli utenti a prenderli in prestito attraverso il prestito interbibliotecario nazionale quando sia possibile. Esistono operativamente ancora molti problemi aperti. Come fare la supervisione dei libri? con quali competenze? da parte di chi? come mettersi in rete, con che risorse? chi è in grado di tenere le fila e di aiutare le biblioteche a iniziare e a crescere? come gli editori potranno dar una mano? troveremo libri in simboli editi? i simboli saranno sempre .gratuiti anche per le biblioteche? si passerà definitivamente tutti al WLS? come raggiungere tutte le famiglie?”).
Biblioteca di Verdello (Libri senza barriere: “Di fondamentale importanza è sembrato comunque fornire la biblioteca di un’ampia gamma di titoli per permettere ai genitori di bambini con esigenze speciali di poter scegliere libri adatti senza dover peregrinare per librerie e biblioteche. I genitori dei bambini con disabilità potevano così soddisfare la necessità di un’esperienza quotidiana come la lettura e trovare un luogo di condivisione delle esigenze del loro e di altri bambini (non è solo il mio bambino ad avere bisogno di questo…). Rispetto al tipo di utenza a cui il libro poteva dare risposta, la comunità locale si interrogava e ci interrogava sull’opportunità di tenere in considerazione non solo disabilità gravi e complesse, ma anche difficoltà più specifiche, come il disturbo degli apprendimenti, o maggiormente legate alla sfera emotiva, in modo da poter fare i conti con situazioni personali particolari (malattie, lutti, eventi traumatici in generale).La fatica fatta per individuare un gruppo di libri e di materiali informativi sufficientemente esemplificativi è però stata molto utile, perché oggi sta emergendo la richiesta di utilizzare quanto già fatto come cuore di progetto esportabile in altre biblioteche comunali, a cui affiancare possibili riedizioni locali del laboratorio libri modificati. Dall’avvio del progetto “La biblioteca di tutti” all’inaugurazione della prima sezione di biblioteca dedicata ai libri modificati sono passati 3 anni, necessari alla modulazione “su misura” e a modificare il contesto, oltre che i libri”).
Francesca Pongetti (La biblioteca diventa speciale: “Nel centro Benedetta D’Intino, si è compreso quanto sia importante l’atto del leggere per i bambini sin dai primi mesi di vita e che, diversamente, quelli che chiamiamo “speciali” non hanno potuto accostarsi e godere di questa attività che al tempo stesso è anche un piacere. Si tratta di passaggi fondamentali, sia da un punto di vista cognitivo che relazionale e affettivo. I libri solitamente propongono una struttura linguistica e un vocabolario più ricchi rispetto al parlato della quotidianità, che ampliano e nutrono il bagaglio di esperienze ed emozioni del bambino. Molti sono i progetti a sostegno dello sviluppo sia cognitivo-linguistico che emozionale, come il progetto Nati per Leggere. Tutto ciò, purtroppo, per questi bambini affetti da disabilità plurime rimane ostico, date le loro difficoltà motorie e di comunicazione espressiva e ricettiva. Ecco quindi una biblioteca speciale per bambini e bambine con difficoltà motorie e/o della comunicazione per: sostenere la lettura come momento importante di relazione e comunicazione; favorire precocemente nei bambini con “bisogni speciali” il piacere e l’interesse per i libri e la lettura; sostenere l’accesso alla letto-scrittura attraverso l’esposizione precoce alla lingua scritta”).
Fausto Galbiati e Alessia Destefani (Così lo leggo anch’io!: Spazi e strumenti di lettura facilitata nelle biblioteche del vimercatese e del trezzese)
Inoltre:
Maurizio Caminito (Volano parole tra libro e display: “Spesso per partito preso, o per convinzione o forse per pigrizia si tende a presentare il mondo del libro e quello della realtà digitale come due dimensioni in opposizione. Si tratterebbe di due mondi sempre più lontani l’uno dall’altro e, soprattutto, il primo infinitamente migliore (o peggiore) del secondo. Per fortuna chi i libri (cartacei o digitali) li produce ha un atteggiamento più laico. Chi ha detto, infatti, che un libro e un’App non possano avere un obiettivo comune, quello, per esempio, di far innamorare alla lettura o alla scrittura un bambino e che non possano cooperare per raggiungere tale obiettivo?”).
Guido Sgardoli (Scrittura e pregiudizio: “Ai ragazzi che incontro nelle scuole o nelle biblioteche, pongo spesso questa serie di domande: ‘Pensate che un ragazzo o una ragazza che soffre a causa di un’amicizia tradita, soffrirà di più o di meno rispetto a un ragazzo o una ragazza che ha subito lo stesso tradimento cento o mille anni fa o a chi lo subirà tra cento o mille anni?’; ‘Pensate che un grande amore possa essere più grande o meno grande a seconda che esso viva e si consumi tra cento o mille anni o che sia vissuto e si sia consumato mille anni fa?’; ‘Pensate che sentirsi soli oggi o fra mille anni, valga più della solitudine provata da un uomo o da una donna mille anni fa? E che questo sentire sia diverso a seconda che si consideri un adulto, un bambino, una ragazza o una vecchia?’. La risposta, l’unica, è invariabilmente “no”. Cambia ciò che ci circonda, non quello che abbiamo dentro. E anche se qualcosa riesce a modificarci, lo fa solo in superficie, non laggiù, dove stanno le Vecchie Verità, che valgono per l’intero universo degli Uomini”).
Stefania Fabri (Santi, Sultani e Gran Capitani: “Elsa Morante ha dimostrato come scrittrice verso l’infanzia e l’adolescenza un suo originale e straordinario impegno. In modo particolare ne L’isola di Arturo e ne Il mondo salvato dai ragazzini, ma in realtà in tutta la sua opera, è costante il rimarcare il valore dell’infanzia: l’ottimismo, l’esuberanza, il voler credere. Per Arturo la realtà è teatro, avventura, favola, mischiati però a oscuri presentimenti di tragedia, di sordidezza, di caduta nella banalità a causa degli intrighi e delle menzogne degli adulti. In tutta l’opera di questa scrittrice così innovativa c’è la percezione della superiorità dei miti infantili anche se irreali, come altri grandi autori hanno rimarcato (penso a Twain, a Stevenson ma anche al nostro Pinin Carpi) e la valorizzazione di una dimensione, spesso contaminata dagli adulti e da loro tradita. Inoltre il linguaggio di Elsa Morante nei suoi romanzi si è avvalso in maniera straordinaria della sua esperienza come scrittrice per bambini: un linguaggio composito volutamente, dove la predilezione per la metafora è funzionale a un processo di mitizzazione di alcuni momenti topici della narrazione, dove il sogno, il racconto all’interno del racconto, la citazione, i moduli atemporali della favola entrano a comporre l’assoluta originalità e qualità della sua scrittura. Perciò scoprire che Elsa è stata una scrittrice fin da bambina, dall’età di cinque anni, è una scoperta esaltante”).
Rubriche:
Ruba bandiera: il gioco e l’immaginario infantile a cura di Roberto Farnè (In equilibrio tra Paidia e Ludus: “Chi si occupa di studiare il gioco costruisce nel tempo una sorta di mappa bibliografica i cui territori sono rappresentati da autori e titoli di libri, distanti tra loro o vicini a seconda del tempo, delle caratteristiche scientifiche e culturali, delle correnti di pensiero. Alcuni di questi territori vengono attraversati più di altri, sono come dei “passaggi obbligati”, uno di questi è certamente I giochi e gli uomini. La maschera e la vertigine, di Roger Caillois: un libro che segna un “territorio” del gioco nel quale inevitabilmente si arriva e dal quale si parte più volte nella veste di esploratori (studiosi) del gioco, poiché le sue pagine continuano ad offrire suggestioni nuove. Come quando si torna, a distanza di tempo, a visitare un luogo conosciuto e si scoprono angoli, dettagli, prospettive che forse avevamo già visto la prima volta, ma che ora ri-scopriamo; forse anche perché il nostro sguardo è cambiato. Il libro di Caillois è di quelli che generano questo effetto, non solo per i suoi contenuti, che tali sono e restano, ma anche perché le sue analisi costituiscono delle chiavi di lettura sul fenomeno gioco che osserviamo nella società e nelle sue forme culturali, di cui è un formidabile evidenziatore. E poiché tale fenomeno cambia nel tempo, anche le tesi di Caillois vengono in qualche modo messe alla prova del tempo e del cambiamento”).
La cattedra di Peter: le tesi originali della cattedra di Letteratura per l’infanzia dell’Università di Bologna a cura di Emy Beseghi (Seguendo le briciole… fin dentro la tv (tesi di Annalisa Zoffoli): “Si dice che l’uomo pensi al suo presente attraverso il futuro. Il futuro dell’uomo è l’infanzia di oggi. Occuparsi dell’infanzia e dell’immaginario che a essa appartiene, si traduce nel prendere come punto di partenza proprio lo sguardo bambino nel suo essere specchio che riflette e restituisce l’immagine di essa generata dalla società dell’oggi, e, al tempo stesso, capace di stupore, di cogliere il filo rosso che tesse legami tra le cose, popolando il mondo di avventure pronte a iniziare. L’infanzia come detentrice del potere più forte di tutti: l’immaginario, forza demiurgica, creatrice di mondi, di futuro. Voler affrontare il tema dell’immaginario infantile, in quanto serbatoio di possibili, e quindi meccanismo propulsore di cambiamento, richiede, ora più che mai, di mettersi in cerca delle storie e del “dove” esse siano precipitate, di avventurarsi per la molteplice varietà di luoghi creatori di Altrove in cui germogliano eroi ed eroine, vecchi e nuovi”).
La cassetta degli attrezzi: gli strumenti di lavoro per gli operatori del settore (Giulio C. Cuccolini – I migliori saggi sui comics).
Comunicati stampa
Comunicato n. 1