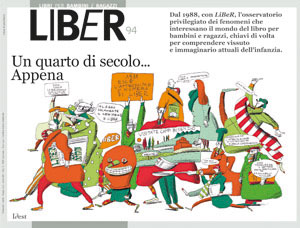Sommario
25 anni di LiBeR
Crossover
Uno storyworld globale, Stefano Calabrese (p. 20-23)
Crossover allo staccio (p. 22)
L’epoca del multitasking, Giorgio Triani (p. 24-29)
Le mille strade di Mediopolis, intervista a Michele Rak (p. 26-29)
Le tracce dell’ipotesto, Carla Poesio (p. 30-35)
“Scavallare” i target, intervista a Sandrone Dazieri (p. 32-35)
Figure di confine, Angela Dal Gobbo (p. 36-39)
Storie di attraversamenti, Davide Morosinotto (p. 30-35)
Rapporto LiBeR 2012 – Prima parte
Tra scienza e avventura, Benedetta Masi (p. 44-47)
Libri per assaggiare altre vite, intervista a Guido Sgardoli (p. 46-47)
L’ho scelto perché (p. 48-50)
By by Harry. Hi Greg!, Alessandra Pecchioli e Elena Tonini (p. 52-53)
Libri e disabilità
Leggere la dislessia e i DSA, Enrico Angelo Emili (p. 57-59)
Orienteering
Nati per raccontare, Manuela Trinci (p. 60-62)
Illustrazione
Ritratti d’aria, Marnie Campagnaro (p. 64-66)
Teatro/Ragazzi
Il teatro dei sensi, Mafra Gagliardi (p. 67-69)
Ricerca
Bologna docet, intervista a Emma Beseghi (p. 70-72)
Media Kids
Dai, prestami un eBook!, Maurizio Caminito (p. 74-76)
Nuovi editori per titoli digitali, Maurizio Caminito (p. 74-75)
Audiolibri
Ascolti di qualità, Paola Legnaro (p. 78-79)
Mailbox
Pinocchio a fumetti, Roberto Denti (p. 80)
Dossier Segnali di lettura
La saggezza di un pesce, la violenza di un umano, Selene Ballerini (p. 82-83)
La libreria dei Ragazzi di Milano compie quarant’anni, Loredana Farina (p. 83)
A tutta scienza!, Francesca Brunetti (p. 84-85)
Pinocchio a fumetti, Roberto Denti (p. 80)
Critici in erba (p. 86-87)
Festival del lettore da giovane a fine maggio, Paola Zannoner (p. 87)
Materia grigia (p. 86-87)
Rubriche
Rubabandiera
Un esercizio filosofico per la filosofia, Roberto Farnè (p. 90-91)
Più leggeri dell’aria, Emma Beseghi (p. 92-93)
Lo scontro culturale tra fascismo e fumetti, Marco Pellitteri (p. 94-95)
Inserto redazionale
In collaborazione tra Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e LiBeR, il primo fascicolo annuale del 2012 de La bibliografia nazionale dei libri per ragazzi, con le segnalazioni di 435 novità di ottobre-novembre 2011
Copertina
L’illustrazione di copertina è di Federico Maggioni
Estratti
Crossover
Stefano Calabrese (Uno storyworld globale: “Il termine inglese crossover (letteralmente “attraversamento”) da pochi anni si è imposto nella comunicazione globale dei media indicando una serie di fenomeni assai diversi, dalla produzione di nuovi veicoli (automobili che hanno le caratteristiche congiunte di una station wagon e di un Suv) al design di indumenti in grado di rivolgersi a un pubblico indifferenziato per sesso o anagrafe, ma è soprattutto nel mercato editoriale che dalla fine degli anni ’90 il termine crossover ha iniziato a indicare nuove forme narrative, caratterizzate dall’accavallamento dei codici di genere (ad esempio nei film d’animazione della Pixar, che ibridano il linguaggio della pop art con l’immaginario disneyano), dal sovrapporsi di storie secondo differenti versioni intermediali (ad esempio i picturebook, dove l’iconico e il verbale risultano inestricabilmente uniti) e in particolare da target generazionali plurimi o non ben definiti. Nondimeno, benché i testi crossover godano dell'attenzione dei media e dividano bellicosamente gli studiosi tra apologeti e detrattori, la teoria letteraria non è andata di pari passo con la popolarità crescente di questa inedita forma di produzione e insieme di consumo estetico che sta contraddistinguendo il nuovo millennio”).
Giorgio Triani (L’epoca del multitasking: “C’era una volta il ‘crossover’ (dall'inglese to cross over, ovvero “passare dall’altra parte”) che, secondo la definizione classica attribuita a tale termine nell’ambito della televisione, del cinema, dei fumetti e dei videogiochi, lo si aveva quando un episodio di una serie televisiva, di un film, di un videogioco, facenti parte di una fiction specifica, si intrecciava con la trama di uno o più episodi di un’altra serie. Per rendere l’idea: la serie televisiva “Star Trek”, all’interno della quale anziché trovare i klingoniani, troviamo i Gremlins come nemici del Capitano Kirk e dell’equipaggio dell’Enterprise. O magari mentre leggiamo un fumetto degli X-Men (Marvel), Ciclope anziché combattere con Magneto combatte con un Predator. Chiara l’idea? Bene: quel crossover non c’è praticamente più. Anzitutto perché le sue frontiere si sono spostate sulla scena multimediale, mettendosi sulla scia del processo di convergenza tra tv, web e telefonia mobile. Tant’è che ora si parla di cross-media e di cross-piattaforma, cioè di idee e progetti innovativi che possono essere sviluppati su media digitali diversi. In secondo luogo perché quel che era un genere narrativo – o meglio “un gioco narrativo di multiversi che si intrecciano” limitato, come pratica e come campo applicativo – si è trasformato in un normale, abituale e diffuso multigioco che s’applica in maniera estensiva; cioè sia nel campo dei media, sia a livello di narratività quotidiana. Ma in entrambi i casi in accordo con lo spirito (trans, multi, iper) dei tempi. Perché attraversare, invadere, contaminare, fondere, mescolare… e chi più ne ha ne metta, è diventato un esercizio quotidiano. Una pratica diffusa che più o meno coscientemente ognuno di noi fa quando è al supermercato, in auto, in cucina, davanti alla tv o al pc, dove una cosa sola e soprattutto una cosa alla volta non si dà più”).
Intervista a Michele Rak (Le mille strade di Mediopolis: “Mediopolis è la città con le strade formate dai media che veicolano in ogni istante di ogni giorno miliardi di testi. Il lettore che, in un modo o nell’altro, deve percorrere queste strade è esposto a scelte che può realizzare sempre più spinto dai fondamentali sociali – conflitto, religione, sesso, profitto e altro – piuttosto che da competenze acquisite nella cultura d’origine attraverso i graduali processi di formazione della scuola, dell’università e dei luoghi di lavoro. Il percorso di questo lettore non è graduale e sistematico, è impulsivo, casuale, erratico, ansiogeno. Fa riferimento a insiemi di conoscenze in continua mobilità (della ricerca anche sulla composizione politica del pianeta), a linguaggi e testi continuamente miscelati per raggiungere gruppi sociali marginali (a cominciare dalla pubblicità e dai new media), ad attrezzi che consentono nuove forme di comunicazione (dai cellulari ai tablet) e contatti con soggetti sociali sconosciuti e che rimangono tali anche dopo contatti sui social network, i siti e altri luoghi testuali visibili e tuttavia evanescenti. La prima conseguenza è che forme elementari di socializzazione rimaste a livello di mentalità tribale, anche all’interno delle città, si contrappongono a forme di socializzazione virtuali richieste dai nuovi abili digitali emergenti e dalle necessità del mercato globale. È un conflitto di mentalità che si combatte strada per strada, dove le culture vedono (ma non se n’accorgono subito) disintegrarsi le loro tradizioni – dai dialetti agli usi, dagli abiti ai modi del divertimento – e comparire all’improvviso nuovi costumi di cui percepiscono l’improvvisa estensione e pressione e di cui devono acquisire, in modo più o meno rozzo, i modi per non correre il rischio di rimanere fuori tempo, cosa che pressoché tutti i gruppi sociali temono. Per questo anche i barboni usano il cellulare”).
Carla Poesio (Le tracce dell’ipotesto: “L’intertestualità è oggi alla ribalta, anche se conta già diversi anni, e ha diversi ambiti oltre a quello letterario. Per quanto attiene alla letteratura giovanile è un tema di molte discussioni e spesso si dimentica che la sua presenza nei libri per ragazzi risale a più di un secolo fa. Basti pensare alla notissima coppia Sussi e Biribissi, a cui Collodi nipote assegna come modello e guida costante nella loro avventura attraverso le fogne il Viaggio al centro della terra di Jules Verne, che a lui non suscitava certo simpatia, ma che ben si prestava a parodiare lo spirito d’iniziativa dei suoi due eroi. Quanto a Le avventure di Pinocchio – libro per ragazzi e anche per adulti – il suo Autore vi riversò vari suoi dubbi di carattere politico e sociale, tra cui l’amministrazione della giustizia, che gli pareva non andasse per il verso giusto, infatti il giudice che appare nelle sue pagine mandava liberi i colpevoli e sbatteva in prigione gli innocenti. Intertestualità di carattere personale che i lettori adulti coglievano a colpo d’occhio, così come l’eco della politica giolittiana, che sempre i lettori adulti avvertivano bene nel Paese delle Api industriose.
La frequenza dell’intertestualità nei libri per ragazzi trova oggi un notevole apprezzamento da parte di chi con tali libri ha un rapporto di critica, di mediazione, di esperienza. È opinione quasi comune (espressa in queste righe nel modo più semplice possibile) che il ragazzo lettore – se una buona penna sa proporgli col dovuto risalto l’elemento intertestuale – non solo avverte una curiosità riguardo a un personaggio, a un evento, a un’avventura menzionati che esulano dallo svolgersi della trama, ma sente lo stimolo a fare un confronto tra ciò che è creazione dello scrittore e la figura, il fatto, la situazione che dal di fuori entrano nella sua narrazione”).
Intervista a Sandrone Dazieri (“Scavallare i target”: “Ci sono due modi per approcciarsi alla scrittura. Quello della pura arte, che è l’estro buttato su carta mediato solo dalle capacità linguistiche, e quello del genere, che prevede una certa dose di pianificazione. Quando scrivi un giallo, per esempio, devi sapere a grandi linee, per lo meno, come va a finire, che scoperte farà il tuo personaggio, come. Ne parlo a ragion veduta perché scrivere gialli è il mio primo mestiere e rimane ancora oggi il mio principale, su carta o sullo schermo. Tenete presente che dico “a grandi linee”, ma molti colleghi preparano scalette minuziose. James Ellroy una volta disse, a proposito di Il Sangue è randagio, che la sua scaletta era più lunga del romanzo. Oltre a questo occorre imparare a fare dei dialoghi credibili, a dosare la suspance e il colpo di scena. Quindi sì, esistono degli ingredienti, ma non significa scrivere “a tavolino” come lo si intende volgarmente. No, significa scrivere in modo artigianale e professionale, ed è necessario quando ci si approccia al genere. E, come editor, il mio supporto agli autori con i quali lavoro è lo stesso che chiedo quando scrivo come autore ai miei editor: cerco di vedere se quello che si cerca di raccontare funziona, e se non funziona perché. Se il personaggio regge, se la trama appassiona, eccetera. Che poi molti scrittori si copino l’un l’altro o scelgano tematiche ricorrenti, il serial killer nei gialli o il vampiro nei crossover, fa parte del gioco. Tutto questo, però, non ha niente a che fare con il successo. Se un editore sapesse il segreto di un bestseller si produrrebbero solo bestseller. Ci sono i libri fatti male e i libri fatti bene: un buon editor sa quando una copertina fa schifo o un titolo non è azzeccato, per esempio, o se l’inizio di un romanzo prende o no. Ma da lì a sapere se fa successo ce ne corre. Un editor scommette sui suoi libri, non ha certezze. E va anche sfatato il mito del marketing. Il marketing, in editoria, è solo un moltiplicatore, non un creatore di successi. Se alla base il libro non marcia sulle sue gambe non c’è niente da fare, è come cercare di rianimare un cadavere: puoi fare un sacco di pubblicità e di campagne lancio, ma i soldi che la casa editrice spende non rientrano con le vendite delle poche copie in più di un libro che non funziona. L’unica vera pubblicità per un libro è il passaparola: se non si innesca, se non piace per qualche motivo, non c’è niente da fare”).
Angela Dal Gobbo (Figure di confine: “Si può parlare di crossover per l’albo illustrato? I confini di età, usualmente collocati tra gli 0 e i 6 anni, possono essere travalicati? E la commistione dei linguaggi, operata da alcuni titoli, può far pensare a un superamento anche dei confini di genere?
In tempi recenti l’albo illustrato ha conosciuto un intenso sviluppo sia sul fronte narrativo – dimostrando sempre maggiore complessità e articolazione – sia sul fronte della ricerca espressiva, diventando uno dei prodotti più innovativi e raffinati tra i libri destinati ai giovanissimi. La maggiore complessità narrativa comporta l’apertura a un pubblico di età più elevata, formato da adolescenti o da adulti. Spesso i testi presentano più livelli di lettura, da quello letterale (immediatamente comprensibile, perciò adatto anche ai bambini) a quello metaforico, o esistenziale, che solo chi ha maturato esperienza può cogliere in modo pieno. Contemporaneamente la ricerca visiva spinge l’albo illustrato in un territorio di sperimentazione che favorisce la sovrapposizione di linguaggi mutuati da ambiti eterogenei, come il cinema, il fumetto, i video, la televisione… Tali caratteristiche collocano l’albo in uno spazio particolarissimo, sorprendente quanto a creatività. È proprio la natura dell’albo illustrato – che lega insieme due codici radicalmente diversi come quello visivo e quello verbale – a rendere così facile la sovrapposizione di linguaggi, anche visivi, e a consentirgli quella grande versatilità che lo caratterizza. Conseguenza (altamente positiva) sta nel predisporre il lettore alla sorpresa, attivando un piacere nella fruizione del libro che motiva e stimola anche i lettori deboli, tanto più i bambini”).
Davide Morosinotto (Storie di attraversamenti: “Definire il crossover è complesso, e ancora più difficile è capirne le applicazioni pratiche. Per questo, forse, può essere utile analizzare esperienze di lavoro concrete: in questo articolo, mi riferirò a quelle che ho visto e vissuto in prima persona.
Sono uno scrittore di libri per ragazzi e da alcuni anni ho la fortuna di lavorare con un gruppo di amici che condividono la mia stessa passione per le storie, soprattutto se rivolte ai lettori più giovani. Ci facciamo chiamare, un po' per scherzo, “scrittori immergenti”, e tra noi ci sono alcuni nomi di spicco della letteratura per ragazzi come Pierdomenico Baccalario, Alessandro Gatti e Elena Peduzzi. Lavoriamo sia direttamente con le singole case editrici, sia in collaborazione con l'agenzia Atlantyca Entertainment di Pietro Marietti (il fondatore della casa editrice Piemme) famosa in tutto il mondo per le storie di Geronimo Stilton.
Io e gli altri immergenti operiamo quindi nel settore della cosiddetta, e mi si perdoni la brutta parola, letteratura commerciale. Cerchiamo cioè di scrivere libri in grado di emozionare un gran numero di lettori, e questo non è affatto scontato in un mercato editoriale come quello italiano dove la stragrande maggioranza delle nuove uscite librarie non vende nemmeno una copia. Nemmeno una. Ora, mi rendo conto che parlare di libri “commerciali” possa far pensare a scrittori avidi che vendono la propria penna e i propri sogni per denaro. Non è così: io e i miei colleghi facciamo questo lavoro con passione, e se avessimo voluto diventare ricchi ci sarebbe senz'altro convenuto imparare a giocare a calcio. Ma siamo convinti che lo sforzo teso a raggiungere molti lettori, e il confronto anche con il mercato e le relative regole o parole d'ordine (come crossover, appunto) possa permetterci di crescere, di scoprire nuove strade… e soprattutto di divertirci un mondo”).
Vignette inedite di Alberto Rebori illustrano questa parte
Nello stesso numero:
Rapporto LiBeR 2012 – Prima parte
A cura di Domenico Bartolini, Riccardo Pontegobbi (“Nel Rapporto sull’editoria per ragazzi, i sondaggi di LiBeR sulle preferenze di lettura del 2011: i migliori libri scelti dagli esperti, i più prestati in biblioteca e i più venduti in libreria, con l’intervista a Guido Sgardoli”. Collaborazione di Benedetta Masi, Alessandra Pecchioli, Elena Tonini).
E ancora:
Enrico Angelo Emili (Leggere la dislessia e i DSA: “Nella nostra società, detta della conoscenza, una persona dislessica può compensare le difficoltà di lettura grazie all’uso di strumenti tecnologici sempre più innovativi. Tra i tanti strumenti compensativi (qualsiasi prodotto o sistema tecnologico che sia in grado di bilanciare un disturbo riducendone gli effetti negativi), i netbook e i tablet pc permettono all’utente di importare e leggere, tramite un programma di sintesi vocale (voce umana artificiale), documenti digitali e file pdf di testi scolastici. Il lettore ha, in questo modo, l’opportunità di leggere, o farsi leggere, gli eBook, talvolta animati, direttamente sul supporto mobile con la possibilità di personalizzarne l’aspetto grafico (carattere, formato e contrasto). L’uso degli strumenti compensativi di norma è consigliato dalla fine della scuola primaria per diventare competenti nel loro utilizzo autonomo, in vista delle scuole secondarie dove il carico di lavoro aumenta. Gli eBook, seppur attraenti, dovrebbero essere affiancati da libri in formato cartaceo, affinché entrambi i supporti diventino mediatori efficaci per l’ingresso nella dimensione del possibile, sempre se proposti in una chiave accessibile.”).
Manuela Trinci (Nati per raccontare: “Allora, a questo punto, dopo tanta giusta enfasi posta su Nati per leggere, si potrebbe cambiare vertice di osservazione e – preda di una sorta di vertigine delle origini o di un’irresistibile vocazione per le storytellers – lanciare come slogan: Nati per raccontare. E questo non solo perché i lattanti dispongono, fino dalla nascita, di quelle capacità linguistiche che solo dopo qualche mese, affinandosi tutta una serie di muscoli della bocca, renderanno l’infante stesso (da in-fari che non può parlare) un essere parlante. No. C’è di più. Intanto oggi sappiamo che il neonato non è più il freudiano bambino ben serrato nel bozzolo del narcisismo primario. Piuttosto, integrandosi i contributi dell’Infant Research, dell’Infant Observation, di contemporanei studi psicoanalitici e di contributi dati dalle neuroscienze, il bebè fino dalle prime settimane di vita, oltre a essere dotato di innumerevoli qualità cognitive e di elaborazione delle esperienze, è alla ricerca di contatti corporei quale prova dell’avviarsi di amorevoli e scambievoli cure. Un piccolo essere relazionale, dunque, da subito. Per quanto riguarda poi, più nello specifico, la relazione sonora fra il piccolo e il mondo esterno, fra il piccolo e la sua mamma, essa si avvia già nel grembo materno, quando il feto — immerso nel liquido amniotico — si sintonizza per ascoltare, della mamma, i borborigmi intestinali, l’onda del respiro, il battito cardiaco, le pause, il rumore del sangue che scorre nelle arterie; quando, esposto al linguaggio grazie alla madre e alle persone che le stanno attorno, il nascituro si allena a percepire, riconoscere e memorizzare rumori e suoni provenienti dal fuori, trovando le sue personali risposte, per esempio accelerando il ritmo del battito cardiaco quando parla la mamma o sobbalzando ai rumori troppo intensi o mostrando un debole per Mozart o Vivaldi, e comunicando in tal modo stati di benessere, di eccitazione o di malcontento”).
Marnie Campagnaro (Ritratti d’aria: “In un interessante passaggio del saggio critico Il potere delle immagini, opera dedicata al ruolo e alle modalità con le quali le immagini suscitano una risposta emotiva da parte di chi le osserva (si tratta un approccio critico-visivo assai lontano dal tradizionale modello di analisi formalista), lo storico dell’arte David Freedberg ricorda come: “nelle nostre menti costruiamo immagini sulla base della nostra memoria del visto, per poter afferrare il non visto (…) Che abbiamo di fronte un’immagine oppure no, la mente può cogliere l’invisibile solo per mezzo del, o con riferimento al, visibile. (…) La meditazione, a meno che non fallisca regolarmente, impone al meditatore la scoperta del potenziale mentale per la visualizzazione pittorica. Ed è nel meditatore che possiamo vedere con maggior chiarezza con quanta facilità la mente faccia ricorso alla costruzione di quadri mentali basati sull’esperienza, quando si ponga il compito di afferrare e soffermarsi su ciò che è assente e speculativo”. Tali parole giovano alla nostra riflessione in quanto evidenziano due fondamentali concetti: il primo concetto, relativo all’atto poietico di costruzione dell’immagine, mette in evidenza la stretta interdipendenza che sussiste fra la memoria del visto e la capacità di afferrare il non visto; il secondo concetto, più rilevante ai fini dell’atto del guardare, sottolinea il ruolo imprescindibile che la prassi della “meditazione” (qui intesa nel significato etimologico del termine latino meditari, ossia pensare, riflettere, studiare, quale azione iterativa di medĕri, curare, applicare, e quindi di una prolungata e intensa capacità di ritornare con il pensiero su un determinato argomento), gioca nel processo cognitivo di comprensione e di produzione di altre immagini mentali”).
Mafra Gagliardi (Il teatro dei sensi: “Il bambino gusta il ‘sapore del mondo’ attraverso il sentire e sperimenta la propria esistenza tramite le risonanze sensoriali e percettive che lo attraversano senza sosta. Il teatro creato per i più piccoli (scuola dell’infanzia e primo ciclo elementare) rivela spesso una felice intuizione del bagno sensoriale in cui è immersa la prima infanzia e propone per questa via ai piccoli spettatori un precoce comportamento estetico (come è noto, il termine greco aistheticos – da cui deriva il nostro “estetico” – significa “sentire”, “capace di sentire” e appartiene alla stessa area lessicale e semantica di aisthanomai, “percepisco con i sensi” “vedo”, “odoro”, “scorgo. Il teatro dei suoni/la ballata del re silenzioso (regia di Cristina Petrantonio, interpretazione di Camilla Da Vico e Giovanna Palmieri, scenografia di Nadia Simeonova, creazione delle immagini di Marco Comuzzi, produzione del Centro S. Chiara di Trento) per esempio, va in questa direzione … Prevalentemente “visuale” è invece un altro spettacolo, Felicità d'una stella, creato per la stessa fascia d'età dal Teatro all'improvviso di Mantova, firmato da Dario Moretti … Per restare in tema, un’altra creazione che promuove l’incontro fra arte e prima infanzia è Wunderkammer/Camera delle meraviglie del Drammatico Vegetale di Ravenna, Compagnia storica del teatro di figura italiano”).
Intervista a Emma Beseghi (Bologna docet: “Il problematicismo pedagogico, fondato da Bertin e poi sviluppato da Faeti con inedite prospettive nel campo della storia della letteratura per l’infanzia, rappresenta un riferimento costante e una linfa preziosa per i giovani che si formano e poi, in alcuni casi, proseguono nel dottorato di ricerca di Bologna con studi innovativi. Antonio Faeti rimane un insuperabile maestro nell’“esplorazione delle connessioni” che attraversano i libri per l’infanzia e a lui siamo debitori del mirabile intreccio con cui sa collocare le opere in una rete di riferimenti ampi e spesso spiazzanti per chi ha una visione riduttiva della materia. L’immaginario è la cifra più profonda di questa esplorazione. Il suo metodo, che mette in gioco e stimola più curiose volontà indagatrici, rappresenta per noi non solo un riferimento ma anche una continua scommessa quando ci accostiamo ai testi e ai loro significati più nascosti. L’insegnamento di Faeti, a cui non cessiamo di attingere perché ha alimentato e ha saputo rinnovare una passione condivisa, è bertiniamente abitato dai richiami dell’“inattuale” perché contrasta le tentazioni di un’epoca dominata dalle facili scorciatoie delle semplificazioni e assediata dalle istruzioni per l’uso in ogni campo della conoscenza e pone lo studio incrociato e apparentemente incongruo di molteplici indizi, segnali e ambiti del sapere, come imprescindibile paradigma ermeneutico da applicare anche ai libri per bambini”).
Maurizio Caminito (Dai, prestami un eBook!: “Pur essendo il fenomeno in Italia ancora agli inizi, si può notare che proprio in questi mesi si diffonde l’uso e la pratica degli eBook tra i lettori di ogni età. Contemporaneamente c'è da dire che il rapporto tra editori e biblioteche non si è evoluto su questo terreno come ci si poteva aspettare. Invece che sciogliersi alcuni nodi si stanno dimostrando difficilmente risolvibili, almeno se si guarda alle posizioni espresse fino a oggi dalle due parti e, soprattutto, alla direzione che sta prendendo il mercato. Questa situazione rischia di penalizzare soprattutto la distribuzione e l’accesso agli eBook per ragazzi”).
Paola Legnaro (Ascolti di qualità: “Nel tempo qualcuno ha raccontato e altri hanno ascoltato, qualcuno ha prodotto fascinazione e altri si sono fatti affascinare. Chi sa narrare ha un potere innegabile su chi ascolta, come sappiamo. E una narrazione sapiente, rivolta a un pubblico giovane e in date condizioni, può produrre esperienze immaginative tanto forti da cambiare radicalmente l’approccio di bambini e ragazzi non solo all’ascolto di storie ma alla lettura e alla scrittura di storie. Alcuni mesi fa ho avuto modo di realizzare presso il Festival della Fiaba Popolare di Campodimele, vicino a Formia, un laboratorio pensato per le ultime tre classi della scuola primaria, a cui hanno partecipato circa duecento bambini in tre giorni. A gruppi di una decina, seduti comodamente a terra in una stanza semibuia, i bambini – e posso dire tutti i bambini – hanno colto la durissima sfida di porsi in ascolto, in silenzio e a occhi chiusi, di brevi brani da opere classiche di letteratura per l’infanzia nella versione in audiolibro, allo scopo di sperimentare come parole che entravano dalle orecchie potevano trasformarsi in immagini dentro la mente”).
Le Rubriche
Ruba bandiera: il gioco e l’immaginario infantile a cura di Roberto Farnè (Un esercizio filosofico per la fenomenologia: “Che il gioco sia una ‘materia’ difficile da definire, complessa per la straordinaria varietà delle sue espressioni, ambigua per come si intreccia con la vita ordinaria, infine mutevole nelle forme e nei significati che assume a seconda delle età della vita, tutto questo è ampiamente noto ed è ciò che rende il gioco una delle esperienze più suggestive e meno oggettive tra quelle che definiscono l’uomo nella sua “essenza”. Le scienze umane, sociali e dell’educazione ci hanno da tempo abituato a fare i conti con le concrete manifestazioni del gioco e con i suoi esiti culturali e formativi, con i suoi rivestimenti ideologici, elaborando raffinate tecniche di osservazione e di analisi, modelli categoriali, tassonomie, producendo su vasta scala materiali ludici che rispondano a criteri scientifici in ambito psicopedagogico. Insomma, ci siamo abituati a trattare il gioco sulla base dei suoi “dati di fatto”. Continueremo a farlo, ma allontanare per un momento lo sguardo da questo punto di vista ci può aiutare ad allargare l’orizzonte cogliendo altre prospettive che forse sfuggono ai criteri dell’utilità immediata, ma non a quelli di una autentica ricerca di senso poiché “Le mere scienze di fatti creano meri uomini di fatto” scriveva Edmund Husserl”).
La cattedra di Peter: le tesi originali della cattedra di Letteratura per l’infanzia dell’Università di Bologna a cura di Emma Beseghi (Più leggeri dell’aria (tesi di Giulia Frascaroli): “Sconfinata e variopinta è la galleria dei bambini di carta che “prendono quota”: per privilegio come Peter Pan e Viperetta, per vivere il mondo all’insegna della leggerezza e di una profonda autenticità come Cosimo Piovasco, per sfuggire allo sguardo adulto come i ragazzi de La guerra dei bottoni e la piccola Aglaia de La casa sull’albero. Ci sono bambini sospesi tra il Qui e l’Altrove come Il Piccolo Principe che conserva fino alla fine il suo sguardo acuto e lieve, bambini che partono a dorso di un’oca come Nils Holgersson per un vero e proprio “volo di formazione”. Si vola per gioco, per magia, con l’aiuto di una scopa, di una risata o di un maestro di vita aereo, con ali autentiche e con ali immaginarie e regolarmente il ritorno prevede cambiamento, stravolgimento sia per il bambino di carta che per il lettore. Sono diversi e paradossalmente opposti i modi per agire la propria leggerezza di spirito e di sguardo, teste rivolte all’insù o visioni oblique di chi guarda la Terra dall’alto, da un rifugio tra i rami, in volo con un pizzico di polvere fatata, sospeso grazie a un pensiero esilarante. La prospettiva del puer è privilegiata: il bambino vede, con il suo sguardo precisissimo e attento che svela anche i segreti più timidi, i sussurri della vita che sfuggono facilmente all’occhio adulto. I bambini e gli Sciamani si trovano inevitabilmente accomunati, in quanto figure liminari con una forte aspirazione per la verticalità e come custodi del bagaglio di conoscenze relative al contatto e alla comunione con il mondo della natura. Il bambino, in questa chiave, si configura come padre dell’uomo perché vive in perfetta armonia con il creato, parla sapientemente la lingua originaria e paradisiaca della natura ed è prescelto dagli uccelli come compagno di volo per veri e propri viaggi di formazione e di conoscenza di sé e del mondo”).
Comunicati stampa
Comunicato n. 1
Comunicato n. 2
Per acquistare LiBeR