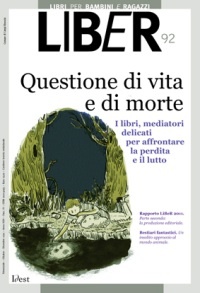[Ottobre – Dicembre 2011]
SommarioSketch
Crossover, Federico Maggioni (p. 7)
La morte
Le parole per dirlo, Manuela Trinci (p. 20-24)
Se Dickens salva la vita, Antonella Lamberti (p. 22-23)
Quando la scuola è in corsia, Andrea Serra (p. 25-27)
Storie di chi rimane e di chi non c’è più. Proposta di lettura da LiBeR Database (p. 28-29)
Libri & ragazzi
Classico, quo vadis?, Roberto Denti (p. 30-32)
Rapporto LiBeR 2011- Parte seconda
Una strada in (ri)salita, Domenico Bartolini e Riccardo Pontegobbi (p. 34-41)
Narratività
Flash fiction: lampi di scrittura, Aidan Chambers (p. 44-45)
Pedagogia della lettura
In viaggio con il Capitano, Antonio Faeti (p. 46-48)
Libri e disabilità
A bordo pagina, intervista a Guido Quarzo e Chiara Carrer, di Marcella Terrusi e Giulia Brintazzoli (p. 50-52)
Bestiari
Uomini, animali & libri, Giulio C. Cuccolini (p. 54-57)
Bestiari e altra umanità. Proposta di lettura da LiBeR Database (p. 56-57)
Media Kids
Harry Potter: non tutto finisce, Maurizio Caminito (p. 58-59)
Net-working
Internet: pentiti ed entusiasti, Domenico Coviello (p. 60-61)
Vedi alla voce
La letteratura fantastica, William Grandi (p. 62-64)
Dossier Segnali di lettura
Cani, tartarughe, orsi, Dei e varia umanità, Selene Ballerini (p. 66-67)
L’ascesa degli audiolibri, Paola Legnaro e Elena Rocco (p. 68-69)
Materia grigia (p. 70-71)
Rubriche
Ruba bandiera
Sante e Tito: maestri della “noble art”, Roberto Farnè (p. 72-73)
La cattedra di Peter
Dalle storie alla Storia, Emy Beseghi (p. 74-75)
La cassetta degli attrezzi
Cataloghi, anzi catalogoni, Claudio Anasarchi (p. 76-80)
Zoom Editoria: le recensioni
24 libri usciti negli ultimi mesi recensiti dagli esperti di LiBeR
Inserto redazionale
In collaborazione tra Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e LiBeR, il terzo fascicolo annuale del 2011 de La bibliografia nazionale dei libri per ragazzi, con le segnalazioni di 702 novità di aprile-giugno 2011.
Copertina
L’illustrazione di copertina è di Zosia Dzierzawska. Nata a Varsavia 28 anni fa, ha preso la matita in mano 23 anni fa, ed è approdata a Milano appena un anno fa. Nel frattempo ha disegnato sempre di più e ora lavora come illustratrice e autrice di fumetti.
Estratti
Questione di vita e di morte
I libri, mediatori delicati, per affrontare la perdita e il lutto
Manuela Trinci (Le parole per dirlo: “I bambini che esiste la morte lo sanno. Anzi, in un certo senso, lo sanno benissimo. Ammettiamo pure che, pur non chiamandola Morte, fino da piccoli hanno conosciuto sentimenti inquietanti, molto vicini al senso di annientamento che la sola idea della morte induce. Da bebè, si sono trovati alle prese con “agonie” primitive, senza nome (descritte da Donald Winnicott, come quelle di cadere all’infinito, di perdersi, di andare in frantumi, ecc.), e crescendo hanno poi conosciuto il timore di essere abbandonati, di rimanere soli. E poi, a parlare con loro della morte, ci sono le fiabe, o i cartoni, che – osservava Bruno Bettelheim – a questi penosi sentimenti riescono a dare voce e rappresentazione mentale. Che dire, infatti, di tante povere orfanelle, da Biancaneve a Cenerentola alla Piccola Fiammiferaia, o del lupo cattivo di Cappuccetto Rosso che viene ucciso dal cacciatore, o di Bambi e del Re leone? Che mai si potrà pensare? Ma la morte, i bambini, possono incontrarla anche lungo la battigia, vedendo una medusa o un pesciolino privi di vita. Senza considerare il numero elevato di ascolti, persino dei più piccoli, alle notizie dei Tg. Nei Tg si parla di morte, e i bambini qui percepiscono pure venti di guerra, di fame e di distruzione, e qui sanno di omicidi, di terremoti e di tsunami e sanno di stragi di profughi, di bambini caduti dai barconi, in mare. Ma questo è ancora un altro livello, per loro, di fare conoscenza con la morte. Si tratta, infatti, in questi casi, di una “morte” relegata a spettacolo o a cronaca consueta, così consueta da provocare una progressiva anestesia dalla sofferenza e una amorale indifferenza”).
Andrea Serra (Quando la scuola è in corsia: “Sono un maestro elementare, molto elementare. Per vezzo e presunzione nel camiciotto ho scritto MaEstro. Uso il camiciotto perché otto anni fa ho iniziato a insegnare in una scuolainospedale. Una scelta con molte motivazioni che avrei capito a poco a poco. Una scelta comunque. La scuola si trova all’interno di un ospedale pediatrico nato per la cura e la ricerca della talassemia (anemia mediterranea) ma col tempo ha ampliato la propria azione alle malattie rare e successivamente all’oncoematologia pediatrica. È in questi due reparti, più il centro Trapianti di Midollo Osseo, che svolgo il mio lavoro. La mia attività si svolge prioritariamente con i bambini delle elementari ma ovviamente nel concreto, si rivolge a tutti quelli che frequentano la scuola. Oltre alla parte didattica, lezioni individuali prevalentemente, un aspetto importante del lavoro è quello da fare con gli insegnanti delle classi di origine. L'importanza di questa attività ha il duplice scopo di permettere ai miei alunni di fare le attività dei propri compagni, ma anche quella di mantenere la classe, gli insegnanti e i compagni, dentro la vita del bambino/ragazzo. Dove è possibile, e per fortuna lo sta diventando sempre più spesso, utilizziamo anche i collegamenti con Skype per far seguire dall'ospedale o da casa le lezioni con i propri insegnanti. L'aspetto più importante, dopo quello di garantire ai bambini ricoverati di godere del diritto allo studio, è quello di fornire un elemento di normalità, di quotidianità in un ambiente e in un momento in cui questa è totalmente capovolta. E in questo capovolgimento è necessario capire come nel concreto, nelle emozioni, nelle sensazioni, non sia il bambino a entrare in ospedale quanto piuttosto l'ospedale a entrare dentro il bambino. Questo cambio di prospettiva aiuta a capire che sei tu adulto a entrare nella casa del bambino e non viceversa. In questo modo tutte quelle che sono le regole, i ritmi, le terapie dolorose, devono trovare un modo diverso per essere proposte”).
Antonella Lamberti (Se Dickens salva la vita: “Dickens, maestro dell’intreccio narrativo, del caso, del destino che premia o castiga i suoi personaggi, sembra diventare così anche nel film il creatore dell’intreccio, responsabile dell’incontro e del lieto fine che ne segue. Lieto non perché ci sia una soluzione a ogni male: il tempo non torna indietro, i morti non resuscitano. Amore e pacificazione possono però esistere ancora dopo il lutto e il tormento e, così come nei suoi libri, una pagina dopo l’altra, si arriva alla quiete che premia i puri di cuore, così qui i vivi scoprono che possono risentirsi tali perché di sicuro c’è un’altra pagina da voltare e un nuovo incontro che porta con sé la vita e fa sbiadire la paura della morte. È stato chiesto allo sceneggiatore di Hereafter Peter Morgan il perché di queste citazioni di Dickens e di questa passione del protagonista per il grande romanziere inglese. Ha risposto che non c’era un motivo, o che forse lo è il fatto che 'un libro di Dickens te lo porti a letto e promette pace e interesse'. Forse allora è di nuovo il destino ad aver portato Dickens, che davvero scampò a un terribile incidente, dentro una storia di sopravvissuti, a suggerirci, insieme al regista, che non è così importante cosa c’è dopo la morte, perché prima possiamo ancora chiederci cosa c’è domani, nella vita che ci resta da vivere, cosa c’è voltando la prossima pagina. Per scoprire che, se siamo puri di cuore, la fortuna magari ci assisterà e ci garantirà quello che almeno Dickens non manca mai di regalare: pace e interesse”).
Libri & ragazzi
Roberto Denti (Classico, quo vadis?: “Una recente tendenza dell’editoria italiana merita qualche breve considerazione perché è certamente il segno di una che lascia piuttosto perplessi. In questi ultimi pochi anni, infatti, non c’è casa editrice che non abbia sfornato una nuova collana di classici o l’abbia rimessa a nuovo con copertine diverse. Quali possono essere le ragioni? Forse la prima è che i classici non esigono diritti d’autore e quindi la loro edizione costa meno, ma sarebbe una trovata inutile se poi i volumi restassero invenduti. Ciò significa che il mercato esiste e che gli editori rispondono a un’esigenza concreta che nei mesi di maggio-giugno del 2011 ha segnato un notevole incremento di vendite. Qualche classico è certamente “leggibile” in quinta elementare ma la loro maggiore diffusione si riscontra nella scuola media dell’obbligo. Ma serve far leggere i “classici”? Il discorso diventa complesso e richiede un’analisi più ampia nella quale la lettura è soltanto una piccola parte e forse non la più importante”).
Rapporto LiBeR 2011 - Parte seconda
Domenico Bartolini e Riccardo Pontegobbi (Rapporto LiBeR 2011. Seconda parte: Il Rapporto propone un’analisi della produzione editoriale del 2010, con dati tratti da LiBeR Database. “Nel corso del 2010 l’editoria per ragazzi ha trovato la forza di reagire al calo produttivo e di intraprendere una significativa ripresa. Il dato è meritevole di grande attenzione da parte degli operatori: le novità librarie prendono a risalire e passano dalle 2155 del 2009 alle 2317 del 2010, superando ampiamente quella soglia dei 2200 titoli che ha segnato lo scalino di resistenza della produzione nel corso del primo decennio del nuovo millennio. Ma l’attuale risalita del numero delle offerte editoriali conferma o smentisce i segnali di riconfigurazione intravisti nella fase di calo?”).
Narratività
Aidan Chambers (Flash fiction: lampi di scrittura: “Queste sono le caratteristiche principali della flash fiction: in genere non supera le 1000 parole, può essere di qualunque genere a patto che sia narrativa. Volendo essere pedanti, occorrerebbe definirla “narrativa-lampo”, in quanto tale forma comprende sia la non-fiction, purché dotata di una struttura narrativa, sia storie inventate. Ma immagino che flash fiction sia diventata la definizione più comune perché suona meglio. Può essere basata su episodi autobiografici o biografici. Può essere una lettera, un brano di diario, un minisaggio o un breve articolo di giornale. Può essere in prosa o senza dialoghi, o anche composta soltanto di dialoghi. Può essere in prima persona o in terza persona e in qualunque tempo. Può utilizzare qualsiasi aspetto del linguaggio e dell’espressione scritta. Deve però essere completa, non un frammento né un brano di un’unità narrativa più lunga. Spesso lascia al lettore il compito di ricreare la storia e di trovarne il “significato”, proprio come fa lo scrittore. Ha una limpidezza e un ritmo apparentemente semplici, ma osservandola meglio ci si accorge che è molto densa e piena di possibili significati. È come un lampo o una scintilla, che permette di scorgere per un istante un’intera scena, una persona, un pensiero, un avvenimento”).
Pedagogia della lettura
Antonio Faeti (In viaggio con il Capitano: “Ecco allora una grande funzione educativa esercitata da Salgari in un paese che di essa ha tanto bisogno: scrivo e penso a un mistero di questi giorni, perché nei quotidiani ho letto di una relazione eroticamente significativa tra Mussolini e Maria Josè. Ebbene: il romagnolo con il petto in avanti e l’indelebile aria felliniana da forzuto di paese, con la colta, elegantissima, nobilmente distante principessa di Piemonte, non ce lo vedo e non ce lo vedrò mai. Questo atteggiamento scaturisce dall’aver letto e riletto Salgari: c’è una sorta di permanente diffidenza nel lettore salgariano vero, è una diffidenza salutare per la democrazia, ma è anche specialmente valida per i popoli che, dalla propria ventrale incoscienza, hanno lasciato emergere una dittatura. La pedagogia della scoperta dei segreti ha (giustamente, inevitabilmente...) molti seguaci nella letteratura per l’infanzia: in questo senso denuncio una mia mancanza, una forte carenza che, nell’anno salgariano, avrei dovuto collocare al centro della mia ricerca. So che Hitler amava leggere Karl May, il 'Salgari tedesco', ma non ho mai davvero riflettuto sulla complessità di questa ben nota esperienza, perché tra il feroce signore dei lager e l’aperto cantore dell’epica della prateria, non c’è nulla che possa collegarli davvero. Eppure ... anche il 'vendicatore', naturalmente, pensando proprio all’ultima, indimenticabile scena del Corsaro Nero, è una presenza fondamentale nell’immaginario, anche per essa si può compiere un salutare esercizio di ricerca entro ambiti molto importanti dell’immaginario”).
Libri e disabilità
Marcella Terrusi e Giulia Brintazzoli (A bordo pagina: Interviste a Guido Quarzo e Chiara Carrer: “Nel panorama della letteratura per l’infanzia sono sempre di più gli albi illustrati e i libri per bambini che raccontano la disabilità e la diversità. Tutte storie che ci parlano dei tanti modi possibili di essere, abili o diversamente abili e senza alcuna forma di commiserazione, dove i protagonisti di queste storie sono bambini autistici, sordi, affetti da sindrome di Down o di Asperger. Storie divertenti e speciali dove le avventure dei protagonisti portano il lettore nella dimensione della diversità intesa come risorsa e non come punto debole, libri che offrono uno sguardo sul mondo e punti di vista inusuali. Questi libri non cancellano il disagio, o l’handicap o la diversità ma sono uno strumento di conoscenza, di esperienza e di crescita utile per migliorare la vita di chi vive a contatto con questi temi, di chi li vive sulla propria pelle, e di chi invece rimane escluso dalla possibilità dell’incontro. I libri, come ponti, mettono in comunicazione voci ed esperienze diverse, tracciano nuove geografie e creano paesaggi più percorribili, ricchi di sentieri che si intrecciano e diramazioni. I libri 'per tutti', come vengono chiamati da Annalisa Brunelli e da Giovanna di Pasquale nel numero monografico della rivista HP-Accaparlante fresco di stampa, sono veicoli capaci di far superare la solitudine, l’isolamento e l’esclusione, in grado di creare comunità di lettori capaci di restituire il diritto di cittadinanza a tutti”).
Bestiari
Giulio C. Cuccolini (Uomini, animali & libri: “L’ambiente primitivo e agricolo non ha mai confuso l’uomo con le bestie verso le quali – soprattutto se utili come mucche, buoi, cavalli e cani – ha però manifestato una vaga affettività ‘battezzandole’ con nomi propri come se avessero una personalità e un carattere. Questa umanizzazione degli animali la ritrovai nelle favole di Fedro e di La Fontaine e poi in quelle di Esopo quando mi misuravo con le traduzioni dal latino e dal francese alla scuola media e dal greco al ginnasio. Al liceo grazie alle spassose incisioni di Giovanbattista della Porta (1535-1616) e di Charles Le Brun (1619-1650) scoprii la fisiognomica che, basandosi sulle rassomiglianze tra volti umani e musi di animali, pretendeva derivare i caratteri morali di una persona dal suo aspetto fisico e tendeva ad attribuire ai vari animali determinati comportamenti. Tradizione che aveva trovato ospitalità nei bestiari, classici e medievali, in cui animali, reali o immaginari, erano eletti a simboli di virtù o di vizi (la fedeltà del cane, l’astuzia della volpe, la stupidità dell’asino, ecc.) a scopo moralizzatore o erano esibiti nei loro aspetti teratologici per destare meraviglia”).
Media Kids
Maurizio Caminito (Harry Potter: non tutto finisce…: “Se qualcuno, leggendo il claim dell’ultimo film di Harry Potter (It all ends: tutto finisce), avesse creduto nell’esaurimento del fenomeno che ha sconvolto le classifiche di vendita di libri per ragazzi in tutto il mondo da quando l’editore Bloomsbury, nel 1996, accettò di pubblicare il primo libro della saga, ebbene si sbaglia di grosso. Non finisce tutto qui. Anzi, forse adesso incomincia il bello. Nel senso che l’operazione editorial-filmica della Rowling oggi si allarga al web e all’editoria digitale, dispiegando tutta la forza di un evento cross-mediale multimiliardario”).
Net-working
Domenico Coviello (Intenet: pentiti ed entusiasti: “Ma i bambini e gli adolescenti di oggi, già classificati dagli studiosi come “nativi digitali”, affrontano la differenza fra vita virtuale (attraverso la tecnologia) e vita reale apparentemente con la stessa dimestichezza con cui - su piano diverso - la generazione di chi scrive guardava con eccitazione la Tv e i primi cartoni animati giapponesi nell’Italia della fine anni ’70. Una relazione – quella fra i ragazzi e il mondo di Internet – che attira sempre di più l’attenzione degli esperti. Soprattutto oltre oceano, negli Stati Uniti, patria del web. Dove è in pieno sviluppo un dibattito sociale e culturale innescato quest’anno da un saggio subito andato esaurito: Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other (Basic Books, New York, 2011) di Sherry Turkle, docente di Sociologia e Psicologia al Massachussetts Institute of Technology (MIT) e celebre da decenni negli Stati Uniti per i suoi studi sulla realtà virtuale. Turkle sostiene che oggi, a vent’anni non ancora compiuti dall’avvento di Internet, 'non siamo più noi a lavorare sui computer tenendoli occupati. Sono loro a tenere occupati noi'”).
Vedi alla voce
William Grandi (La letteratura fantastica: “Non esiste una versione unica della letteratura fantastica: sono invece riscontrabili diverse declinazioni di una medesima tendenza narrativa caratterizzata dalla volontà di esplorare quanto sta oltre la soglia della quotidianità, di tracciare le improbabili ma suggestive mappe dei mondi inquieti che paiono estendersi oltre il reale e che, a volte, sembrano volerlo ghermire. Tale esplorazione può assumere toni e modalità peculiari, dando luogo a esiti molto spesso distinti. Si pensi, per esempio, a due grandi viaggiatori letterari dell’Altrove fantastico, ovvero a Lovecraft e a Tolkien: più o meno contemporaneamente – attorno agli anni ’30 del secolo scorso – questi narratori di area anglosassone raccontarono due diverse finzioni fantastiche. Mentre lo statunitense Lovecraft per i suoi racconti horror faceva leva su un fantastico perturbante e inquietante, dominato da crudeli entità aliene, l’inglese Tolkien recuperava e rielaborava i colori smaglianti delle fiabe e delle leggende nordiche per il suo romanzo fantasy intitolato The Hobbit. Il fantastico dei racconti di Lovecraft è molto diverso da quello tolkieniano: mentre l’uno è proteso con ansia e angoscia verso misteri minacciosi, l’altro descrive un Altrove di meraviglie. Eppure, anche nella differenza, queste due tipologie di racconto possono essere ricondotte all’interno della categoria del fantastico, dal momento che non è l’approccio con il reale, con le concrete dimensioni storiche del vivere comune a rappresentare il loro principale centro d’interesse e di ispirazione”).
Dossier Segnali di lettura: rassegna di iniziative, progetti di promozione della lettura e materiali di letteratura grigia dal mondo del libro per ragazzi (Selene Ballerini – Spuntini di letture: Cani, tartarughe, orsi, Dei e varia umanità; Paola Legnaro e Elena Rocco – L’ascesa degli audiolibri).
Rubriche
Ruba bandiera: il gioco e l’immaginario infantile a cura di Roberto Farnè (Sante e Tito: maestri della “noble art”: “Il gioco e lo sport, nelle loro diverse espressioni e articolazioni più o meno istituzionali, costituiscono fisicamente dei luoghi 'abitati' da soggetti che condividono la gestione concreta di spazi, tempi e materiali, entrano in un sistema di regole e rituali, comunicano attraverso un determinato linguaggio. Che si tratti di un circolo degli scacchi o del tennis, di una palestra di scherma o di un campo di calcio utilizzato dagli iscritti a una società sportiva, i luoghi connotati da pratiche ludiche e sportive sono 'territori vissuti' da gruppi di persone attraverso sistemi di relazioni personali e di gruppo. È assumendo l’ipotesi di una identità antropologica di questi luoghi che Giuseppe Scandurra e Fulvia Antonelli eleggono come campo di ricerca una palestra di boxe alla Bolognina, una zona popolare nella media periferia di Bologna. La 'Tranvieri', questo è il nome della palestra, è frequentata per due terzi da immigrati extracomunitari, perlopiù fra i 16 e i 25 anni, dove la presenza numericamente irrilevante ma qualitativamente significativa di alcune ragazze assume i caratteri di un 'corpo estraneo' con il quale la comunità maschile deve imparare a fare i conti. Se poi anche uno dei ricercatori è donna, la cosa si complica ulteriormente…”).
La cattedra di Peter: le tesi originali della cattedra di Letteratura per l’infanzia dell’Università di Bologna a cura di Emy Beseghi (Dalle storie alla Storia (tesi di Elisa Valentini): “non si può insegnare tutta la Storia con la letteratura, ma rintracciare i canali e i contenuti attraverso cui bambini e ragazzi possono esperire il senso della Storia può contribuire ad arricchire la riflessione sulla trasmissione del sapere storiografico cercando, anche, strategie alternative, tra cui il piacere intellettuale del leggere. Sfruttare i meriti della lettura non potrà che arricchire la pratica della conoscenza, sarà poi compito delle operazioni storiografiche guidate dall’insegnante riuscire a collegare la vicenda individuale narrata alla dimensione collettiva e ai contesti nei quali la vicenda si è svolta. Pertanto, agire con la narrativa e su di essa non comporta falsificare o semplificare la Storia, né demolire la fascinazione della lettura, quanto piuttosto far rivivere problematizzandolo un tema, un evento, un dato, un fatto realmente accaduto. Significa promuovere la lettura come strumento di conoscenza storica, senza nulla togliere al piacere di una lettura individuale e decontestualizzata dall’ambiente scolastico. Significa fare della Storia un’esperienza di senso. Significa riconoscere nella narrativa la capacità effettiva di essere ponte per il passaggio dalle storie alla Storia. Condizioni importantissime affinché la conoscenza così esperita si possa tradurre in Memoria: l’incontro vivo col passato che si sedimenta come memoria del proprio vissuto”).
Sketch rubrica d’illustrazione curata da Federico Maggioni. Tema del numero: Crossover
La cassetta degli attrezzi: gli strumenti di lavoro per gli operatori del settore (Claudio Anasarchi – Cataloghi, anzi catalogoni).
Comunicati stampa ![]() Comunicato n.1
Comunicato n.1
Per acquistare LiBeR