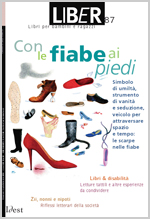[Luglio – Settembre 2010]
Sommario
Fiabe
Il popolo e le scarpe, Dieter Richter (p. 19-26)
Zii, nonni e nipoti
Grazie zii, Manuela Trinci (p. 27-28)
Zii, nonni... questione di osmosi, Fernando Rotondo (p. 29-31)
Gli zii di Disney, Roberto Denti (p. 32)
Zii di qualità. Proposta di lettura (p. 33-35)
Pedagogia della lettura
Le ultime doppie notti, Antonio Faeti (p. 36-37)
Vedi alla voce: Interpretazione psicoanalitica delle fiabe
Se le metafore giocano, Adalinda Gasparini (p. 38-40)
Incontri
Confini letterari e mondi altri, dialogo fra Roberto Denti e Gianni Celati, di Ilaria Tagliaferri e Paolo Iacuzzi (p. 41-43)
Ritorni
Freaks e altre varianti, Tiziana Roversi (p. 44-45)
Libri e disabilità
Libri tattili illustrati... con tatto, Laura Anfuso (p. 46-49)
Proprio come noi, Silvana Sola e Marcella Terrusi (p. 50-51)
Teatro/Ragazzi
Sua maestà la Parola, Mafra Gagliardi (p. 52-53)
Mailbox
Dove li metto?, Miranda Sacchi (p. 54)
Dossier Segnali di lettura
A occhi nudi & bocca aperta, Selene Ballerini (p. 56-57)
Stelle e provette in cerca di un podio, Francesca Brunetti (p. 58-59)
Materia grigia (p. 60-62)
Rubriche
Ruba bandiera
Basta un campo, per giocare, Roberto Farnè (p. 63-64)
La cattedra di Peter
La sposa cadavere di Tim Burton, Emy Beseghi (p. 65-66)
La cassetta degli attrezzi
Almeno questi!, Selene Ballerini (p. 67-68)
Le Recensioni
24 libri usciti negli ultimi mesi recensiti dagli esperti di LiBeR
Inserto redazionale
In collaborazione tra Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e LiBeR, il secondo fascicolo annuale del 2010 de La bibliografia nazionale dei libri per ragazzi, con le segnalazioni di 696 novità di gennaio-marzo.
L’illustrazione di copertina è di Maja Celija.
Estratti
Fiabe
Dieter Richter (Il popolo e le scarpe: piedi nudi e con le scarpe nella fiaba e nella cultura popolare: “Chi non ha scarpe, spesso non ha neppure il pane. È «una bambina povera col capo scoperto e a piedi nudi» che d’inverno deve camminare nella neve, come La piccola fiammiferaia di Hans Christian Andersen: il prototipo della povertà infantile vista dalla prospettiva della compassione borghese. È guardiana d’oche, pastorello o La piccola scalza, la bambina protagonista dell’omonima novella di Berthold Auerbach (Barfüßele, 1856) che narra dell’orfana Amrei che, mostrandosi scalza, ostenta quasi consapevolmente il proprio umile stato sociale: «Fuor che in pieno inverno camminava sempre scalza e si diceva che possedesse un mezzo segreto per non ammalarsi e morire». La povertà, infatti, comincia dai piedi; chi calza scarpe di cattiva qualità, consumate o non le possiede proprio, fa capire già esteriormente che nella sua casa regna la povertà”).
Zii, nonni e nipoti
Manuela Trinci (Grazie zii: gli zii odierni, magari single, sono una risorsa e hanno il merito di allargare gli stretti ambiti familiari arricchendo la genitorialità: “Se non ci fossero gli zii… e le zie! Nella frenesia della vita moderna spesso sono proprio loro che tamponano al volo il ritardo della mamma intrappolata nel traffico, partecipano ai corsi per “nipoti adottati”, alle recite, alle feste, alle passeggiate in passeggino. Poi, vivacizzano i forum con le loro osservazioni sui nipotini, creano siti in qualità di zii fieri di esserlo. Regalano senza parsimonia magliette “Three Wolf Moon”, abitini college upper class, corsi di yoga, figurine dei Gormiti, gel, ragni pelosi, rossetti alla pesca eccetera eccetera. E comunque sia, i loro regali hanno incanto e magia, come la neve bianca che Zio Bianco portò in dono agli Orsi Bruni. Senza considerare che gli zii, che da bambini o da giovanissimi hanno vissuto in prima persona marachelle e scappatelle dei genitori, adesso le raccontano volentieri agli “eredi”. Inoltre, meno pressati dei genitori dai doveri educativi, ascoltano le disavventure e i dubbi dei loro “bocconcini di grana” (per dirla con Geronimo Stilton) e, volendo, trovano anche il tempo per escogitare con loro qualche leggera trasgressione alle regole della famiglia. Insomma, una vera e propria inaspettata pacchia!”).
Fernando Rotondo (Zii, nonni… questione di osmosi: la presenza preponderante dei nonni nella narrativa è la “legittimazione” letteraria di un fenomeno sociale, psicologico e antropologico: “La progressiva sostituzione dei nonni agli zii, nei libri per ragazzi, la loro “prevalenza” narrativa appare, oltre che come una presa d’atto della situazione oggettiva, come una razionalizzazione, la “legittimazione” letteraria di un fenomeno sociale, psicologico e antropologico: la trasformazione della figura del nonno da vecchio saggio della comunità a supporto economico/materiale della famiglia e in accudiente/consigliere del bambino, nella vita quotidiana come nelle pagine dei libri. Dove, a genitori scialbi e mediocri, inadeguati e inaffidabili, si sostituiscono figure di adulti eccentriche, spesso trasgressive, comunque “non in norma”, capaci di un rapporto ludico e fantastico con il piccolo”).
Roberto Denti (Gli zii di Disney: l’esclusione del genitore nella narrativa di Disney sottende una precisa intenzione di trascurare l’aspetto conflittuale dei rapporti familiari: “Ritroviamo gli zii verso la metà del 1900, esaltati dai cartoni animati e dai fumetti di Walt Disney: la loro funzione diventa specifica e determinante. Topolino e Paperino sono zii dei loro nipotini, ragazzini intraprendenti e intriganti dei cui genitori non si parla mai. Papà e mamma hanno una doverosa e precisa funzione educativa, che comporta anche contrasti spesso complessi e difficili da ignorare. Lo zio disneyano, invece, non ha ovviamente responsabilità e l’accordo o i contrasti con i nipoti assumono soltanto un aspetto divertente, mentre se si trattasse di figli il comportamento non potrebbe prescindere dagli indispensabili aspetti formativi. L’esclusione dei genitori nelle storie di Walt Disney riguardanti due personaggi assolutamente molto popolari non è certamente casuale. Fa parte di scelte specifiche della narrativa disneyana, che tende a deresponsabilizzare i protagonisti proponendo un mondo soltanto apparentemente realistico anche con la narrazione di vicende fantastiche”).
Redazione (Zii di qualità: una selezione di romanzi recenti che annoverano figure di zii fra i protagonisti tratta da LiBeR Database).
E inoltre:
Antonio Faeti (Le ultime doppie notti: una carrellata sulle ultime lezioni del corso “Le doppie notti dei tigli”, lungo il quale l’Inattuale è stato riproposto con successo: “Il 20 ottobre ero pieno di dubbi: 25 episodi di una storia della lettura che si andava facendo settimana dopo settimana, mi affascinavano e mi riempivano di ansie. L’atmosfera dell’ultima lezione era tale da spegnere ogni timore. È stato un inverno lungo e freddissimo, però una studentessa iscritta al corso lo ha interamente frequentato venendo da Roma a Bologna ogni martedì, tra neve, pioggia, gelo e ritardi, senza mai rinunciare. Credo che le “doppie notti”, tutte le doppie notti delle nostre vite debbano pensare a questa impresa, a questa sicura dedizione, a questa lettura impavida che ha guardato in faccia la fatica”).
Adalinda Gasparini (Se le metafore giocano: fiaba e psicoanalisi tra pulsioni e convergenze: “L'interpretazione psicoanalitica della fiaba fallisce nella misura in cui ha successo. Riconosce nelle fiabe, genere narrativo dotato di un grado massimo di variabilità formale e di costanza strutturale, analogie calzanti con la propria descrizione della realtà psichica, ma se riesce a dar conto coerentemente di tutta la fiaba essa suona meno vera o meno pregnante della fiaba che ha spiegato. Nei miei lavori sulla fiaba ho cercato di evitare questa deriva, a costo di sembrare imprecisa o incompleta”).
Ilaria Tagliaferri e Paolo Fabrizio Iacuzzi (Confini letterari e mondi altri: dialogo fra Roberto Denti e Gianni Celati: “Ci sono molti modi per esplorare i confini fra la letteratura per adulti e quella per ragazzi. Uno di questi è far incontrare due protagonisti d’eccezione come Roberto Denti e Gianni Celati, in occasione della festa del papà, come è avvenuto il 19 marzo scorso nell’ambito della 54a edizione del Premio Ceppo Pistoia. Partendo dalla rievocazione dei loro esordi letterari, i due “padri” del racconto, vincitori rispettivamente del Premio “Ceppo per l’infanzia e l’adolescenza” e del “Ceppo cultura del verde”, hanno interagito fra loro sollecitati dalle loro reciproche provocazioni, con l’aiuto di due critici-scrittori – Giusi Quarenghi e Alberto Bertoni – che fanno parte della Giuria del Premio. Dal loro dialogo solo in apparenza “anomalo” abbiamo liberamente tratto alcuni stralci salienti per sottoporli alla riflessione dei lettori, pensando che talvolta uno sguardo trasversale rispetto ai temi centrali di un’opera letteraria possa creare un proficuo terreno di confronto, nel quale i confini sfumano e si rimettono in discussione formule critiche già codificate”).
Tiziana Roversi (Freaks, e altre varianti: il celebre Mostri di Sclavi, apparso nel 1994, si arricchisce ora delle illustrazioni di Federico Maggioni, un grande maestro. E il romanzo torna a turbare: “Tiziano Sclavi, il creatore di Dylan Dog e del suo mondo di incubi, racconta, laconico, di un mondo reale di nani, di siamesi, di persone che noi comuni mortali abbiamo visto solo al cinema. Leggendo Mostri si va subito a Freaks (1932) di Tod Browning, film censurato per anni a causa del turbamento che si diceva producesse, che deve gran parte della sua celebrità anche alla presenza nel cast di veri ‘diversamente abili’”).
Laura Anfuso (Libri tattili illustrati... con tatto: strumenti preziosi per favorire relazioni e aprire gli “occhi interiori”: “Le illustrazioni tattili, da 'sentire' e toccare permettono a tutti di vivere una suggestiva esperienza di lettura poiché sono coinvolti altri sensi oltre alla vista. I libri tattili dovrebbero essere ospitati in ogni biblioteca ed essere proposti nelle scuole per consentire a tutti un’esperienza gratificante e, ai bambini con deficit visivo, una lettura condivisa con i compagni vedenti”).
Silvana Sola e Marcella Terrusi (Proprio come noi: il Centro di Documentazione Ibby di Oslo seleziona e diffonde i migliori libri per ragazzi sul tema della disabilità. Nasce una riflessione sulla produzione italiana e sulle buone pratiche: “I libri per ragazzi sono formidabili luoghi di relazione, dove il dialogo si costruisce attorno a un oggetto esterno che diventa una voce da ascoltare insieme, adulto e bambino, bambino e bambino, per affidarsi alla 'sospensione dell’incredulità' che ci dà sollievo perché ci permette di predisporci all’ascolto, alla ricezione. I libri per ragazzi, quando si parla di disabilità e di differenza, sono strumenti e compagni di strada discreti e a volte potenti, capaci di mostrare quotidianamente alcune vie possibili, non solo attraverso codici speciali, ma con messaggi per i cinque sensi in grado di offrire piacere, conoscenza, tempo di qualità attraverso la forma flessibile del progetto editoriale che si fa racconto”).
Mafra Gagliardi (Sua maestà la Parola: la ristampa di alcune opere teatrali di Roberto Piumini offre nuovi spunti di riflessione sulla carriera del celebre scrittore: “In questo genere di testi, Piumini si propone nel ruolo tradizionale del conteur, del narratore in praesentia, che istituisce una complicità costante con il suo uditorio, quasi come in una comunicazione diretta occhi-negli-occhi (e la narrazione, si sa, è il grado zero del teatro). Anche i suoi testi teatrali veri e propri hanno una forte matrice di oralità – direi quasi di corporeità – e spesso nascono da una precedente narrazione”).
E anche:
Dossier Segnali di lettura: rassegna di iniziative e progetti di promozione della lettura e di materiali di letteratura grigia sul mondo del libro per ragazzi.
Le Rubriche:
Ruba bandiera: il gioco e l’immaginario infantile a cura di Roberto Farnè (Basta un campo, per giocare: quali sono i luoghi di integrazione tra ragazzi italiani e stranieri? Giardini, parchi, cortili... dove giocando si impara a conoscersi: “’Siamo in un campo sportivo pubblico in un piccolo paese dell’Italia settentrionale…’
‘È domenica pomeriggio, assisto alla finale di Coppa Italia di cricket…’
‘Mi trovo nella piazza principale del quartiere “multietnico” di una grande città italiana…’.
Questi sono alcuni incipit con cui si aprono i capitoli del libro di Davide Zoletto, Il gioco duro dell’integrazione: l’intercultura sui campi di gioco (Raffaello Cortina, 2010). Ognuno degli otto capitoli inizia con una situazione che l’autore descrive sulla base di un atteggiamento di ‘osservazione partecipante’. Non si tratta di un escamotage letterario, ma di una precisa scelta metodologica, tra quelle di cui si avvale la ricerca nel campo delle scienze sociali e dell’educazione. Né tali situazioni sono generiche o casuali, ma si collocano ognuna all’interno di unità tematiche di cui costituiscono l’efficace abbrivio di tipo empirico”).
La cattedra di Peter: le tesi originali della cattedra di Letteratura per l’infanzia dell’Università di Bologna a cura di Emy Beseghi (La sposa cadavere di Tim Burton: questo è il titolo della tesi di Alberto Baccarini che ne esplora le metafore fiabesche attraverso uno sguardo pedagogico: “Nonostante siano trascorsi circa cinque anni dall’uscita cinematografica de La sposa cadavere, quest’opera si può tuttora considerare l’emblema di Tim Burton – l’eclettico regista di incredibile talento inventivo che oscilla tra il gotico e la fiaba, il cupo e il poetico. La sposa cadavere, infatti, con la ricchezza dei significati simbolici in essa contenuti, rappresenta un percorso paradigmatico all’interno della sua variegata produzione filmica. Ed è considerata un vero e proprio regalo che Burton ci ha voluto fare per aiutarci a evocare con la gioia nel cuore ‘i nostri morti’, come segnala la sua visione televisiva riproposta nella notte di Halloween”).
La cassetta degli attrezzi: gli strumenti di lavoro per gli operatori del settore, di Selene Ballerini (Almeno questi! Nel portale www.liberweb.it la quinta edizione della bibliografia di base delle biblioteche per ragazzi).