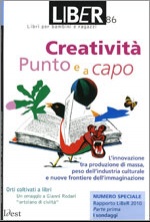[Aprile – Giugno 2010]
Sommario
Creatività
Maestro di creatività, Franco Cambi (p. 15-18)
Il poeta lettore di uomini, intervista a Bobo Rondelli di Domenico Coviello (p. 19)
Spazio alla creatività del lettore, Carla Poesio (p. 20-23)
La congiunzione tra arte e scienza, intervista a Ludovica Lumer di Vichi De Marchi (p. 22-23)
Secoli di novità, Roberto Denti (p. 24-27)
Genesi della potenza creativa, Stefano Calabrese (p. 28-29)
Letture ludiche, Loredana Farina (p. 30-32)
Il libro giocattolo, Gianni Rodari (p. 33-35)
Le proposte del graphic novel, Daniele Barbieri (p. 36-38)
Piccoli editori inventano, tavola rotonda con Grazia Gotti, Fausta Orecchio e Corrado Rabitti (p. 39-42)
Orti coltivati a libri
Gianni Rodari “ortolano di civiltà”, Vinicio Ongini (p. 43-47)
I libri della scuola che fa i libri, Adriana Querzè (p. 44-45)
Cipollino e gli altri. Proposta di lettura (p. 48-50)
Rapporto LiBeR 2010 – Prima parte
A Kuijer il Premio LiBeR, Benedetta Masi (p. 52-55)
L’irriverente amicizia di Gesù, intervista a Guus Kuijer di Federica Velonà (p. 54-55)
L’ho scelto perché…, commenti di Flavia Bacchetti, Angela Dal Gobbo, William Grandi, Eros Miari, Fernando Rotondo, Giorgia Grilli, Rosella Picech, Carla Poesio (p. 56-58)
Seriali, occhio al secondo!, Alessandra Pecchioli, Elena Tonini (p. 60-61)
Pedagogia della lettura
Ritrovarsi non vuol dire dirsi addio, Antonio Faeti (p. 65-66)
Cultura scientifica
Eppur ci sono…, intervista a Ilaria Capua e Lucia Votano di Francesca Brunetti (p. 67-69)
Dalla parte del lettore
L’ombra del dubbio, Antonio Faeti (p. 70)
Dossier Segnali di lettura
Un teatro portatile giapponese e una mamma giramondo, intervista a Daniela Celli di Antonella Lamberti (p. 72-73)
Focus su “Fahrenheit”, intervista a Marino Sinibaldi di Ilaria Tagliaferri (p. 74-75)
Materia grigia (p. 76-78)
Rubriche
Ruba bandiera
Giocattoli da leggere, libri da giocare, Roberto Farnè (p. 79-80)
La cattedra di Peter
Il sogno di Pan, Emy Beseghi (p. 81-82)
La cassetta degli attrezzi
Da Lucca Comics, Giulio C. Cuccolini (p. 83-84)
Le Recensioni
20 libri usciti negli ultimi mesi recensiti dagli esperti di LiBeR
Inserto redazionale
In collaborazione tra Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e LiBeR, il primo fascicolo annuale de La bibliografia nazionale dei libri per ragazzi, con le segnalazioni di 433 novità di novembre-dicembre 2009.
L’illustrazione di copertina è di Paolo Guidotti.
Comunicati stampa
Estratti
Creatività
Franco Cambi (Maestro di creatività: Rodari pedagogista, teorico della formazione e della didattica: “Rodari è sì un narratore di storie di razza e un poeta autentico per l’infanzia, un giornalista acuto e colto, un politico impegnato sul fronte della cultura a vari livelli, ma è stato anche un pedagogista. Attento allo studio dell’infanzia, interlocutore critico dell’educazione familiare e di quella scolastica, un intellettuale che si è collocato “accanto ai maestri” per dare indicazioni riflessive e metodologie didattiche innovative, sempre disposte su una frontiera pedagogica assai significativa, non solo ideologicamente. No, anche in senso squisitamente pedagogico-operativo. Sì, il suo obiettivo massimo è favorire l’emancipazione di tutti (e qui è con Marx e con Gramsci, soprattutto) attraverso l’assimilazione della cultura - alta e critica: quella che fa vera cittadinanza - per dar corpo a una società democratica avanzata e in sviluppo. Nel suo lavoro narrativo e riflessivo ci sono anche elementi di pedagogia cognitiva, di teoria della formazione della mente e del soggetto, di educazione alla pace, di pedagogia della creatività, che tende a valorizzare la formazione estetica e a tradurla in una didattica efficace. Per formare una mente complessa, plurale e dialettica, come è richiesto dalla concezione che oggi abbiamo del mentale e della formazione cognitiva, necessari per abitare una società - appunto - complessa e un sapere sempre più polimorfo e in via di innovazione costante”).
Bobo Rondelli intervistato da Domenico Coviello (Il poeta lettore di uomini: “In principio fu Sergio Endrigo. Il signore della canzone italiana amava musicare e cantare poesie per i bambini: prima i testi del brasiliano Vinicius de Moraes, poi quelli di Gianni Rodari. Erano gli anni a cavallo fra i ’60 e i ’70, Endrigo spopolava a Sanremo e Rodari diventava celebre in tutto il mondo vincendo il Premio Andersen e pubblicando il suo capolavoro La grammatica della fantasia: introduzione all’arte di inventare storie. Ossia, potremmo dire, come parlare ai bambini per mandare messaggi anche ai grandi. È proprio quello che nell’anno di grazia 2010 fa Bobo Rondelli, il cantautore livornese di Shanghai (o Shangai, per dirla in labronico). Rondelli, considerato dai fan, da molti critici e da illustri concittadini come Paolo Virzì (che gli ha dedicato il film L’uomo che aveva picchiato la testa e lo ha fatto recitare ne La prima cosa bella), uno dei migliori cantautori italiani di oggi, si è rimesso, forse senza volerlo, sulle orme del grande Endrigo. Così nell’ultimo album di Rondelli, Per amor del cielo (che ha concorso come finalista al Premio Tenco 2009), torna a farsi vivo per interposta persona Gianni Rodari”).
Carla Poesio (Spazio alla creatività del lettore: il lector in fabula si esplicita grazie a una curiosità sollecitata dalla lettura: “Siamo oggi lontani dalla morte dell’autore prevista da Barthes negli anni ’70 e più attenti a una politica dell’Auteur (si usa preferibilmente la dizione Auteur derivata dalla storia del cinema). Non lo si vede, ovviamente, come divinità sul piedistallo, ma pur sempre come agente che dà al lettore la facoltà (empowerment) di interagire, di acquistare un potere di lettura interpretativa, che rimane, comunque, circoscritta dalle prospettive narrative su cui è costruito il testo. Talvolta le varianti immaginate, gli interventi creativi paralleli nella mente di chi legge, possono essere anche imprevisti per l’autore stesso, ma la forza, l’efficacia, l’originalità dell’intervento inventivo del lettore sono pur sempre debitrici dell’empowerment offerto dal testo.
È errato pensare che esistano come lectores in fabula solo lettori provveduti sia per età, sia per frequenti esperienze di lettura. Nell’ambito della creatività non si parla di selezione o di selezionati. A esempio, l’albo illustrato per lettori debuttanti o alle prime armi, con la forza delle immagini che convivono col testo, è in grado di provocare e sviluppare nel bambino un’autonomia sia di visione, sia di identificazione, sia di accrescimento e sviluppo di quanto viene proposto da figure e parole”).
Ludovica Lumer intervistata da Vichi de Marchi (La congiunzione tra arte e scienza: “Qualsiasi cosa cambia un individuo: anche vivere chiuso in una stanza ti modifica. Il bambino nasce con un certo numero di neuroni che non possono aumentare. Nel primo anno di vita nella mente del bambino si cominciano a formare le connessioni tra neuroni, a esempio inizia ad articolarsi il linguaggio. Queste connessioni creano l’individualità, fanno dell’individuo ciò che egli sarà. Ma le connessioni che si formano sono fin troppe, ed ecco che interviene ciò che Gerarld Maurice Edelman, premio Nobel per la medicina, chiama “darwinismo neurale”. Edelman, grande esperto delle funzioni cognitive mentali, ha dimostrato come vi sia una selezione naturale delle molteplici connessioni che si formano. Solo le psinapsi che ricevono un “rinforzo” vivono. Data questa plasticità psinapsica, l’importanza degli stimoli è enorme. Ogni esperienza in qualche misura ti fa diventare quello che sei. Ogni volta che si fa un’esperienza significativa, il rapporto tra i neuroni cambia per permettere a quell’esperienza di depositarsi nella memoria. Ovviamente a ogni età corrispondono esperienze diverse, come la verbalizzazione o l’astrazione”).
Roberto Denti (Secoli di novità: excursus storico sull’innovazione nella letteratura per l’infanzia dall’Ottocento a oggi: “Con la fine della seconda guerra mondiale entriamo nel mondo della narrativa contemporanea, nella quale non sono mancati autori di grande importanza innovativa. L’inizio compete ad Astrid Lindgren con Pippi Calzelunghe (1945). La piccola protagonista ha i genitori praticamente sempre assenti: vive sola con i suoi animali che stanno in casa con lei (compreso il cavallo a cui piace star seduto in poltrona); mangia quando e quello che vuole. Di fatto riesce a fare a meno di mamma e papà, vive benissimo ed è una bambina felice. Successo mondiale del libro, arrivato in Italia alla fine degli anni ’50 per merito di Donatella Ziliotto che dirigeva la collana Il Martin Pescatore (Vallecchi) che pubblicò molti altri romanzi in controtendenza a una narrativa per ragazzi banale e dolciastra. Pippi Calzelunghe permise a chi lo leggeva un sogno meraviglioso: non sono in grado di stare senza mamma e papà ma posso sognare di farne a meno. È la libertà di comportarmi come voglio, almeno nell’immaginazione! La famiglia cambia aspetto!”).
Stefano Calabrese (Genesi della potenza creativa: i segreti della creatività e dell’innovazione in letteratura: “In ambito umanistico, particolarmente nelle attività estetiche e artistiche, i processi di trasformazione radicale avvengono secondo relazioni ormai accertate con il contesto storico-sociale, l’andamento dell’economia, le innovazioni tecnologiche. Qualche valente frequentatore dei media studies ha, a esempio, dimostrato come nelle epoche di recessione economica il livello di creatività inventiva si innalzi improvvisamente, per poi divenire sterile nei momenti di incremento degli indici economici e di welfare, quando ciò che è stato inventato viene diffuso, distribuito, introdotto negli interstizi della vita reale. Nei momenti di stagnazione, il sistema punta sull’innovazione tecnologica, e in particolare nell’ambito della comunicazione e dello storytelling, l’arte del narrare. Insomma, ci sarebbe una disgiunzione tra flussi culturali e flussi economici.”).
Loredana Farina (Letture ludiche: le tendenze della produzione di libri-gioco in Italia: “Ho provato anche in passato a definire i libri-gioco con poche parole, e ogni volta ho dovuto rinunciare alla brevità perché questi oggetti di confine tra giocattolo e libro, fatti apposta per i bambini piccoli, costituiscono un bel campo di ricerca che ha tuttora molte strade da percorrere. Il gioco è un’attività speciale che consente ai bambini di entrare in relazione col mondo per esplorarlo attraverso i sensi e decodificarlo con la mente. Su questo si gioca la complessità dei libri-gioco e su questo si articola e diversifica la ricerca. La non poca difficoltà a circoscriverli, è dovuta al fatto che gli oggetti in questione sono in qualche modo dei mutanti, visto che il cartone con cui perlopiù sono realizzati non ha solo funzione di supporto su cui stampare parole e immagini, ma ha una forma, uno spessore, una struttura, e anche queste comunicano messaggi conoscitivi ed emozionali. Si può dire che i libri-gioco siano insieme contenitore e contenuto. Che forma e sostanza in essi coincidano”).
Gianni Rodari (Il libro giocattolo: un testo pubblicato sul bollettino AVIO nel 1969: “Sui libri-giocattolo, che l'industria editoriale produce da anni per i piccolissimi e che i manuali di letteratura infantile regolarmente trascurano, si potrebbero fare diversi discorsi. Già la loro classificazione sarebbe abbastanza laboriosa. Ci sono, per cominciare, i libri “animati”, che raccontano una storia accompagnandola con illustrazioni “agibili”: si tira una lingua di cartoncino e il lupo mostra il suo ceffo, prima nascosto dall'albero, per spaventare Cappuccetto Rosso, i nani si tolgono e rimettono il berretto, il maggiordomo infila la scarpina sul piede di Cenerentola e la ritira, tutte le figurine della scena si muovono, come in un piccolo teatro. Ci sono i libri stampati su grosso cartone, con colori speciali perché il bambino se li possa mettere in bocca senza pericolo: perché non bisogna dimenticare che, come la prima digestione si fa in bocca, cosi è con la bocca che si compiono le prime conoscenze. Ci sono libri stampati su stoffa, lavabili. La varietà dei formati è grandissima: si passa dalle dimensioni enormi a quelle semi-microscopiche, il che è giusto, perché il bambino ha interesse per le cose grandi, che oppongano qualche difficoltà al suo bisogno di maneggiare, sollevare, spostare, ma è sempre colpito da tutto ciò che appartiene alla categoria del “piccolissimo”. Ci sono “libri” stampati su cartoncini staccati, componibili e scomponibili come un gioco di carte, organizzati secondo “insiemi” fantasiosi che tocca al bambino riscoprire”).
Daniele Barbieri (Le proposte del graphic novel: tendenze e novità nel fumetto in Italia: “A oltre vent’anni dalla scomparsa di Andrea Pazienza, il fumetto italiano percorre con continuità e, per certi aspetti, sempre maggiore intensità la via, personale, intimistica, crepuscolare e al tempo stesso sarcasticamente disperata, indicata a suo tempo da lui. Apparirà strano che, nonostante questo, Pazienza non abbia praticamente avuto eredi diretti – salvo forse nel manierismo fortemente imitativo di un Maurizio Manfredi, o magari nel ben più consistente lavoro di Paolo Bacilieri, di frequente indicato come migliore prosecutore dell’opera di Pazienza, ma in verità troppo originale per essere ridotto a questo. È che quello che più facilmente appare del lavoro di Pazienza è il suo fantasmagorico virtuosismo espressivo, sia sul piano grafico che su quello del racconto – ma un aspetto così specifico del suo genio non ha modo di fare scuola. Ciò che resta, invece, è una tendenza che magari Pazienza non ha inaugurato, ma di sicuro vi si è inserito tra i primissimi, e, almeno in Italia, è stata condizionata da lui in maniera determinante”).
Redazione di LiBeR (Piccoli editori inventano: tavola rotonda tra editori ‘creativi’: Giannino Stoppani, Orecchio Acerbo e Zoolibri rispondono alle nostre domande: “Il concetto di innovazione vorrei porlo accanto a quello di novità. Per noi librai ed editori novità è diventato il termine con cui si designa il libro appena stampato, l’ultimo della serie spedito alle librerie. Tante sono le novità in un anno, ma poche le vere novità: intendo collane, argomenti, nuovi illustratori, nuovi autori. Ecco allora che il mio giudizio sull’innovazione nell’editoria italiana per ragazzi è un giudizio critico che sottolinea la sostanziale inerzia. Si va avanti per inerzia, anche se da parte dei piccoli editori c’è ovviamente più spinta innovativa. La grossa spinta dei grandi è quella della concentrazione, tanti marchi in poche mani e questa è una innovazione che hanno praticato tutti i Paesi”).
Nello stesso numero:
Orti coltivati a libri
Vinicio Ongini (Gianni Rodari ortolano di civiltà: dall’orto del rodariano Cipollino a quello delle fiabe di Calvino: “Questo fantastico mondo di frutta e verdura, nato nel clima del dopoguerra, in un’Italia ancora contadina ma anche attiva, fiduciosa nel futuro (certo più di quanto lo sia l’Italia di oggi) può ancora incuriosire e appassionare i piccoli lettori? Cipollino può convivere con i cartoni dei mille canali televisivi, con i Pokemon e i Gormiti? E potrà mai competere un orto, la dimensione dell’orto, emblema di un mondo contadino ormai scomparso, con la tridimensionalità degli occhialetti 3D? Inoltre c’è un sospetto: se Cipollino è nato sul giornalino dei comunisti e piaceva tanto nei paesi comunisti è lecito pensare che contenesse o si prestasse a letture ideologiche e moralistiche. È lecito pensarlo ma quelli erano gli occhiali del tempo non quelli che metteva l’autore. Proprio ricordando i primi anni del suo lavoro di scrittore Rodari dice: “Dopo Cipollino venne Gelsomino nel paese dei bugiardi e poi tutti gli altri. Però devo raccontare un antefatto. L’antefatto è che prima, prima della guerra, avevo già incontrato il mondo dei bambini molto da vicino, come maestro di scuola…..Ora ho capito che scrivere per i bambini è un’altra maniera di fare il maestro. Cerco di non essere un maestro noioso ma spero che i bambini imparino qualcosa dalle mie storie e filastrocche. Mi basta che imparino a guardare il mondo con gli occhi ben aperti. Anche ridere è una maniera di imparare. Penso, inoltre, che le mie storie vadano bene anche per i grandi, almeno per i maestri e i genitori che possono usarle come uno strumento per comunicare con i loro scolari e figlioli”).
Adriana Querzè (I libri della scuola che fa i libri: “Libranch’io Ambiente, la scuola che fa i libri è un’iniziativa che si svolgerà a Modena e nel cui ambito prende avvio il progetto “Orti coltivati a libri”: la manifestazione si basa sull’idea che la scuola, oltre a essere un luogo di trasmissione di cultura è anche luogo di produzione di cultura nel quale è possibile scrivere, realizzare, editare libri”).
Redazione di LiBeR (Cipollino e gli altri: bibliografia)
E ancora:
Domenico Bartolini, Riccardo Pontegobbi (Rapporto LiBeR 2010 - Parte prima: “I sondaggi sulle preferenze di lettura del 2009: i migliori libri scelti dagli esperti, i più prestati in biblioteca e i più venduti in libreria”).
Antonio Faeti (Ritrovarsi non vuol dire dirsi addio: continua il diari del corso ‘Le doppie notti dei tigli’: “Libri lontani, letti nell’adolescenza, riletti ora da vecchio, a 71 anni, con una ermeneutica estremamente diversa, con strumenti che non sono quelli di allora. Sempre con una commossa constatazione: “loro” cambiano, con il mutare dei modi dell’interpretazione, ma aumenta, sempre, quella passione ingovernabile che li rese capaci di lasciare una traccia così rilevante in una bildung. Considero, per esempio, i nuovi modi di lettura con cui ho percorso le pagine delle Cronache di poveri amanti di Vasco Pratolini, li passo in rassegna, questi modi, valuto la loro consistenza. Dalla prima lettura adolescenziale sono trascorsi 55 anni, conosco decine di libri sul fascismo di cui allora non sapevo nulla, possiedo perfino una piccola collezione di diari composti da squadristi. Ma il fascino struggente di quella via del Corno, in quella Firenze appartata, povera, minima, nascosta dietro i palazzi stupendi, è perfino aumentato, perché il genio di Pratolini non regala nulla al contingente, nulla alle mode letterarie, nulla ai capricci di un’estetica stagionale. Così, ora, il personaggio della vecchia maitresse cresce fino a sfidare vincendo (proprio così: vincendo...) le presenze non dissimili di Cent’anni di solitudine. E la grande sfida di Pratolini, dopo decenni di trionfi della “storia minima” imitata dai francesi, si ripropone intatta”).
Lucia Votano e Ilaria Capua intervistate da Francesca Brunetti (Eppur ci sono: nella vita reale come nella letteratura per ragazzi le scienziate sono ancora troppo poco visibili: “L.V. Credo che la battaglia da condurre sia più generale, occorre battersi perché cambino i modelli di riferimento che appaiono nei media e principalmente nelle televisioni, per esempio per una televisione di qualità. Non è facile però avere proposte concrete su come condurre questa battaglia e quindi sulla possibilità di scalfire i modelli imperanti.
I.C. Bisogna creare dei modelli nei quali le giovani ragazze si riconoscano. Nel campo della scienza le icone italiane sono Rita Levi Montalcini e Margherita Hack, le nuove generazioni hanno bisogno di personalità che siano più vicine a loro e che diano il messaggio che esistono carriere gratificanti anche nelle professioni che sembrano non immediatamente accessibili. Si dice che per le donne nella ricerca scientifica esista “un soffitto di cristallo”: anche se nel nostro paese sono molte le donne che intraprendono studi e professioni scientifiche sono relativamente poche coloro che arrivano ad occupare posizioni di rilievo nelle università e negli enti di ricerca”).
Antonio Faeti (L’ombra del dubbio: una rifllessione sull’ultimo romanzo di Jack Ketchum: “Ho letto La ragazza della porta accanto di Jack Ketchum (Gargoyle, 2009), con un senso di pena, di sgomento, di ansia, ovvero in condizioni di spirito che non credevo più possibili in un lettore che ha superato i 70 anni. Ci furono quasi solo tre occasioni, ma allora ero un adolescente, in cui mi sentii preso da turbamenti dello stesso tipo. Ho letto, soffrendo, Le diaboliche di Jules Barbey d’Aurevilly e mi sembrò, a metà degli anni ‘50, di essere entrato in uno di quei luoghi di sevizie e di torture che erano collocati anche vicino a casa mia e sui quali avevo sentito orribili racconti alla fine della guerra. Ho letto l’episodio di Merenzina, nell’Enrico il verde di Keller e non ho mai guardato una mia scolara, negli anni in cui ero maestro, senza vedere in lei la bambina assassinata dal religioso. Ho letto Teresa Raquin di Zola pensando alle turpitudini della Bologna povera e operaia nella quale vivevo. Ho sempre ritenuto che i tre libri fossero grandi libri, che dovessero fruire di variegate e complesse ermeneutiche. Ma il libro di Ketchum non offre alcuno spiraglio per una forma qualunque di catarsi e, ben scritto e ben costruito come è, prende il lettore e lo lascia lì, nel rifugio antiatomico abbandonato, nell’orrore delle sevizie, nella terrificante successione delle torture”).
Dossier Segnali di lettura
Rassegna di iniziative e progetti di promozione della lettura e di materiali di letteratura grigia sul mondo del libro per ragazzi:
Antonella Lamberti - Un teatro portatile giapponese e una mamma giramondo: Daniela Celli ci racconta il kamishibai;
Ilaria Tagliaferri – Focus su Fahrenheit: intervista a Marino Sinibaldi)
Le Rubriche:
Ruba bandiera: il gioco e l’immaginario infantile a cura di Roberto Farnè (Giocattoli da leggere, libri da giocare: “I giocattoli - intesi qui come oggetti ideati e realizzati da adulti per il gioco infantile - e i libri per bambini, nascono pressoché insieme come le due linee di prodotti che hanno caratterizzato la cultura per l’infanzia della modernità, man mano che si è sviluppato quello che Philippe Ariès ha chiamato il “sentimento per l’infanzia” e il bambino è diventato un “soggetto sociale”. La fondamentale intuizione di Rousseau è di porre al centro l’esperienza del bambino, per il quale il gioco è insieme lettura e avventura, costruzione della fantasia e della realtà, movimento del corpo e della fantasia. La differenza è che il gioco è attività naturale (il bambino gioca non perché qualcuno gli insegna a giocare), la lettura è un’attività che presuppone un apprendimento formale. Tra queste due dimensioni c’è la pura e semplice narrazione, il piacere di raccontare e ascoltare storie, o di guardare figure che diventano racconti, giochi… È in questa chiave, dove pedagogia del gioco e della lettura dialogano e incrociano i rispettivi percorsi nell’esperienza infantile, che si colloca il lavoro ideato e curato dalla cooperativa culturale Giannino Stoppani di Bologna, che ha prodotto la mostra Books and toys: children’s companions. Libri e Giocattoli: compagni di viaggio dei bambini, e il suo eccellente catalogo”).
La cattedra di Peter: le tesi originali della cattedra di Letteratura per l’infanzia dell’Università di Bologna a cura di Emy Beseghi (Il sogno di Pan: “Peter nasce dalla penna di Barrie, un bambino eterno, un uomo che, ancora piccolo, capisce che le madri amano di più i figli che non crescono, quelli che, in seguito alla morte, non potranno mai diventare così grandi da poterle deludere. Barrie decide quindi di non crescere, ma ciò che rimarrà di questo grande primo dolore sarà il desiderio di avere una madre che gli voglia bene, desiderio che condivide con il dio Pan e con Peter ma che, tutti e tre, non riusciranno mai a realizzare. Peter cerca questa mamma in Wendy: Wendy è la donna vittoriana, che sta in casa, che cura la famiglia e che racconta storie, Peter, ancora, cerca una mamma che lo accudisca, che lo faccia sentire amato , ma che non lo segua nelle sue avventure. Per questo entra in scena Trilli, figura complessa e poliedrica che rappresenta la fatina, la donna passionale, la suffragetta che non si piega al volere maschile, la compagna di giochi coraggiosa ed interessante. Il rapporto tra Peter e le donne è centrale nella maggior parte dei film e dei romanzi a lui dedicati.”).
La cassetta degli attrezzi: gli strumenti di lavoro per gli operatori del settore: Giulio C. Cuccolini - Da Lucca Comics: Novità e segnalazioni dopo l’ultima edizione del salone toscano.
Per acquistare LiBeR