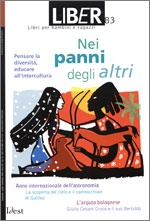[Luglio – Settembre 2009]
Sommario
Interculturalità e narrativa
Nelle scarpe degli altri, Vinicio Ongini (p. 19-22)
Siamo tutti migranti, Adalinda Gasparini (p. 23-25)
La figlia delle cavallette, Ribka Sibhatu (p. 26-28)
Nei panni degli altri, Direzione di LiBeR (p. 28)
Autori: Giulio Cesare Croce
L’arguto bolognese, Antonio Faeti (p. 29-31)
2009 Anno dell’Astronomia
Alla luce della prima candela, intervista a Jayant Vishnu Narlikar di Francesca Brunetti (p. 32-34)
Guardare il cielo con gli occhi di Galileo, F.B. (p. 33)
Vieni a vedere oltre, Francesca Brunetti (p. 35-36)
Strumenti
Il nuovo soggettario, Anna Lucarelli (p. 37-40)
Il thesauro Spider, Direzione di LiBeR (p. 38-39)
Cartoonia
In nome del fumetto, Marco Pellitteri (p. 41-43)
Promozione della lettura
Un rapporto da curare con amore, Roberto Denti (p. 44-47)
Sulla lettura dei classici, una lettera del 1964 di Don Lorenzo Milani (p. 46-47)
Libri dell’altro mondo
Libri a Levante, Loredana Farina (p. 48-52)
Illustrazione
Iconografia di Esopo, Giulio C. Cuccolini (p. 53)
Mailbox
Dove sta il colpevole?, Miranda Sacchi (p. 54-55)
In biblioteca nessuna censura, comunicato dell’Associazione italiana biblioteche (p. 55)
A carte scoperte
Apologia dell’orso, Roberto Denti (p. 56)
Dossier Segnali di lettura
Il giro del mondo… con Raccontalibri, intervista a Sergio Guastino di Ilaria Tagliaferri (p. 58-59)
Pagine in gioco: le biblioteche di Antonio in ABruzzo, IBBY Italia (p. 60-61)
Materia grigia (p. 62-65)
Premio Nati per Leggere, Maria S. Quercioli (p. 66)
Rubriche
Ruba bandiera
Lo sport, la pedagogia e S. Paolo, Roberto Farnè (p. 67-68)
La cattedra di Peter
C’è una scimmia nel divano, Emy Beseghi (p. 69-70)
La cassetta degli attrezzi
Documentazione e infanzia, Antonella Schena e Anna Maria Maccelli (p. 71-72)
LiBeRWEB
Novità in LiBeRWEB (p. 76)
Inserto redazionale
In collaborazione tra Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e LiBeR, il secondo fascicolo annuale de La bibliografia nazionale dei libri per ragazzi, con le segnalazioni di 571 novità di gennaio-marzo 2009.
Copertina
L’illustrazione di copertina è di Giulia Orecchia
Estratti
Nei panni degli altri
Vinicio Ongini (Nelle scarpe degli altri: i sandali di Cenerentola, i tacchi di Gulliver, gli stivali della statua di Bagdad: “Mettersi nelle scarpe degli altri è un buon modo per mettersi nei panni degli altri e guardare la realtà con occhi diversi. Anche se l’altro è un nemico, sostiene lo scrittore israeliano David Grossman nel libro Con gli occhi del nemico (Mondadori, 2008). Quando avremo conosciuto l’altro dall’interno, da quel momento non potremo più essere indifferenti a lui. Non potremo comportarci come se non esistesse, o come se non fosse una persona, dovremo tener conto delle sue ragioni, della sua storia, forse capiremo di più i suoi e i nostri errori. Che cosa ha impedito, sostiene lo scrittore, agli israeliani e ai palestinesi di fare questo passo, di guardare con gli occhi dell’altro?”).
Adalinda Gasparini (Siamo tutti migranti: “Identità è stretta somiglianza, e noi di fatto ci sentiamo normali se somigliamo a qualcosa di normale, desiderabili se somigliamo a qualcosa di desiderabile per il mondo al quale apparteniamo. I colonizzatori hanno sempre tenuto a distanza i colonizzati, come gli eserciti nemici si tengono a distanza, perché è perturbante vedere quanto somigliamo a chi ci deve servire o a chi dobbiamo combattere. Eppure oggi i media ci portano in casa nostra, sullo schermo della nostra televisione o del nostro pc uomini e donne di ogni parte del mondo, e ci troviamo costretti a guardare la loro fame, la loro malattia, la loro ricchezza, la loro gioia e la loro disperazione. È come se vivessimo tutti una migrazione virtuale illimitata, viaggiando virtualmente in paesi lontani con una rapidità e un’abbondanza inimmaginabili fino a pochi decenni fa. La tendenza ad affermare la superiorità, e la maggiore legittimità, della nostra cultura accende fuochi che sembrano più violenti di quelli delle guerre del passato, ma anche la nostra capacità di comunicare con chi è lontano e diverso, pochi decenni fa irraggiungibile, è cresciuta in misura esponenziale.”).
Ribka Sibhatu (La figlia delle cavallette: “Quando in Italia faccio vedere i miei alberi genealogici, la gente rimane abbagliata. L’albero genealogico in questione però non contiene solo nomi, ci sono anche tantissimi racconti legati ai miei antenati. Nelle scuole, porto i bambini in Africa attraverso il racconto della mia nascita. Spiego loro che uno dei miei sopranomi era “la figlia delle cavallette”, perché sono nata tra le continue invasioni delle cavallette che hanno fatto sprofondare il paese nella carestia. Racconto le storie delle mie madri e dei miei padri. Sconcertati i bambini mi chiedono: “Ma quante madri hai tu? Io ne ho solo una!”. Dico ai ragazzi che non sono diversa da loro e nello stesso tempo sottolineo che in caso di bisogno, le mamme eritree, a cominciare dal villaggio di appartenenza, si comportano tutte come fossero delle vere mamme. La maggior parte degli studenti considera le storie legate ai miei antenati come favole. Grazie a queste meravigliose “favole” vengono calmati anche gli alunni iperattivi. Ho visto tanti ragazzi soprannominati “difficili” diventare i principali attori dell’intercultura. Alcuni di loro mi chiedono: “Se l’Eritrea è come ci racconti, allora perché la televisione parla solo di brutte cose sull’Africa?”.”).
Autori: Giulio Cesare Croce
Antonio Faeti (L’arguto bolognese: “In Bertoldo, Camporesi ha visto confluire, come entro uno spazio adatto a contenere tutto, quella alterna contesa fra il Sopra e il Sotto, tra dominanti e dominati, che è parte fondamentale dell’Immaginario occidentale. Dai libri di Camporesi, mi dico spesso, dovrei essere capace di ricavare quanto mi serve per l’oggi, mentre gli Alboini usano mille travestimenti e i Bertoldi sembrano tutti morti, mentre il 'panierone di Cuccoli' è pieno di veline anoressiche e di ruffiani travestiti da presentatori televisivi. Ecco il punto, infatti: è davvero tutto finito, l’omogeneizzazione ha vinto, il contrasto che meravigliosamente divide i damerini che affliggono il cardinal Lambertini e i villani che mangiano l’erba per tacitare la fame, non c’è più?”).
2009 anno dell’astronomia
Francesca Brunetti (Alla luce della prima candela: Intervista a Jayant Vishnu Narlikar, illustre astrofisico indiano che in occasione dell’Anno internazionale dell’Astronomia ci parla di questa disciplina, ma anche della comunicazione scientifica nel suo Paese tra tradizioni culturali diverse, organizzazioni non governative e innovazione tecnologica. “Uno dei vantaggi che gli astronomi hanno è che, perlomeno in India, esiste da parte di tutti, persone colte e analfabeti, una grande curiosità riguardo al cosmo. Quindi un comunicatore scientifico può usare l’astronomia come cavallo di battaglia per la diffusione della cultura scientifica. Ho avuto modo di tenere conferenze pubbliche in piccole città rurali, e ho assistito a persone che interloquivano con me nel loro linguaggio. Ricordo di avere tenuto tre conferenze in una zona remota, nei primi due giorni il luogo che le ospitava era un auditorium con una capienza di 1.000 posti, comprese le zone esterne, il terzo giorno mi sono trovato in un’area all’aperto con un pubblico di 10.000 persone!. Questo significa che il desiderio di conoscere la scienza tra le masse è (veramente) grande.”).
Francesca Brunetti (Vieni a vedere oltre: “È possibile iniziare un percorso bibliografico sull’esplorazione del cielo e dello spazio a prescindere da Galileo Galilei? Non nel 2009. Gli esiti delle scoperte del grande scienziato sono stati a tal punto rivoluzionari, profondi e dirompenti nella storia dell’umanità, da indurre le Nazioni Unite a proclamare il 2009 “Anno internazionale dell’Astronomia”. Sono trascorsi quattro secoli da quando Galileo puntò per la prima volta il cannocchiale verso il cielo per osservare cose invisibili a occhio nudo e ovunque nel mondo si moltiplicano gli eventi dedicati al grande scienziato. La nostra editoria per ragazzi non manca l’appuntamento e torna su questo periodo, cruciale nella storia della scienza, con alcune pubblicazioni che si segnalano per la loro originalità.”).
Strumenti
Anna Lucarelli (Il nuovo Soggettario: “Come è noto, per offrire al mondo dei lettori e degli studiosi strumenti efficaci che consentano di acquisire informazioni, conoscere quanto l’editoria ha prodotto, accedere ai contenuti delle pubblicazioni, ai loro “soggetti”, le biblioteche impiegano strumenti catalografici particolari basati su linguaggi di indicizzazione; questi strumenti, se applicati con uniformità e coerenza, consentono di corredare ogni descrizione bibliografica di dati che riguardano il tema di base di ogni opera, permettendo così di recuperare notizie tramite accessi che, a seconda dei linguaggi di indicizzazione usati, possono presentarsi in forma di stringhe di soggetto (intestazioni costituite da combinazioni di termini ordinati con una sintassi particolare), o semplicemente da parole chiave, uno o più termini eventualmente collegati fra loro al momento della ricerca, a cui è affidato il compito di rappresentare i concetti fondamentali trattati nell’opera descritta. Così i contenuti concettuali dei documenti diventano sia un importante punto di accesso, sia dati significativi che si aggiungono a quelli su autori, traduttori, titoli, eventuali titoli originali, editori, ecc.”).
Cartoonia
Marco Pellitteri (In nome del fumetto: “In Italia le prime storie propriamente definibili a fumetti – apparse prima in modo episodico e disorganico su alcune riviste illustrate nel corso dell’Ottocento e poi sul Corriere dei Piccoli fondato nel 1908 – non erano definite come tali. Il termine è registrato per la prima volta nel dizionario della lingua italiana di Bruno Migliorini nel 1942 per designare le nuvolette e poi, nell’edizione del 1953, alla parola si attribuisce per sineddoche la definizione delle storie disegnate che delle nuvolette si avvalgono. È evidente che la storia del nome con cui questo oggetto linguistico, letterario ed editoriale è indicato, anche in Italia è contrassegnata dalla incapacità (o impossibilità?) di restituirne con maggiore precisione la natura e struttura. E, poiché tutte le parole hanno una storia e col tempo si imprimono nel tessuto socio-culturale di una nazione, è molto difficile e sarebbe anche inopportuno delegittimarle.”).
Promozione della lettura
Roberto Denti (Un rapporto da curare con amore: “Soltanto la scuola può affrontare il disinteresse di bambini e ragazzi alla lettura. Sulle famiglie non è certo il caso di poter contare. Aiutare bambini e ragazzi a leggere richiede però una competenza particolare che nessun insegnamento cattedratico è in grado di fornire. È una materia – la lettura – che esce completamente dai tradizionali canoni didattici ma senza la quale bambini e ragazzi vengono privati di quegli elementi mentali, l’immaginazione e poi la fantasia, che richiedono un costante aiuto per essere sviluppati. È bene ricordare che l’essere umano viene al mondo con una sola capacità innata: succhiare il seno materno. Tutto il resto gli viene insegnato: non sapremmo camminare in posizione eretta se non ci aiutassero a sapere come si fa, non saremmo in grado di parlare se non fossimo costantemente aiutati. Tutti gli esseri umani hanno potenzialmente la capacità di immaginare ma anche questa facoltà va insegnata, non con la didattica di lezioni scolastiche ma con la proposta – che in genere arriva attorno ai tre anni – dell’ascolto della fiabe”).
Libri dell’altro mondo
Loredana Farina (Libri a Levante: “Shahrazad è la figlia del visir di Chahzeman, Sinbad il marinaio vive a Bagdad, Aladino trasporta il palazzo della principessa dal Chatai al Marocco, Alì Babà vive in Persia. Frequentando, nel corso di questi anni, la produzione degli editori mediorientali di libri per ragazzi, ho cercato anche Le mille e una notte. Ma inutilmente. Il perché è presto detto. Il capolavoro in lingua araba è una sorta di invenzione dell’Occidente, anzi di Antoine Galland. Questo studioso, segretario dell’ambasciatore francese in Oriente – con il quale aveva viaggiato a lungo imparando il turco, l’arabo e il persiano – tornato in patria fece conoscere ai francesi Shahrazad e le sue storie. Era il 1704, poco dopo il successo di Cappuccetto Rosso e Il gatto con gli stivali di Perrault.”).
Illustrazione
Giulio Cuccolini (Iconografia di Esopo:” Il Museo della figurina del Comune di Modena da alcuni anni affianca alla sua attività di routine (consistente in un’esposizione che offre un panorama storico della figurina) ricorrenti proposte espositive, consistenti in interessanti mostre e puntuali cataloghi dei quali un paio di volte abbiamo dato notizia su queste pagine. L’ultima di queste mostre svoltasi nella primavera 2009 era dedicata all’iconografia di alcune favole esopiche dalle origini a oggi.”).