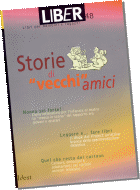Non è un’offesa né una malattia, e neppure un mero contenitore di ricordi.
Non necessita di compassione ma di rispetto. Nessuno sa esattamente quando inizia ma se ci arriviamo si presenta come l’abbiamo costruita negli anni. Inquietudini, delizie, potenzialità e rapporti intergenerazionali della vecchiaia, una fase dell’esistenza degna come le altre di essere vissuta con creatività e pienezza. Intervista a Fulvio Scaparro di Marco Venturelli tratta dal numero 48 di LiBeR.
Nelle sue Storie del mese azzurro lei sembra voler lottare tenacemente contro gli stereotipi relativi all’immagine sociale della vecchiaia, costruiti non solo da parte degli “altri” ma anche dagli anziani stessi…
Conoscete la storia del bicchiere riempito per metà: è mezzo pieno o mezzo vuoto? È diffusa l’opinione che “mezzo pieno” sia la risposta dell’ottimista, “mezzo vuoto” quella del pessimista. Aggiungiamo una terza possibile risposta: “dipende dal liquido contenuto nel bicchiere”. Se invece di buon vino si tratta di uno sciroppo ricostituente dal sapore sgradevole l’ottimista dirà, per farsi forza e mandar giù la medicina, che “è mezzo vuoto”, mentre il pessimista si renderà più dura la vita guardando quel bicchiere “mezzo pieno”.
Questo mi viene in mente quando sento alcuni vecchi che danno giudizi generali sulla vecchiaia quando in realtà esprimono una valutazione personale del modo con cui loro stanno attraversando questa fase della vita. Due illustri esempi fra tutti: il fondatore della psicanalisi Sigmund Freud e l’etnologo Claude Lévi-Strauss, anbedue tra i massimi protagonisti del secolo che si sta chiudendo.
Freud così risponde all’amica Lou Salomé che elogia la vecchiaia e lo esorta a coglierne gli aspetti positivi, invitandolo di fatto a vedere il bicchiere “mezzo pieno” di buone cose e a non soffermarsi su ciò che non c’è più, sul “mezzo vuoto”: "non ci trovo più tanto gusto alla vita. A poco a poco mi sento ricoprire da una corteccia di insensibilità; lo constato senza rammaricarmene. In fondo si tratta di un processo naturale, quasi un cominciare a diventare inorganico. Credo che si chiami serenità della vecchiaia".
Sentite invece cosa disse Lévi-Strauss agli amici che festeggiavano il suo 90° compleanno, il 25 gennaio 1999 al Collège de France: "Montaigne ha detto che la vecchiaia ci riduce ogni giorno che passa; così, quando la morte sopraggiunge, non si porta via che un mezzo uomo, o un quarto di uomo. … Ora a questa età … c’è per me un io reale che non è più che la metà o un quarto di uomo, come diceva Montaigne; ma c’è anche un io virtuale, che conserva ancora viva un’idea del tutto. L’io virtuale prepara un progetto … e dice all’io reale: “adesso tocca a te”. E l’io reale, che non è assolutamente in grado di continuare, risponde: “Non ci penso nemmeno. È affar tuo. Sei tu soltanto che ancora percepisci la mia totalità”. La mia vita oggi si svolge con questo strano, continuo battibecco tra i miei due io. Ma devo ringraziarvi perché, grazie alla vostra presenza e alla vostra amicizia, per qualche istante avete fatto cessare questo dialogo, e avete permesso ai miei due io di coincidere di nuovo".
Non si tratta di scegliere chi di questi due grandi pensatori abbia ragione. Entrambi stanno descrivendo quello che sentono e ha poco senso dire se sia giusto o sbagliato il loro modo di concepire la propria vecchiaia. Si tratta di due grandi vecchi che sono stimolati a parlare di sé e lo fanno in condizioni diverse, in fasi diverse della loro esistenza e, se interrogati in altro modo e in altro momento, avrebbero potuto forse avere reazioni soggettive differenti. Fermandoci tuttavia a quanto abbiamo appena letto possiamo dire che, se entrambi hanno ben presente l’inevitabilità della fine e il progressivo ridursi delle energie fisiche e psichiche, non reagiscono allo stesso modo. Fanno i conti non solo con il decadimento del corpo ma pure con quello, molto temuto, della propria creatività. Usano parole diverse che riflettono i rispettivi umori: alla “corteccia di insensibilità”, al “diventare inorganico”, all’inaridimento di cui parla Freud si contrappone in Lévi-Strauss il conflitto tra un io reale che si sta “sciogliendo” — e dunque non si rinsecchisce — e un io virtuale vivo e vegeto.
Molti anziani avvertono dentro di sé questa diversità di tempi e modi d’invecchiamento tra corpo e psiche. Ci sono giorni in cui li afferra un cupo pessimismo perché si percepiscono avviati in direzione di quella “serenità della vecchiaia” che, per come ne parla Freud, somiglia a un vero e proprio rimbambimento. In altri giorni, invece, si sentono più vicini alla posizione di Lévi-Strauss e il loro io reale battibecca con l’io virtuale; sono più vivaci, più battaglieri.
C’è però un passo nel discorso di Lévi-Strauss su cui vorrei porre l’attenzione: quello in cui lo studioso ringrazia chi, con la sua presenza e la sua amicizia, gli ha consentito, sia pure per poco, di ritrovare la totalità di un tempo, quando il corpo e l’anima viaggiavano di pari passo. Noi abbiamo questa possibilità quando entriamo in contatto attento e affettuoso con gli anziani della nostra vita: aiutarli, fosse anche per brevi momenti, a ritrovare l’unità che sentono perduta, a sentirsi ancora fertili e a vedere la vita come ancora dotata di senso. Quest’esperienza è alla portata di tutti: provate a vedere, per esempio, come un anziano si rianima quando racconta un episodio della propria vita a interlocutori non distratti ma curiosi, interessati e partecipi, come avverte dentro di sé le spinte migliori della giovinezza quando sente che la sua giornata ha un senso.
Secondo lei quali fattori hanno contribuito alla creazione e alla diffusione della paura della vecchiaia nella società attuale?
Leggo che nel 2050, se sono giuste le previsioni della Ragioneria di Stato, saremo in 46 milioni a vivere nel Bel Paese contro i 57 milioni di oggi. “Saremo”? Dovrei dire “saranno”, ma a parte il saggio suggerimento di non porre limiti alla Provvidenza mi sento parte di una storia che è iniziata prima di me e non finirà con me. Se è vero che siamo, almeno in parte, il prodotto di un passato e che attraverso ciò che facciamo oggi diamo un contributo, sia pur infinitesimale, a ciò che avverrà domani, capirete perché sono tanto interessato al 2050, anno che ho buone probabilità di non vedere. In quell’anno sul palcoscenico ci saranno nuove messe in scena, ma attori molto simili a me che forse non sapranno d’interpretare vecchi copioni. Se anche non vedrò quest’Italia del futuro, dunque, sento — o m’illudo di sentire — di essere parte di una lunga carovana che si snoda nel tempo e mentre cammino m’interrogo con curiosità sui territori e sulle genti con cui la carovana entrerà in contatto.
Nel 2050 saranno adulti o anziani molti dei bimbi e ragazzi che adesso sono accanto a me nella carovana. Oggi c’è allarme per la loro condizione. Tutti segnalano i pericoli a cui sono esposti, le inadempienze delle famiglie e delle istituzioni, ma alle parole e ai buoni propositi non fanno seguito in ugual misura fatti coerenti. Eppure quello che io faccio oggi per e con i bambini contribuirà in qualche modo a costruire gli adulti e gli anziani del 2050. Ecco in che senso il presente e il futuro sono uniti, ecco in che modo il nostro orizzonte terreno va al di là della durata della nostra vita, ecco perché nel 2050 ci saremo tutti, rappresentati dai risultati di ciò che oggi abbiamo fatto od omesso di fare.
Torniamo alle previsioni sulla popolazione italiana tra circa mezzo secolo. Abbiamo visto che saremo circa il 20% in meno, ma non basta. Leggo che saremo anche molto più vecchi: uno su tre avrà più di 65 anni, mentre solo uno su sei avrà meno di 20 anni; se ne deduce che fra pensionati e giovanissimi solo una metà della popolazione sarà impegnata in attività produttive e “manterrà” l’intera comunità. Io la penso un po’ diversamente, come molti altri del resto. Oggi — come accade nel film Ritorno al futuro — possiamo tentar di cambiare lo scenario delineato dagli esperti costruendo, se sapremo farlo, un tipo di società che contrasti certe tendenze negative. Già adesso l’Italia si presenta come un crocevia di movimenti migratori che spingono a immaginare un 2050 con meno italiani di antica residenza e tanti altri nuovi arrivati, immigrati e figli e nipoti d’immigrati, integrati in una società che proprio per questo non sarà poi cosi vecchia. Com’è avvenuto in altri paesi può darsi che le tensioni che accompagnano l’arrivo dello “straniero” si trasformino nel tempo nella consapevolezza che l’immigrazione può essere un’importante risorsa sia economica sia culturale. Molto dipenderà da ciò che riusciremo a fare oggi.
Ciò che però mi preoccupa in questo diffondersi di scenari di un’Italia con tanti vecchi e pochi bambini è la concezione sostanzialmente negativa del termine “vecchio” che viene trasmessa, al di là delle buone intenzioni di chi quegli scenari delinea. Dove ci sono più vecchi ci sarebbero meno bambini e quindi anche meno vitalità, meno vivacità, meno gioia di vivere; si vivrebbe con la testa rivolta verso il passato, non si guarderebbe al futuro, non si progetterebbe né sognerebbe. So bene che le cose non stanno così e m’inquieta che in tempi di scarsa attenzione per gli anziani possano diffondersi interpretazioni distorte di dati e previsioni. Sta però a noi evitare lo spandersi di certi pregiudizi, costruendo una società viva e vitale dove convivano vecchi e bambini, dove gli anziani e i piccoli siano rispettati e abbiano la possibilità di vivere con dignità ed esprimere il loro potenziale, dove non si ponga il problema di “chi mantiene chi” per il semplice fatto che tutti hanno fatto o faranno la loro parte al momento giusto. Per non parlare di presunte o reali tensioni tra vecchi e giovani attizzate da chi non si accontenta d’immaginare cupi scenari di mondi di “vecchi”, ma titola senza mezzi termini sui giornali: “i vecchi al potere non lasciano posti di lavoro ai giovani”. Girando per l’Italia, incontrando tanti anziani nelle case, negli istituti, negli ospedali, per la strada, mi viene da sorridere a pensare ai milioni di vecchi del nostro paese — molti dei quali al di sotto della soglia di povertà — come a gente “di potere”. Certo, come sempre è avvenuto, non mancano vecchi potenti abbarbicati ai loro posti di comando e ostili a ogni cambiamento, ma questi non sono in alcun modo rappresentativi degli anziani italiani, com’è dimostrato dal poco o nulla che hanno fatto per migliorarne la condizione.
Se non ci piacciono gli scenari che gli esperti vanno descrivendo sul futuro della nostra collettività diamoci da fare oggi. Il problema non è tanto l’Italia che invecchia o non fa più bambini, ma piuttosto cosa fa l’Italia per i vecchi e per i bambini oggi, cosa fa per ridare agli italiani l’ottimismo e la fiducia nel futuro, che si traducono non solo nel mettere al mondo figli ma anche nell’accogliere tra noi coloro che chiedono solo di lavorare e vivere onestamente. Mi piace molto l’idea che con le nostre azioni di oggi abbiamo la possibilità d’incidere – mi auguro positivamente – sui nostri figli e nipoti che vivranno nel 2050 e di cambiare lo scenario della Ragioneria di Stato. E sapere che un seme buono gettato oggi produrrà i suoi frutti nel 2050 forse non mi allunga la vita, ma di certo mi allarga il cuore.
Nel suo libro c’è una frase che a me è piaciuta molto: “abbiamo una vita per diventare i vecchi che siamo”.
Chiunque sia vissuto abbastanza a lungo almeno questo lo ha imparato: vivere bene fa bene. Il problema sta nel capirci su cosa intendiamo per “vivere bene”, visto che è ancora diffusa l’errata opinione che sia sufficiente avere danaro e potere per star bene. Le cose non stanno così: vivere bene vuol dire star bene con noi stessi e con gli altri, portare in mezzo agli altri i risultati di un lungo lavoro — può durare tutta una vita — diretto a distinguere ciò che conta da ciò che è superfluo o addirittura dannoso. Vuol dire imparare a vivere insieme agli altri impostando le nostre relazioni, per quanto possibile, sulla base di scambi costruttivi. In altri termini: non solo “non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te” ma anche “fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te”.
Ma quali che siano gli aspetti che si considerano essenziali per la propria esistenza una cosa è certa: nulla di ciò che conta arriva senza fatica, senza impegno, senza contraddizioni. “Tutto ciò che ha valore è costoso, esige molto tempo e richiede molta pazienza” diceva Jung; e potrei aggiungere che noi ci affezioniamo a ciò che abbiamo costruito con il tempo e con la pazienza. Così si formano i legami che contano e che sono destinati a durare nel tempo, così si forma la nostra identità, così si gettano le basi del nostro benessere, così ci si avvicina senza paura a una buona vecchiaia.
Un giorno ho letto su un quotidiano la protesta di un lettore che non voleva essere chiamato “anziano” né tantomeno “vecchio” perché lo trovava umiliante e dispregiativo. Avrebbe preferito essere chiamato senior come si fa negli Stati Uniti, dove — così scriveva — c’è maggior rispetto per chi ha più anni di vita. Senza entrare nel merito di quanto avviene in quel paese mi limito a osservare che non dobbiamo aver tanta fiducia nelle parole, siano esse gradevoli o sgradevoli al nostro orecchio. Maggiore attenzione dovremmo dedicare ai fatti in base ai quali certe parole come “vecchio” sono sempre più usate quale insulto invece che pronunciate e utilizzate in segno di rispetto. Ho l’impressione che se non mutano le condizioni di vita degli anziani e l’atteggiamento che la comunità ha nei loro confronti non sarà sufficiente cambiare una parola per incidere sui fatti, e con il passare del tempo anche “senior” finirebbe col diventare un insulto come “vecchio”.
Non va poi trascurata la possibilità che le parole, soprattutto quelle insultanti, si trasformino in etichette e producano a loro volta fatti. Se stabiliamo che si diventa ufficialmente vecchi dopo i 65 anni, da quell’età ci verrà affibbiata l’etichetta di “vecchi” con tutto il carico di stereotipi e pregiudizi, perlopiù negativi, che attorno alla parola si è venuto accumulando negli anni. Non sarò dunque soltanto un essere umano di 65 anni ma un “vecchio”, nel senso di logoro, superato, debole, vicino al fine-corsa. E allora coloro che hanno a che fare con me si comporteranno di conseguenza, con il bel risultato di confermare (e talvolta di convincere perfino me) che sono proprio logoro, superato, e così via. Ecco così che la parola, divenuta un’etichetta, ha prodotto dei fatti.
Chi, mosso a compassione, vuole evitare di offendere il vecchio sostituirà il termine, ormai divenuto offensivo, con qualche eufemismo: “maturo” per esempio, o “di una certa età”, “meno giovane”, e così via, evitando perfino la parola “anziano”, che sta pericolosamente avviandosi a far la fine del vocabolo “vecchio”, un tempo glorioso. Tutto questo mi piace poco. Io mi sforzo di fare in modo che termini come “vecchio” e “vecchiaia” non siano più brutte parole che richiamano esperienze di vita talmente spiacevoli da dover essere coperte da eufemismi, come si usa fare per certe malattie: spero piuttosto di contribuire, insieme a tanti altri, a modificare i fatti così da ridare contenuti positivi a quei termini.
Intanto occorre che gli anziani la smettano di considerarsi solo degli ex. Passi che gli altri li considerino tali, ma loro dovrebbero evitare di annegare nella nostalgia e nel rimpianto. Ai più giovani che snobbano gli anziani in quanto ex si dovrebbe dire che tutti noi crescendo diventiamo ex di qualcosa o di qualcuno. Qualunque sia la nostra età, infatti, siamo ex: ex embrioni, ex feti... Proprio quest’ultimo esempio dovrebbe farci riflettere. Il bambino molto piccolo non si preoccupa di essere un ex perché nel suo ambiente non c’è nulla che glielo faccia pesare. E più avanti, quando cresciuto è in grado di avere nostalgie e rimpianti, di solito nessuno lo accusa di essere un ex, anzi lo si spinge in avanti, verso il futuro, con messaggi che non insistono nel fargli rimpiangere la sua condizione precedente. Le cose vanno più o meno così per gran parte della giovinezza, finché un giorno ci accorgeremo di essere diventati degli ex per tanti. E da vecchi? Se non abbiamo potere, di qualunque tipo, ma soprattutto se non avremo coltivato ideali, sogni, progetti che ci aprano prospettive, se non avremo imparato ad apprezzare ogni tappa della nostra esistenza senza nutrirci solo di rimpianti, chi ci eviterà di essere definitivamente bollati come ex e di sentirci tali?
Lo scrittore David Grossman nel suo racconto Il duello parla della profonda amicizia tra un dodicenne, David, e un settantenne, Rosenthal. David una sera capisce “d’improvviso” che anche il vecchio Rosenthal "un tempo è stato giovane, ha amato, ha avuto amici e ragazze e alle feste, quando ballava con la sua Edith, era sicuro che il mondo fosse stato creato esclusivamente per lui".
E la mente di David, che talvolta si sente scoppiare di vitalità e allegria, è attraversata da un pensiero semplice e illuminante: verrà un giorno in cui i miei figli e i miei nipoti non riusciranno a immaginarsi che io sia stato così giovane ed entusiasta; già, perché “gli occhi della nostra infanzia conoscono quel che solo alla fine della nostra vita avremo il coraggio di vedere”.
Ricordo un antico lamento: ah, se i vecchi potessero e i giovani sapessero! Il fatto che sia antico non implica che sia del tutto sensato, perché in poche parole condensa un gran numero di pregiudizi sulla vecchiaia e sulla giovinezza. Pregiudizi di cui si nutrono giovani e anziani e che presentano la vecchiaia come l’età dell’impotenza e la giovinezza come quella dell’ignoranza. Su queste basi non c’è possibilità di dialogo e la stessa convivenza si presenta difficile. Ecco allora che nel tentativo di smentirli qualche giovane per dimostrare a se stesso e agli altri di “saperla lunga” si spinge fino all’arroganza e alla saccenteria. A sua volta qualche anziano tenta di confutare lo stereotipo del vecchio debole e in fase calante tentando di dar prove di potenza a se stesso e ai più giovani, spingendosi talvolta oltre i limiti propri e quelli del ridicolo. Non è così che si avvia un dialogo fertile tra generazioni. Il confronto va tentato tra esseri umani autentici e non tra maschere. L’amicizia tra David e Rosenthal si è formata nel tempo, frequentandosi in un clima non competitivo e alla lunga ha dato i suoi frutti: l’uno, l’anziano, ha ricordato la propria infanzia, l’altro, il ragazzo, è riuscito a immaginare se stesso da vecchio.
Da qualche tempo stiamo assistendo a un crescendo di attenzione dei mass media sulla condizione degli anziani. Dovrei esserne lieto, ma mi sembra di cogliere in gran parte degli interventi e nel risalto dato a certe notizie il permanere dei consueti pregiudizi e stereotipi. Oggi come ieri l’anziano “fa notizia” per alcune straordinarie imprese di singoli. Un tempo era Charlie Chaplin divenuto padre in tarda età, adesso è Glenn, protagonista ancora una volta di uno spettacolare viaggio spaziale. Abbondano i commenti in chiave trionfalistica del tipo “non è mai troppo tardi”, si esaltano alcuni vecchi eccezionali assurti a modello per tutti gli anziani del pianeta... Io continuo a pensare che dovremmo occuparci di più degli anziani “normali”, quelli che non compariranno mai in prima pagina ma che fanno parte del panorama della nostra esistenza quotidiana. Continuo a credere che sia difficile invecchiare bene quando le condizioni economiche e di salute non ci consentono di ricavare il meglio dalla nostra vita. Il meglio è trovare un senso alla nostra giornata, avere un’esistenza fertile, cioè ricca di sogni, progetti, ideali, fino all’ultimo minuto di vita. Il meglio consiste anche nell’alleviare le fatiche del vivere di coloro che invecchiano soli, malati, poveri. Il meglio è preparare responsabilmente la nostra vecchiaia quando siamo giovani, contribuendo a modificare il clima di negazione, cinismo e indifferenza che rende penosa la vecchiaia degli anziani di oggi e di domani.
Quali vantaggi crede che potrebbero trarre i giovani da una relazione più stretta con gli anziani, dedicando loro tempo e attenzioni?
Non basta un rispetto di facciata, assicurando loro vitto e alloggio estraniati in maxistrutture senza alcuna identità culturale né affettiva e coinvolgendoli in attività prive di costrutto per le quali userei il termine “passatempo” nel significato peggiore, quello di tirar sera non avendo altro di meglio da fare. Rispettare gli anziani significa assicurar loro una “vita reale” nei luoghi dove sono vissuti, dove ci sono i loro affetti e ricordi, dove possono svolgere qualche attività che abbia un senso. Ma, discutendo di questi temi in giro per l’Italia, sempre più mi vado convincendo che sono gli anziani stessi — organizzati o meno — che devono proporre e premere perché le loro proposte vengano realizzate, non aspettando che qualcosa giunga dall’alto come concessione. Nulla di ciò che veramente conta e impariamo ad amare arriva, ripeto, senza fatica e impegno. Rispetto, affetto, attenzione, giustizia molto spesso non sono doni ma conquiste. Lo sanno bene gli anziani, che hanno conosciuto tempi in cui molti dei diritti che oggi sembrano pacificamente garantiti erano invece negati ai più, come i diritti elettorali, quelli sindacali, l’istruzione, e tanto, tanto altro ancora.
Il distacco tra vecchi e giovani comporta in effetti anche un vero e proprio buco di memoria. Molti ragazzi non possono più contare sui racconti degli anziani, testimoni di un’epoca non lontana in cui molto di ciò che oggi appare assodato e scontato era invece oggetto di dura lotta. La scuola dovrebbe essere il luogo nel quale questo ponte tra presente e passato, tra cronaca e storia, potrebbe essere percorso da insegnanti e allievi. Ma spesso le istituzioni educative si sottraggono a questo compito e lo studente, tornato a casa, non trova quasi mai un nonno o una nonna che gli trasmetta l’esperienza delle generazioni passate, né può contare troppo su adulti che abbiano tempo, sensibilità o voglia di affrontare tali questioni. Non è bello né sano vivere come se ogni giorno fosse il primo giorno del mondo. Dobbiamo tornare a colmare questo vuoto se vogliamo avere un futuro come individui e come collettività. Dobbiamo tornare a ridare senso e dignità a tutte le età della nostra vita, dall’infanzia alla vecchiaia. L’identità ci viene da una storia. In mancanza di una storia troveremo qualche fragile identità d’accatto, ci legheremo al carro delle identità altrui.
Quale può essere il ruolo della “generazione di mezzo” nel trasmettere ai giovani il rispetto per la vecchiaia?
La “generazione di mezzo” è il problema. I bambini e i ragazzi entreranno a farvi parte, gli anziani l’hanno lasciata, ma tutti noi ci siamo sentiti dire che questa è l’età della vita in cui si vedrà ciò che veramente siamo e quanto valiamo. Con quest’immagine della vita in testa non si va lontano, perché l’infanzia e l’adolescenza diventano una fase preparatoria (non-ancora-adulti) e l’anzianità un fine corsa (non-più-adulti). La vita dovrebbe invece essere considerata preziosa e fertile dal primo all’ultimo secondo dell’esistenza. Non è un caso che l’adulto perda la memoria della propria infanzia e della propria gioventù, che spesso rinnega perché incompatibili con le esigenze di serietà e impegno che l’età di mezzo richiede. Non è un caso che l’adulto tema ed esorcizzi la vecchiaia, alla quale non riconosce altro contenuto che non sia un lento avvicinarsi verso la fine della vita. Quale messaggio stiamo dando ai ragazzi quando nei fatti insegniamo loro che l’unica età che conta è quella collocata tra l’infanzia e la vecchiaia? Il passato della nostra vita individuale, secondo questa prospettiva, sarebbe solo una preparazione all’età adulta, mentre il nostro futuro solo un decadimento fisico e mentale. Gli esseri umani passerebbero quindi da una condizione di non-ancora adulti né attivi a quella di non-più adulti né attivi, con una sopravvalutazione dell’età di mezzo a tutto discapito delle altre età. Io dunque non mi aspetto molto dall’età di mezzo per affrontare e risolvere i problemi degli anziani: al massimo un po’ di umana comprensione, se non di pietà, per alleviare paternalisticamente le loro pene. Molto di meglio mi attendo invece dall’iniziativa degli anziani stessi in collaborazione con — ma se necessario anche contro — l’età di mezzo, affinché sia chiaro che il sempre più lungo periodo che a questa succede, cioè l’anzianità, è una fase della vita degna di essere vissuta pienamente, lottando e amando, senza attendere la carità di nessuno.
Nel suo libro si trovano spesso spunti, suggerimenti, sogni di progetti d’intervento nelle città. Come giudica l’attuale situazione italiana riguardo alle iniziative che intendono stimolare il dialogo tra generazioni?
Il tema della condizione degli anziani sembra estraneo al dibattito politico e non figura in molti programmi elettorali, se si eccettuano vaghi accenni. In Danimarca hanno rivolto ai cittadini una domanda molto semplice: preferisci invecchiare e morire in una casa o in un ospizio? In casa, ha risposto l’85% dei danesi. Ed ecco la risposta a questa richiesta dei cittadini: nella sola Copenaghen ci sono ben 26.000 case in cui convivono giovani e anziani.
Non è che in Italia non si faccia nulla. A Parma un cittadino benemerito che si occupa da anni dei più deboli tra noi, Mario Tommasini, ha messo a punto il progetto “Esperidi”, che prevede la creazione di condomini in cui possono convivere generazioni distanti, giovani e anziani. Nella sintesi che Chierici fa di questo progetto si può leggere: portinerie speciali per i non autosufficienti; operatori sanitari 24 ore su 24; appartamenti da comprare o affittare in quartieri normali, mescolando età diverse, in città dove chi è malato soltanto di vecchiaia può continuare a sentirsi e a essere considerato una persona, dove i piccoli negozi e i cinema vengono riaperti, dove si ampliano gli spazi verdi per anziani e bambini.
Già, qualcuno dirà, belle idee: ma i soldi dove li troviamo? Rispondo che, come hanno fatto in Danimarca e altrove, si tratta di fare delle scelte. Gran parte degli investimenti oggi sono fatti avendo in mente una popolazione adulta, attiva, autosufficiente, molto mobile e in grado di sopportare cambiamenti ambientali e culturali di grande portata, una popolazione non più bambina e non ancora anziana, che ha dimenticato le necessità dell’infanzia ed esorcizza il pensiero dell’invecchiamento. Una popolazione smemorata e perlopiù miope, che crede che il periodo che sta attraversando duri in eterno e soprattutto non capisce che la caduta dei valori, le tensioni sociali e l’impotenza delle istituzioni educative hanno radici, in buona parte, in questa indifferenza nei confronti delle condizioni di vita dei più giovani e dei più vecchi. Occuparsi attivamente di bambini e anziani significa comunicare a tutti un concetto di grande importanza: la vita umana è preziosa dal primo all’ultimo istante della nostra esistenza. Non bastano le parole per trasmettere questo messaggio, occorrono fatti e scelte. Investire per migliorare le condizioni della convivenza urbana non è una scelta come un’altra. Questi investimenti producono interessi altissimi in termini di pacificazione delle relazioni fra i cittadini, di serenità individuale, di rispetto reciproco, di voglia di vivere, d’impegnarsi, di progettare e sognare.
Alla base di quest’utopia ragionata che tende a trasformare i centri urbani e a renderli meno ostili nei confronti dei cittadini più fragili c’è, credo, il concetto di “familiarità”, cioè quella confidenza che ci deriva dalla consuetudine e dalla dimestichezza con un ambiente che abbiamo avuto il tempo di esplorare e conoscere e nei confronti del quale abbiamo stabilito relazioni anche affettive. Il bisogno di familiarizzarsi è evidente nei bambini, che prima di spingersi a esplorare il nuovo hanno necessità di una base sicura da cui partire e a cui, nel caso, ritornare. Ma anche negli anziani rinasce prepotente, con il passare degli anni, questa spinta a legarsi a ciò che è familiare e, proprio per questo, rassicurante. Chi non è più giovane e non ancora vecchio si avventura spesso senza timori in terreni nuovi e inesplorati, è più propenso ad accettare il cambiamento, crede addirittura si possa e debba vivere senza troppi legami di cuore e di cervello. Ma non è così per gli anziani, i quali non amano i cambiamenti repentini che non consentono loro il tempo di familiarizzarsi.
Questo non vuol dire che bambini e anziani siano nemici del nuovo. Tutt’altro. Sono attenti, curiosi e avidi di novità come ogni essere umano sano. Essi però avvertono l’esigenza di rendere familiare questo nuovo — per sentirlo come proprio o respingerlo perché estraneo ai loro bisogni — e hanno il diritto d’impiegare tutto il tempo necessario a soddisfarla.