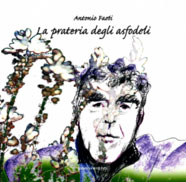copertina di Grazia Nidasio
Bologna, Bononia University Press, 2010, 307 p.
ISBN 9788873955122 - Euro 35,00
Dopo tanti anni dedicati allo studio dei grandi libri della letteratura per l’infanzia, l’autore ha interamente ricomposto lo scaffale che conteneva i primi libri amati da bambino. Non ci sono i classici della letteratura per l’infanzia, in questo elenco, mancano in esso tutti i libri famosi, gli autori glorificati da interpretazioni prestigiose. Ma la rilettura di questi romanzi per bambini, nascosti, scomparsi, perduti ha offerto una grande sorpresa: smarriti dalla memoria collettiva, Zio Floflò, Cocomero e Cetriolo, L’amba selvaggia e trenta altri volumi sono apparsi intensi, evocativi, struggenti, comici, sapienti. Una rilettura commossa di libri molto belli e molto dimenticati.
L'autore
Antonio Faeti, nato a Bologna nel 1939, ha insegnato sedici anni nella scuola elementare, venticinque all’università, otto all’accademia di belle arti. Da tre anni tiene il corso annuale di Pedagogia della lettura, voluto dalla Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna. Dopo Palomares, Bologna, 1967, e Guardare le figure, Torino, 1972, è giunto, con La prateria degli asfodeli, al suo trentacinquesimo libro.
La recensione
LA LETTERATURA E' SOGNO GUIDATO
di Teresa Buongiorno
(una versione più breve della recensione è pubblicata sul n. 88 di LiBeR)
Nel 1967, dopo otto anni di ruolo nella scuola elementare, interessandosi della Pop Art e delle icone della cultura popolare, da ritrovare attraverso le tradizioni iconografiche legate al mondo dell'infanzia, Antonio Faeti tornò ai libri amati da bambino, scoprendo che vi figuravano soprattutto testi minori, ormai dimenticati. Comprese allora che per studiare la letteratura per l'infanzia bisognava tener conto non solo della dimensione del classico, ma anche di quella del privato. E qualche anno più tardi, concluso quel suo Guardare le figure (Einaudi, 1972) che lo impose all'attenzione internazionale, si propose di ritrovare le proprie letture infantili per soppesarne il senso: “Del loro mistero, cioè della loro non decifrata capacità di influenzare, di formare, di caratterizzare, ero in certo senso preoccupato”.
Soltanto oggi, con l'esperienza di una vita e di una carriera, ha tirato le fila, rileggendo ogni libro, confrontando il bambino che è in lui con il vecchio professore che da tanti anni studia e insegna storia della letteratura per l'infanzia, prendendo in esame ricordi di altri sul tema, passando da Steinbeck a Stevenson, da Henry James ad Arturo Carlo Jemolo, da Ardengo Soffici a Franco Cordelli, a Gian Franco Vené. E conclude: “Sono tante le ragioni che inducono a cercare e a proporre una pedagogia della lettura, ma l'estasi di un possibile ritrovamento è di grande importanza per la vita, per un senso lieto della crescita e del mutamento... Il rapporto con una biblioteca che si ricompone cercando e rileggendo i testi che è impossibile dimenticare si fonda sulla contraddizione, sa che la letteratura è sogno guidato, come dice Borges”.
Così è nata questa autobiografia molto particolare, che ricostruisce le tappe del formarsi di una mappa concettuale nella mente di un bambino attraverso i libri. Un testo di cui non si potrà più fare a meno, perché apre prospettive inedite e fondamentali nel panorama della cultura dell'infanzia. Il piccolo Dante di Gherardo Ugolini è stato il primo libro: era l'estate del 1944, Antonio aveva cinque anni e imparò a leggere sotto la guida di un gruppo di giovani SS, accampate nel podere del nonno. Gli facevano compitare l'alfabeto su una loro rivista di guerra, “Signal”, molto illustrata. Erano pagine piene di soldati, carri armati, cannoni: parole e immagini, un binomio di cui non si sarebbe più liberato, che darà alle sue interpretazioni un sapore speciale.
L'accostamento ai classici attraverso le riduzioni, da tanti contestate, gli si rivela nella memoria come una scelta che produce grandi vantaggi, ai quali non si può rinunciare: “Si offre, per esempio, l'opportunità di entrare molto presto in contatto con grandi paradigmi, si porgono splendidi esempi, che spostano l'attenzione dalla miserabile cronachetta di oggi, giornalistica o televisiva. Si consente di stabilire un confronto, sempre nobile o rilevante, tra sé, i propri pensieri, le paure e gli ardimenti, e quelle vicende così alte, sperimentate per secoli e per millenni. Si conserva almeno un rito di iniziazione, entro una cultura che li ha perduti tutti”.
Molti i titoli della sua prima biblioteca. Alcuni fondamentali, come I racconti wagneriani di Elena Primicerio. Antonio li lesse con la sorellina Fioretta, più piccola di due anni, compagno segreto, socio e alleato: “Fu un libro tutto nostro, senza nessuna mediazione adulta”. A leggerle oggi, quelle fiabe wagneriane “così limpidamente ridotte a una essenzialità fascinosa”, si potrebbe credere che la Primicerio conoscesse Propp e ne seguisse la lezione, dice. E' del tutto impossibile, ma negli scrittori per l'infanzia che, come lei, come Gherardo Ugolini, come Laura Orvieto, volevano salvare il Mito raccontandolo ai bambini, si avverte comunque una ricerca della struttura che è portata avanti con sapiente determinazione”. Libro ambiguo, libro oscuro, libro perfino pericoloso: ma libri così, osserva, sono “indispensabili a una crescita vera, sono contrari al protrarsi di un peterpanismo che conduce alle notti del sabato, quelle delle morti giovani”.
Gelsomino Lanciainresta di Mino Doletti, riletto oggi, si apparenta a Tournier, che considera il rifacimento come una forma d'invenzione, “anzi come la sola vera invenzione a cui si possa pensare”. Giornalista di mestiere, critico cinematografico in anticipo sui tempi, autore di romanzi e libri di viaggio, impegnato nelle imprese pedagogiche del regime, fondatore dell'AICRET, l'Associazione Italiana dei Critici di Radio e Televisione, Doletti riprende Collodi e De Amicis per dar vita a un personaggio nuovo, che vive in un contesto diverso, un lazzaroncello che non rinuncia a combinare malefatte, ma non passa mai la misura: “sembra di essere di fronte a una metafisica della monelleria”.
Altri titoli: le Novelline divertenti per bambini intelligenti di Alfredo Panzini, un autore che ha avuto una presenza significativa nell'Italia del suo tempo, poi incredibilmente scomparso: “più che dimenticato, quasi censurato, nascosto”. O le Favole d'oggi di Emilia Villoresi, “l'opera consapevolmente creata da una persona colta, d'animo libero, fiera delle proprie convinzioni educative, che ha voluto, con successo, cimentarsi in un impresa rischiosa, complicata”: l'aggiornamento del fiabesco, la ricerca di nuovi temi che si potessero inserire nella morfologia consegnata da una millenaria tradizione, “una donna che volle nelle sue fiabe le muse inquietanti della cultura europea”. Non a caso la Villoresi ha firmato la la traduzione dell'intero ciclo di Bibi di Karin Michaelis, (e ha scritto di suo pugno persino un settimo volume in cui Bibi si sposa, pubblicato da A.Vallardi nel 1953, molto criticato).
Di Giuseppe Fanciulli troviamo L'omino turchino, disegnato da una bambina su una cartolina e poi ritagliato, e Lisa-Betta, una bambina per bene che entrò nell'immaginario adolescente anche dei maschi, che ufficialmente allora si interessavano soltanto di eroi di guerra, di cowboy, di gangster. “C'erano, in questo scrittore così attento ai cambiamenti, intenti pedagogici molto diversi da quelli espressi nel tempo” annota Faeti. “Colpisce fortemente il distacco così netto, così severo, così limpido, di Lisa-Betta e del suo mondo, dagli accadimenti pubblici, dalle icone rilevanti, dai grandi simboli, dai sogni collettivi messi in evidenza dai media di allora: la radio, il cinema, le copertine della Domenica del Corriere”.
E poi Yambo, con il suo Capitan Fanfara che trovò posto negli anni Sessanta nella nuova collana Einaudi Ragazzi: un autore “ che si rese sospetto a certi maestri per la frenesia verbale delle sue pagine e la briosa impudenza delle sue tavole disegnate”, ma “soprattutto sempre e davvero un autentico giornalista, che amava il suo lavoro e non lo dimenticava anche mentre scriveva per ragazzi”. Un attenzione particolare per Tommaso Landolfi, uno dei più sofisticati scrittori del secondo Novecento, autore del Principe infelice: la “fiaba delle fiabe” nella percezione bambina di Faeti, che adulto ne ritrova intatto il fascino e rimpiange che non sia stato salvato, come il Piccolo Principe, come il Piccolo Lord.
E poi Olga Visentini, Salgari, Collodi Nipote, Camilla Del Soldato, Vamba con Ciondolino. Impossibile citarli tutti. Ricordo ancora Pina Ballario con Le fiabe dei monti di corallo, le leggende delle Dolomiti, che tutti conosciamo attraverso Wolff, per Faeti troppo serioso. E Nizza e Morbelli con i Quattro moschettieri e 2 anni dopo, “libri creati per un pubblico adulto, più o meno lo stesso che aveva seguito con entusiasmo massmediologico il programma radiofonico da cui essi scaturivano e collezionato le famose figurine che la Perugina aveva creato per dar luogo a una campagna pubblicitaria multimediale ancora in grado di stupire per la variegata ampiezza dei messi usati e per la coerenza con cui essi potevano collegarsi tra loro”. E' sopratutto nei libri che la proposta da artistica diventa pedagogica e ha una capacità molto aggressiva di combattere ciò che appare molesto, negativo, inibente: è “un grande itinerario nella cartografia delle finzioni occidentali, attraverso generi, autori, tipologie narrative. Se la derisione, il ribaltamento parodico, la contaminazione, l'abbassamento carnevalizzante sembrano essere il fondamento del viaggio, occorre invece tener conto di qualcosa che è meno evidente e meno esibito”: la grande poetica degli eroi affascina gli autori “e loro sanno bene che nei sogni collettivi forse solo la parodia consente ormai di mostrare affetto, attenzione, voglia di capire davvero”.
Non manca lo Scaffale Proibito, con i libri trafugati ai fratelli più grandi, e dove figurano anche i fumetti, allora mal giudicati dagli adulti, e il “Grand Hotel” regno del gossip, dove pulsava la vita. Infine La prateria degli asfodeli, di Alba Cinzia, forse il più amato, da cui Faeti prende il suo titolo: “un volumetto per bambini in cui si parla solo di Morte, un testo che guarda a una tanatologia sapiente, ispirata, piena di finezza. E io ero orfano di madre, ed ero stato spettatore di tanti lutti, perché il Fronte, il temutissimo Fronte... era venuto a collocarsi proprio nel piccolo paese dove io ero sfollato, proprio per non incontrarlo mai”. L'autrice ricava dai testi greci una veglia funebre e di essa riempie interamente il suo libretto: è morto un bambino, il padre disperato domanda, riflette, discute, accoglie pensieri... come farà suo figlio ad attraversare la prateria degli asfodeli che, dopo le due porte dei sogni, conduce direttamente al regno dei morti? “Che cos'è la morte se non l'altro volto della vita?” dice pacatamente l'autrice. “Tutto perisce e tutto risorge...”
In appendice, le illustrazioni dei libri ricordati e una scheda su ogni volume. Da rimarcare la sapienza grafica di Lucia Bottegaro, che per ogni capitolo mostra in trasparenza la pagina scritta a mano dall'autore e ne riprende il titolo: un'accortezza sottile per stabilirne la presenza in queste pagine. Bellissima la copertina di Grazia Nidasio, grande maestra.