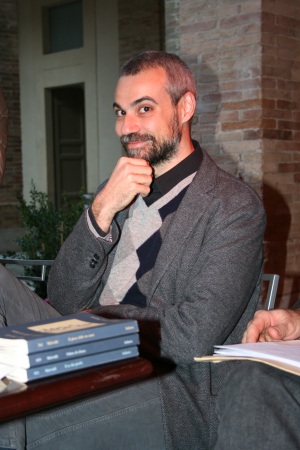Marco Malvaldi, chimico e scrittore, è autore di una fortunata serie di “gialletti”, come ama ironicamente definirli, che ruotano attorno alle vicende di un detective, matematico di formazione e barista per scelta, e degli anziani avventori del suo locale, il BarLume. Lo abbiamo raggiunto, tra una presentazione e l’altra del suo ultimo successo Odore di Chiuso, dove Pellegrino Artusi, da fine osservatore e profondo conoscitore di reazioni e combinazioni alimentari, gioca un ruolo di primo piano nella risoluzione di un delitto.
Cosa rappresenta per lei la chimica? Come ha avuto inizio la sua passione verso questa scienza?
Da bambino, mi interessavano tutte le scienze esatte. Non avevo, invece, nessuna passione per le scienze biologiche e la medicina, che nella mia povera testa di bimbo reputavo delle stregonerie. Al liceo, leggendo un libro sulla vita di Charles Goodyear, rimasi folgorato dal fatto che le proprietà meccaniche della gomma dipendevano dalla forma particolare delle macromolecole, e che l'elasticità di una macromolecola era la conseguenza della seconda legge della termodinamica. Siccome ero e rimango affascinato dagli oggetti in gomma (so che detta così può dare adito a strani pensieri, per cui è bene specificare che mi riferisco principalmente ai pneumatici e alle superfici delle racchette da ping pong) e dalle loro proprietà uniche, decisi che avrei studiato chimica. C'è anche un secondo fatto: al liceo ho avuto un’ottima professoressa di fisica e di matematica, mentre quella di chimica era pessima. Quindi, ignoravo cosa fosse la chimica, e mi sembrava giunto il momento di rimediare.
Come è pervenuto alla scrittura di gialli?
Ho cominciato a scrivere per noia, mentre facevo la tesi di laurea. Io sono un chimico teorico, e la mia tesi si è svolta in una tristissima stanza del dipartimento di chimica dell'Università di Pisa, che è già brutto di suo. Il mio lavoro consisteva nella scrittura di un codice di calcolo per un particolare processo fotochimico, e nel suo utilizzo. Ora, questi calcoli avevano dei tempi biblici, per me: duravano ore, o anche giorni. Avevo moltissimi tempi morti, e durante queste pause ho scritto il mio primo romanzo, La briscola in cinque. Non avevo intenzione di pubblicarlo, era solo un modo come un altro per non andare fuori di cervello.
Esiste una relazione, un parallelismo tra il procedimento di Malvaldi scrittore di libri gialli e il metodo di indagine di un chimico?
No, non direi. I miei gialli sono di tipo induttivo: da un piccolo particolare, una nota stonata, si ricostruisce pian piano l'intera sequenza degli eventi. Il metodo di indagine chimico è principalmente di tipo sistematico: si procede come dei bulldozer, si fanno prove apparentemente inutili e non si lascia nulla di intentato, al fine di stabilire con certezza che cosa si ha davanti. Direi che l'analisi chimica assomiglia più ai gialli tipo police procedural, come quelli di Ed McBain. Quello che ti dà forza e fiducia, nell'analisi chimica, è l'affidabilità e la solidità del metodo, non l'intuizione.
Più in generale, esistono dei nessi tra chimica e letteratura? Mi viene in mente un grande scrittore come Primo Levi, oppure penso alla fascinazione che la chimica ha esercitato su Oliver Sacks bambino così ben raccontata in Zio Tungsteno, ricordi di un’infanzia chimica.
Un nesso, a mio parere, c'è. A parte la quantità di tempi morti che la chimica fornisce a chi la pratica (si pensi a quanto tempo uno può passare a distillare), c'è il fatto che un buon chimico è necessariamente qualcuno in grado di descrivere. Deve descrivere colori, odori, gesti, mettere in risalto possibili errori. Il tutto nel modo più efficace possibile, perché chi ti legge dovrà capire quello che hai fatto, e possibilmente essere in grado di riprodurlo, se lo volesse. E deve essere conciso: quello che hai scritto con tre frasi, può essere sempre detto con due. In altre parole, scrivere un lavoro scientifico è una grande scuola di scrittura, che ti insegna a scrivere in modo chiaro, essenziale e coerente. Il rischio è quello di diventare pedanti, ma per quello ci sono gli editor.
(da LiBeR 91)